ANNO IV – numero 1 – gennaio 2026
- MILANO CORTINA 2026 di Alessandro Bocci
- PROVE DI DEMOCRAZIA NEL SALOTTO DI JÁN ALBRECHT di Libera Iannetta
- LA BABELE DELL’INCONSCIO: LINGUA MADRE E LINGUA STRANIERA NELLA PRATICA ANALITICA di Nurgul Cokgezici
- STORIE E LEGGENDE DEL SEMPIONE di Giorgio Righetti
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 18 di Fabio Fumagalli
- GOING THE DISTANCE di Giacomo Pio Augello
- GENTE DE LA RIPA di Giorgio Righetti
- IL RITORNO DI AGAPÈ: MILANO, INIZIO D’ANNO di Maria Mihaela Barbieru
- URLA DALLA TERRA di Giorgio Righetti
- LA CANZONE DEL MAGGIO di Aurora Marella
ANNO III – numero 12 – dicembre 2025
- BUON NATALE di Nurgul Cokgezici
- SCINTILLE DI CAPODANNO di Giorgio Righetti
- FIND YOUR CENTER di Giacomo Pio Augello
- IL SENSO DELLA PAROLA “ATTESA” di Aurora Marella
- L’ALBERO DEI DESIDERI DI AGÀPE – UNA STORIA DI SPERANZA di Maria Mihaela Barbieru
- DAL BUCO DELLA SERRATURA di Luigi Filipetto
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 17 di Fabio Fumagalli
- QUANDO A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 11 – novembre 2025
- GRAZIE, OCCIDENTE di Alessandro Bocci
- TEMPO CHE FU. I CANTASTORIE di Giorgio Righetti
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.16 di Fabio Fumagalli
- AGÀPE – CRONACA DI UN CAMBIAMENTO MAGICO E CONSAPEVOLE di Maria Mihaela Barbieru
- ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO di Giacomo Pio Augello
- UNA STORIA CHE CONOSCIAMO TUTTI, O FORSE NON LA CONOSCIAMO TUTTA:LA STORIA DELLE PANCHINE ROSSE di Aurora Marella
- IL PANETTONE MILANESE di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 10 – ottobre 2025
- UNA FLEBILE SPERANZA di Alessandro Bocci
- IL FAMEDIO DI MILANO TRA CURIOSITÀ E LEGGENDE di Giorgio Righetti
- CHI DECIDE COSA È GIUSTO E COSA È SBAGLIATO? LE MIE DUE CULTURE E LA PAURA DEL DIVERSO di Nurgul Cokgezii
- CENERE, ACQUA E DIGNITÀ: IL LAVORO DEI LAVANDAI NELLA VECCHIA MILANO di Angelo De Cristofaro
- C’ERANO UNA VOLTA LE SCOPE di Luigi Filipetto
- ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA di Giacomo Pio Augello
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.15 di Fabio Fumagalli
- I FEEL FOOD
- EL DONDINA. UN PERSONAGGIO AVVOLTO DAL MISTERO di Giorgio Righetti
- LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 9 – settembre 2025
- IL TEMPO DELL’ODIO di Alessandro Bocci
- SUL FRECCIAROSSA CON FANON: QUANDO IL COLONIALISMO RISUONA IN BUSINESS CLASS di Nurgul Cokgezici
- CATTANEO E MILANO: ECONOMIA, LIBERTA’ E LA LEZIONE CHE PARLA AL PRESENTE di Emanuela Maritato
- MISURARE SE’ STESSO E MISURARSI CON SE’ STESSO di Giacomo Pio Augello
- A MALEZZA di Angelo De Cristofaro
- MILANO E “EL PRET DE RATANÀ”: QUANDO LA LEGGENDA SUPERA LA REALTÀ di Giorgio Righetti
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 14 di Fabio Fumagalli
- ACCADE IN VIA PORPORA
- FAUSTO AMODEI di Aurora Marella
- LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 7/8 – luglio/agosto 2025
- SEMPRE PIÙ SPESSO di Alessandro Bocci
- L’ESPRESSIONE TRANSCULTURALE DEL LUTTO: IL DOLORE CORPOREO NEL RITUALE LURI E CURDO di Nurgul Cokgezici
- TEMPO CHE FU. GIOVANOTTI IN CAMERA! di Giorgio Righetti
- A 19 ANNI VIVO COSÌ di Luigi Filipetto
- EVENTI LOCALI CHE FANNO CULTURA: IL CASO DI GRAZZANO BADOGLIO di Teresa Tardia
- LA CHIAVE DEL SUCCESSO di Giacomo Pio Augello
- LOUISE MICHEL di Aurora Marella
- CHI NON LO RICORDA A MILANO di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 6 – giugno 2025
- LA MEMORIA OSCURATA: PERCHÉ L’ITALIA E L’EUROPA DEVONO ASCOLTARE LA VOCE DEI CURDI di Nurgul Cokgezici
- UN’EUROPA FEDERALE, UN SOGNO O UN FUTURO DOVEROSO? di Slobodan Fazlagic
- IL BORGO DEGLI ORTOLANI di Giorgio Righetti
- DELLA MANCATA INCLUSIONE di Antonella Rizzo
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 12 di Fabio Fumagalli
- SOLA di Maria Teresa Zumbo
- LA PIÙ UNIVERSALE DELLE DOMANDE di Giacomo Pio Augello
- CRISTIANI PER IL SOCIALISMO. UNA VAMPATA di Luigi Filipetto
- IL DONO – UNA LETTERA DA MAESTRO A MAESTRO di Angelo e Gloriana De Cristofaro
- LEGGENDE DEL DESERTO AMERICANO di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 5 – maggio 2025
- LORENA ASANAVICIUTE di Alessandro Bocci
- UN VIAGGIO NELLA MILANO DI IERI: LA LIGERA di Giorgio Righetti
- IL VUOTO DELL’UMANO: TRA DESIDERIO, SICUREZZA E SPERANZA di Nurgul Cokgezici
- QUESTA È UNA STORIA DI CANTIERE E DI MARE di Angelo De Cristofaro
- RIVALUTAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ di Giacomo Pio Augello
- CULTURA, IDEE E CORAGGIO A PRATO di Teresa Tardia
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 11 di Fabio Fumagalli
- IL TIVOLI UNA VERA CUCCAGNA PER I TAGLIABORSE di Giorgio Righetti
- IPAZIA di Aurora Marella
- LA PICCOLA PARTIGIANA di Luigi Filipetto
ANNO III – numero 4 – aprile 2025
- FRANCESCO di Alessandro Bocci
- “ORA E SEMPRE RESISTENZA” di Giorgio Righetti
- IL FISCO ITALIANO AD APRILE 2025: NOVITÀ E IMPATTI DELLA LEGGE DI BILANCIO di Emanuela Maritato
- L’OMBRA CHE CI ABITA. UNA RIFLESSIONE SULLA NATURA UMANA, IL NARCISISMO È L’URGENZA DI RICONOSCERE IL MALE IN NOI di Nurgul Cokgezici
- NUOVO SPETTACOLO 2025 !!!! di Fabio Fumagalli
- SE MIO FRATELLO DEVE MORIRE MORIRÒ CON LUI di Luigi Filipetto
- UNA GUERRA PER LA PROTEZIONE DELL’ESISTENZA. RIFLESSIONE SULLA LOTTA CURDA, SUL SUO LEADER, SU QUANTO CIRCOLA di Aurora Marella
- IL RISORGIMENTO ITALIANO AL FEMMINILE di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 3 – marzo 2025
- PIAZZA EUROPA
- LE RELAZIONI OGGI: UN PROGETTO, NON UN VINCOLO ETERNO
- IN GIRO PER LA VECCHIA AFFORI
- O MIA BELA MADUNINA
- LA FORZA DELL’OTTIMISMO
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 9
- UNIONE EUROPEA: L’INCOMPIUTA DA COMPIERE
- CHI È NUDO: LO ZAR O IL KING?
ANNO III – numero 2 – febbraio 2025
- PACE NON SOTTOMISSIONE di Alessandro Bocci
- LEGGENDO BARICCO di Libera Iannetta
- I-TECH INNOVATION DELL’OPIFICIO GOLINELLI: DALL’IDEA AL SUCCESSO di Teresa Tardia
- IL DOLORE COME STRUMENTO DI CRESCITA: UN NUOVO SGUARDO SUL BENESSERE E LA CONSAPEVOLEZZA di Nurgul Cokgezici
- LEGGENDE E STORIE DI MILANO – “TIREMM INNANZ” di Giorgio Righetti
- UNA MOSTRA DA NON PERDERE
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 8 di Fabio Fumagalli
- IO NON SONO RAZZISTA, MA… di Luigi Filipetto
- LEGGENDE E STORIE DI MILANO – EL TREDESIN DE MARZ di Giorgio Righetti
ANNO III – numero 1 – gennaio 2025
- IL DECLINO EUROPEO di Alessandro Bocci
- PARROCI NEL TERZO MILLENNIO a cura di Luigi Filipetto
- L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI): SFIDE ED OPPORTUNITÀ NELLA NUOVA PROFESSIONE di Emanuela Maritato
- IL RUOLO DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE: QUANDO LE DONNE COSTRUISCONO IL FUTURO DELL’INTEGRAZIONE di Nurgul Cokgezici
- LEGGENDE E STORIE MILANESI. 3 FEBBRAIO. IL PANETTONE DI SAN BIAGIO di Giorgio Righetti
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 7 di Fabio Fumagalli
- LEGGENDE E STORIE MILANESI. I TRII DI DE LA MERLA 29, 30, 31 GENNAIO di Giorgio Righetti
ANNO II – numero 12 – dicembre 2024
- IL DISCORSO ALLA CITTÀ di Alessandro Bocci
- IL 27 GENNAIO 1901 MORIVA GIUSEPPE VERDI di Giorgio Righetti
- FACCIAMO UNA STRAGE? a cura di Luigi Filipetto
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 6 di Fabio Fumagalli
- I SACCHETTARI di Aurora Marella
- LA SCHIAVITÙ È UNO STATO DI GUERRA. IL CAPITANO BROWN di Giorgio Righetti
ANNO II – numero 11 – novembre 2024
- “JEANS GENERATION O VOLARE VIA DALL’URSS” di Viktoriia Lapa
- DA SIMONE DE BEAUVOIR AD OGGI: UNO SGUARDO SULL’ESSERE DONNA di Melissa Idonia
- I RITARDI NEI PAGAMENTI DEI SUPPLENTI BREVI NELLA SCUOLA: UNA QUESTIONE IRRISOLTA di Francesco Maraia
- LA (QUASI) SCOMPARSA DEL PATRIARCATO di Rachele Grillo
- INCONTRI RAVVICINATI DI TERZO TIPO a cura di Luigi Filipetto
- DONNA, VITA, LIBERTÀ: LA REPRESSIONE DELLO SLOGAN CHE INCARNA LA LOTTA DELLE DONNE di Nurgul Cokgezici
- SCUOLA DI MILANESE – PONTÈLL nr. 5 di Fabio Fumagalli
- UGUALMENTE ARTISTI di Aurora Marella
- NATALE A MILANO di Giorgio Righetti
ANNO II – numero 10 – ottobre 2024
- ALCIDE DE GASPERI di Alessandro Bocci
- PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI di Emanuela Maritato
- GIUSY SALA: UNA MAMMA CORAGGIO di Francesco Maraia
- GOVEND (HALAY): LA DANZA CURDA COME ESPRESSIONE DI UNITÀ E MEDITAZIONE COLLETTIVA di Nurgul Cokgezici
- PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ E MANTENERE IN EQUILIBRIO IL SISTEMA di Teresa Tadia
- IL FASCINO DELLA TRADIZIONE: LA FIERA DEGLI “OH BEJ, OH BEJ” di Giorgio Righetti
- SPETTACOLO 2024!!!! di Fabio Fumagalli
- SANITÀ DI STRADA a cura di Luigi Filipetto
- MUSICA SUI PIANEROTTOLI…E NON SOLO di Aurora Marella
ANNO II – numero 9 – settembre 2024
- IUS SCHOLAE di Alessandro Bocci
- LA SACRALITÀ DELLA DONNA NEL KURDISTAN: UN FARO DI CONOSCENZA E RESISTENZA di Nurgul Cokgezici
- LA NAVE E I SUOI AMICI di Aurora Marella
- AVVOCATO SÌ, MA ANCHE ALTRO a cura di Luigi Filipetto
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 3 di Fabio Fumagalli
- UNA STORIA RACCAPRICCIANTE. LA COLONNA INFAME di Giorgio Righetti
- GLORFINDEL, L’EROE DIMENTICATO di Luca Dragani
- “DONA VITA, DONA SANGUE” di Kateryna Semenchuk
- A BOLOGNA I GRAFOLOGI IN AZIONE DAL 27 AL 29 SETTEMBRE di Teresa Tadia
ANNO II – numeri 7/8 – luglio/agosto 2024
- NON SOLO SATNAM di Alessandro Bocci
- DALLA VERDE IRPINIA ALLA VIA DELLA SETA, IL VIAGGIO DI LEO di Francesco Maraia
- TURANDOT, L’INCOMPIUTA di Libera Iannetta
- CONSERVATORISMO – ALLA RICERCA DISPERATA DI UNA VIA D’USCITA… di Slobodan Fazlagic
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 2 di Fabio Fumagalli
- LA FABBRICA DELL’OLINDA. DA OSPEDALE PSICHIATRICO A CENTRO CULTURALE DI QUALITÀ di Luigi Filipetto
- IO CANTO LA CITTÀ a cura di Luigi Filipetto
- LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MUSICA MODERNA: OPPORTUNITÀ O DECADENZA? di Giorgio Caporale
- ESISTONO GLI ZOMBIE? A QUANTO PARE SÌ, E SONO PURE DROGATI di Carmine Pizzino
ANNO II – numero 6 – giugno 2024
- IL SACERDOTE DEGLI OPERAI di Alessandro Bocci
- DIRITTI UMANITARI E DIRITTO PENALE di Milena Ruffini
- ATMI/ATMIYAN di Nurgul Cokgezici
- LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE di Libera Iannetta
- SBARRE DI ZUCCHERO. QUANDO IL CARCERE È DONNA IN UN MONDO DI UOMINI di Aurora Marella
- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr.1 di Fabio Fumagalli
- LA DOMENICA IN ALBIS di Luigi Filipetto
- SCAPIGLIATURA CHE MODA! di Giorgio Righetti
ANNO II – numero 5 – maggio 2024
- LA CASA COMUNE EUROPEA di Alessandro Bocci
- LA SOLIDARIETÀ di Giorgio Righetti
- COMPLESSO ARCHITETTONICO DI VIA ASTESANI 39-45, MILANO. LE RAGIONI PER UNA TUTELA di Maurizio Boriani e Fulvia Premoli
- VOLARE SULLA MOTO: UNA TERAPIA FUORI DALLE RIGHE di Aurora Marella
- L’INFLUENZA TRASFORMATIVA DELLA MUSICA NEL SOCIALE: UN VIAGGIO NEL TEMPO di Giorgio Caporale
- I LUPI NELLA MAFIA di Carmine Pizzino
- TRANQUILLO CREMONA E IL TEMPO DELLA SCAPIGLIATURA di Giorgio Righetti
- QUEGLI ANNI E LA MORTE INTORNO di Luigi Filipetto
ANNO II – numero 4 – aprile 2024
- FINALE DI PARTITA di Alessandro Bocci
- STUDIARE MUSICA NEI CONSERVATORI vs CRESCERE PER STRADA: UN CONFRONTO GENERAZIONALE di Giorgio Caporale
- IL GENE DEL SERIAL KILLER: REALTÀ O IRREALTÀ? di Carmine Pizzino
- UN QUARTO… NON UN BUON AFFARE di Slobodan Fazlagic
- IL DISCORSO DI SCURATI SUL 25 APRILE E LA CENSURA RAI di Francesco Maraia
- CONVIVENZA DI QUARTIERE di Luigi Filipetto
- “EL TOMBON DE SAN MARC” di Giorgio Righetti
- LA STAZIONE CENTRALE DI JR di Giulia Farinella
- PIC PRONTO INTERVENTO CLOWN di Aurora Marella
- IL METEOROLOGO DI SARAJEVO – di Libera Iannetta e Slobodan Fazlagic di Simona Dolci
ANNO II – numero 3 – marzo 2024
- TRICKLE DOWN ECONOMICS di Alessandro Bocci
- LA DIASPORA KURDA IN ITALIA di Nurgul Cokgezici
- SUL CONCETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA di Melissa Idonia
- LA CONVERGENZA TRA MUSICISTI E INFLUENCER: QUANDO IL PALCOSCENICO SI TRASFORMA IN UN FEED DIGITALE di Giorgio Caporale
- MOLCE ATELIER, STORIE DI RINASCITA di Aurora Marella
- “TREDESIN DE MARZ”. SAN BARNABA E I TREDICI SEGNI di Giorgio Righetti
- ECOCIDIO IN UCRAINA: A RIMETTERCI SARÀ TUTTO IL PIANETA di Olga Boiko
ANNO II – numero 2 – febbraio 2024
- CARLO DONAT-CATTIN di Alessandro Bocci
- LE BELLE STORIE CI CATTURANO di Libera Iannetta
- “20 GIORNI A MARIUPOL” di Olga Boiko
- IN VIAGGIO VERSO LA LIBERTÀ: IL VIAGGIO DI ROGER di Milena Ruffini
- VIVERE PERICOLOSAMENTE… LAVORARE A SCUOLA di Slobodan Fazlagic
- PRECARI DELLA SCUOLA, LA MAGISTRATURA È CON VOI! di Francesco Maraia
- SANREMO: LA SFIDA DI RITROVARE LA GRANDEZZA MUSICALE NELL’ERA DELLO SPETTACOLO di Giorgio Caporale
- BREVE STORIA DI UN TEATRO COMUNE di Aurora Marella
ANNO II – numero 1 – gennaio 2024
- L’INVERNO DEMOGRAFICO di Alessandro Bocci
- È ARRIVATO IL TEMPO DI PENSARE AL TEMPO? di Slobodan Fazlagic
- IL TEMPO, ETERNAMENTE GALANTUOMO di Andrea Martelli
- LA FORZA DELLA PAROLA di Libera Iannetta
- I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE di Alessia Perazzo
- UN METRO SOPRA LE NUVOLE: BAD BUNNY di Andrea Bevilacqua
ANNO I – numero 3 – dicembre 2023
- LA SFIDA DI ELLY di Alessandro Bocci
- BUON NATALE A CHI SOFFRE, A CHI LOTTA E A CHI SPERA di Francesco Maraia
- LA PRIMA SCALIGERA E IL MITO VERDIANO di Libera Iannetta
- STORIA DI UNA MEDIATRICE CULTURALE di Nurgul Cokgezici
- IL FEMMINICIDIO È UN PROBLEMA SOCIALE di Kateryna Semenchuk
- AFFIDO ETERO FAMILIARE: UN LEGAME OLTRE LA LEGGE di Milena Ruffini
- BOSNIA OGGI: COS’ABBIAMO IMPARATO? di Slobodan Fazlagic
- IL MITO CONTINUA: L’IMPATTO DURATURO DEI BEATLES SULLA MUSICA MODERNA di Giorgio Caporale
- COACH SKINNY: PLAYERS CLUB ’23 di Andrea Bevilacqua
ANNO I – numero 2 – novembre 2023
- ARTICOLO 34 di Alessandro Bocci
- QUANTO È PERICOLOSO ESSERE DONNA NEL 2023? di Alessia Perazzo
- MILANO CANTIERE VERDE di Francesco Maraia
- IL RISULTATO È DAVVERO L’UNICA COSA CHE CONTA? di Andrea Martelli
- STORIA DI UNA VITA DISTRUTTA di Kateryna Semenchuk
- LA CONVENZIONE DI ISTANBUL di Nurgul Cokgezici
ANNO I – numero 1 – ottobre 2023
- A PROPOSITO DI NOI… di Alessandro Bocci
- CRONACA DI UN RIENTRO A CASA SOTTO I BOMBARDAMENTI di Kateryna Semenchuk
- L’UOMO CURIOSO È L’UOMO VINCENTE di Barbara Ciccone
- UN NUOVO CASO “MAHSA AMINI” di Nurgul Cokgezici
- IL MODELLO MILANO di Francesco Maraia
MILANO CORTINA 2026

di Alessandro Bocci
Ormai ci siamo. Accesa a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma Olimpica è sempre più vicina e con la partecipazione di 92 nazioni la terza edizione dei Giochi invernali ospitata in Italia inizierà fra qualche giorno.
Secondo le stime elaborate da Banca Ifis, i Giochi, che prevedono 116 competizioni in 16 differenti discipline sportive, avranno un impatto economico positivo pari a 5,3 miliardi di euro. Una cifra da suddividersi fra spesa immediata sul territorio (1,1 miliardi), spesa differita nei successivi 12 mesi (1,2 miliardi) e heritage infrastrutturale, cioè il patrimonio di lungo periodo costituito dagli impianti sportivi, rigenerazione urbana e miglioramenti delle reti viarie ( 3 miliardi). I Giochi sono una manifestazione capace di attrarre 2,5 milioni di visitatori da tutto il mondo, interessati a tutto ciò, programmi culturali, enogastronomia, shopping, che il territorio offre. L’Olimpiade culturale che affianca i Giochi ha appunto la finalità di valorizzare il patrimonio del territorio ospitante.
Al termine dei Giochi si apriranno le Paralimpiadi, un’occasione unica per promuovere le tematiche relative all’inclusione e che saranno il trampolino di lancio di investimenti finalizzati a rendere più accessibili metropolitane e ferrovie.
Milano Cortina 2026 rappresenta dunque una fonte di ispirazione per chi pratica attività sportive, fornisce un’immagine positiva dell’Italia all’estero ed è una grande occasione di crescita per le città coinvolte. Senza lasciare indietro nessuno, Milano deve continuare a correre e a rafforzare il suo ruolo, dopo Londra e Parigi, di terza metropoli europea per rango. In questo senso è lecito aspettarsi che tutti, amministrazione regionale e comunale, società pubbliche e private, società civile, siano all’altezza del loro ruolo.

PROVE DI DEMOCRAZIA NEL SALOTTO DI JÁN ALBRECHT

di Libera Iannetta
Incontro Igor Valentovič dell’Albrecht Forum nella tarda mattinata del 16 gennaio, in una Bratislava innevata e silenziosa, presso la casa di via Kapitulská, appartenuta al musicologo Ján Albrecht (Bratislava, 1919-1996). Igor è il presidente dell’associazione che ha rilevato e ristrutturato la casa con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro in cui trovino posto permanente musica classica, letteratura, pittura, teatro, cinema, filosofia, scienze sociali, nel solco della tradizione inaugurata dal musicologo bratislavese.
Quella di Albrecht è stata una figura di spicco nel panorama culturale della Slovacchia. Musicologo, violinista, docente presso l’Università Comenius, l’Accademia di Arti Performative, il Conservatorio di Bratislava, fondatore dell’Early Music Movement nel paese, un movimento musicale che si concentra sulla musica colta composta in Europa tra il Medioevo e il Rinascimento, fino a includere la musica del XVII e della prima metà del XVIII secolo. Le esecuzioni si basano su una ricerca musicologica che attinge alle fonti originali e vengono realizzate su strumenti musicali storici.
Quando la nuova direzione dell’Accademia delle Arti Performative non si mostrò più interessata a mantenere la materia opzionale “Musica Antica”, Albrecht accolse i suoi studenti nella casa di via Kapitulská, nel centro storico della città, dietro la cattedrale di St. Martin. Da questa esperienza trasse origine, nel 1973, “Musica aeterna”, il primo ensemble dedicato alla musica antica in Slovacchia, per quanto riguarda la programmazione e le professionalità coinvolte. La casa era nota in città come luogo di ritrovo per persone provenienti dal mondo della musica, della letteratura, delle arti visive, della filosofia. Tutti avevano accesso alla ricca biblioteca del proprietario, anche in sua assenza, in un clima di umanità e tolleranza per le diversità. Il Maestro suonava musica da camera con amici e studenti. Se qualcuno arrivava con un violino, un flauto, lui tirava fuori uno spartito dalle sue centinaia di titoli e suonava, anche tutta la notte. Nel suo salotto si esercitava l’ascolto, il dialogo, il rispetto.
Igor Valentovič, fondatore con sua moglie di una casa editrice musicale, ha conosciuto personalmente Ján Albrecht, in quanto loro redattore per diversi titoli. Con docenti, musicologi, musicisti e grazie al sostegno di donatori, ha rilevato, nel 2010, la casa ormai in rovina. Mi mostra il salotto arredato com’era in origine, la biblioteca in cui sono confluite anche numerose pubblicazioni della sua casa editrice, la sala di cinquanta posti in cui troneggia un pianoforte a coda. I membri dell’associazione vorrebbero ristrutturare la soffitta e creare uno spazio per un caffè al pianterreno. Il cortile innevato è piuttosto ampio. Vi è installata una pedana in quanto, in estate, si fa musica all’aperto. La struttura, infatti, ospita concerti, tavole rotonde, un festival giunto alla sesta edizione, con programmi in cui trovano spazio anche opere di musica da camera, raramente eseguite, di compositori slovacchi. Mentre scatto qualche foto, mi sembra di vederlo il Prof. Albrecht mentre aspira dalla sua immancabile pipa, accogliente e gentile. Mi offre tè e biscotti preparati dalla zia, poi mi invita a sedermi e a suonare con lui. Ringrazio Igor Valentovič e, insieme, ci avviamo all’uscita.
Il clima culturale che si respirava in casa Albrecht, fin dagli inizi degli anni Settanta, anticipa la Rivoluzione di Velluto del 1989, quale momento cruciale nella storia europea, simbolo della transizione pacifica verso la democrazia e dell’aspirazione del popolo slovacco alla libertà e ai diritti civili.

LA BABELE DELL’INCONSCIO: LINGUA MADRE E LINGUA STRANIERA NELLA PRATICA ANALITICA

di Nurgul Cokgezici
Introduzione
L’analisi con chi parla più lingue solleva questioni particolari. Non si tratta semplicemente di tradurre parole. Ogni idioma porta con sé vissuti, modi di sentire e ricordi legati a persone specifiche. Nella propria lingua madre, certe emozioni emergono con maggiore intensità. Parlare invece in una lingua appresa successivamente genera una sensazione diversa: meno coinvolgimento immediato, più controllo oppure una sorta di protezione. Le cose dette in una lingua piuttosto che nell’altra non pesano allo stesso modo.
La lingua madre come veicolo dell’inconscio
Fin dalle prime parole sentite in casa, ogni suono ha un peso particolare nel cuore. Quando si parla con il terapeuta, certe frasi emergono in modi che tradiscono vecchie ferite nascoste. A volte basta uno sbaglio di grammatica per aprire una porta chiusa da anni. Usare la lingua madre – non imparata ma vissuta – fa emergere sensazioni autentiche, mai smussate dal tempo. Emozioni che restano mute se costrette in vocaboli appresi dopo i dieci anni.
La lingua straniera: distanza e difesa
Parlare in una lingua non propria può creare un filtro tra le emozioni intense. Chi soffre potrebbe scegliere questa modalità per contenere ricordi dolorosi. Usarla aiuta a reggere il peso interiore, ma permette anche di esplorare parti nascoste di sé senza eccessiva paura. Di contro, certi stati d’animo restano appena accennati, poco sciolti. Questo richiede all’analista uno sforzo maggiore nel cogliere ciò che rimane in ombra.
La babele dell’inconscio: dinamiche analitiche
Ogni volta che il paziente passa dalla lingua madre a quella straniera, lo spazio della terapia cambia pelle. Non sono solo le parole a contare, ma anche gli intervalli tra esse, i mutismi improvvisi, il modo in cui alcune forme emergono soltanto in un idioma e mai nell’altro. L’ascolto deve abbracciare ciò che resta sospeso, trattenuto, nascosto nel timbro o nella cadenza. Le decisioni sul quando parlare e in quale lingua non nascono a caso: dentro ci sono lotte profonde su chi essere e dove appartenere.
Ciò che emerge è un campo vivo, denso di significati incrociati, dove cultura, trauma e desiderio si intrecciano senza tradursi completamente. L’analista osserva con attenzione minuziosa questi segnali, come se ogni cambio di registro fosse una mappa non dichiarata. Niente va dato per scontato; neppure il respiro prima di un verbo in inglese invece che in italiano.
Implicazioni cliniche
Parlare nella lingua madre aiuta spesso a toccare emozioni nascoste. Usare una seconda lingua crea, invece, una distanza più sicura. Chi conduce la seduta dovrebbe osservare come queste due modalità si muovono nel percorso terapeutico. Non sempre è chiaro quale delle due sia più utile in un dato momento.
Lingua che parli, chi sei. A volte ci si sente stranieri dentro, specialmente se si proviene da lontano o si è cresciuti tra due culture diverse. Durante la seduta, ogni scelta di parole modifica il clima tra paziente e terapeuta. Basta un tono diverso a cambiare tutto. Il modo in cui qualcuno pronuncia una frase può rivelare tensioni nascoste. Ogni silenzio pesa quanto una dichiarazione esplicita. Chi ascolta deve prestare attenzione anche a ciò che non viene detto ad alta voce.
Conclusione
Nel lavoro psicoanalitico, la confusione dei linguaggi nell’inconscio diventa una risorsa. Parlare tra lingua madre e seconda lingua mostra con chiarezza come una persona sente, cosa pensa della propria origine e dove si riconosce. Quando lo specialista coglie le differenze nel modo di esprimersi, seguendo accenti o scelte insolite di parole, riesce a comprendere meglio il mondo interno del soggetto. Questo aiuta il paziente a capire sé stesso più profondamente, a ricomporre parti distanti dell’animo e a sentirsi meno spezzato.

STORIE E LEGGENDE DEL SEMPIONE

di Giorgio Righetti
“PER LA FABBRICA DELL’APPETITO”. Il vecchio fachiro mangiafuoco “il Mario” con questa frase cercava di suscitare la simpatia e benevolenza del pubblico. I suoi ferri del mestiere consistevano in rompere catene, ingoiare sassolini e vetri ed esercizi col fuoco. Con un solo pugno secco e preciso, il Mario piantava un lungo chiodo in un asse di legno, e poi una buona bevuta di petrolio da spruzzare su una torcia accesa, dove la fiamma andava in alto componendo forme strane e paurose. Ma il repertorio non si esauriva qui, il pezzo forte doveva ancora arrivare, era la rottura delle catene, dove la faccia del Mario assumeva orrendi connotati di una maschera di dolore. Ma infine le catene si rompevano e con la frase:
“Buona salute e buona fortuna!…
Grassie, siore, siori e siorinne!…
Al vostro buon cuore.
Per la fabbrica dell’appetito.
La cena quella sera era assicurata. Il Mario lo si poteva vedere un po’ dappertutto, ma il più delle volte preparava la sua piccola ribalta a ridosso del CASTELLO, o all’ACQUA MARCIA, al PARCO SEMPIONE, dove soleva dare il suo spettacolo, erano quelli i suoi posti preferiti dove arrivava sempre in bicicletta seguito da un gruppo festante di ragazzini.
LA SORGENTE DI ACQUA SOLFOROSA AL PARCO SEMPIONE. Cinquanta, sessant’anni fa e anche molto prima ci si andava di giorno e di notte a bere l’acqua marcia, a riempire fiaschi e bottiglie, era un po’ l’acqua di chi credeva nei miracoli che potevano fare solo le acque naturali, di chi pur avendo molti disturbi o malanni diffidava dei medici, delle medicine, dei farmacisti e, si curava a modo suo a questa fonte solforosa dove era bello andare, dove si faceva anche comunità e si ritrovava un po’ l’anima di Milano. La sorgente di acqua solforosa inaugurata al parco nel 1925 era una fonte di gioia, a quel tempo sembrava che Milano dovesse diventare una città termale ci si recava felici alla fonte a riempire un fiasco o qualche bottiglia, il Parco si sarebbe prestato benissimo ad accogliere chioschi, pergolati e orchestre. All’acqua marcia era quasi sempre presente il Mario, e la banda del Tirazza che divertiva i presenti con la sua musica. Era stata composta per l’occasione anche una simpatica canzoncina.
“Anche Lei mio caro duca qui alla fonte? – Le dirò mio caro conte – Me ne son successe tante – Che devo proprio disintossicarmi un po’…”.
Ma stiamo parlando di certi momenti che ci riportano a una Milano dai tempi delle favole. Da tempo ormai la fontana dell’ACQUA MARCIA è stata asciugata, era stato messo un cartello che ammoniva: ACQUA NON POTABILE. Mi dicono che ora dalla fonte zampilla acqua potabile, ma non più solforosa.
Nella foto del 1950, il Mario in una delle sue esibizioni.
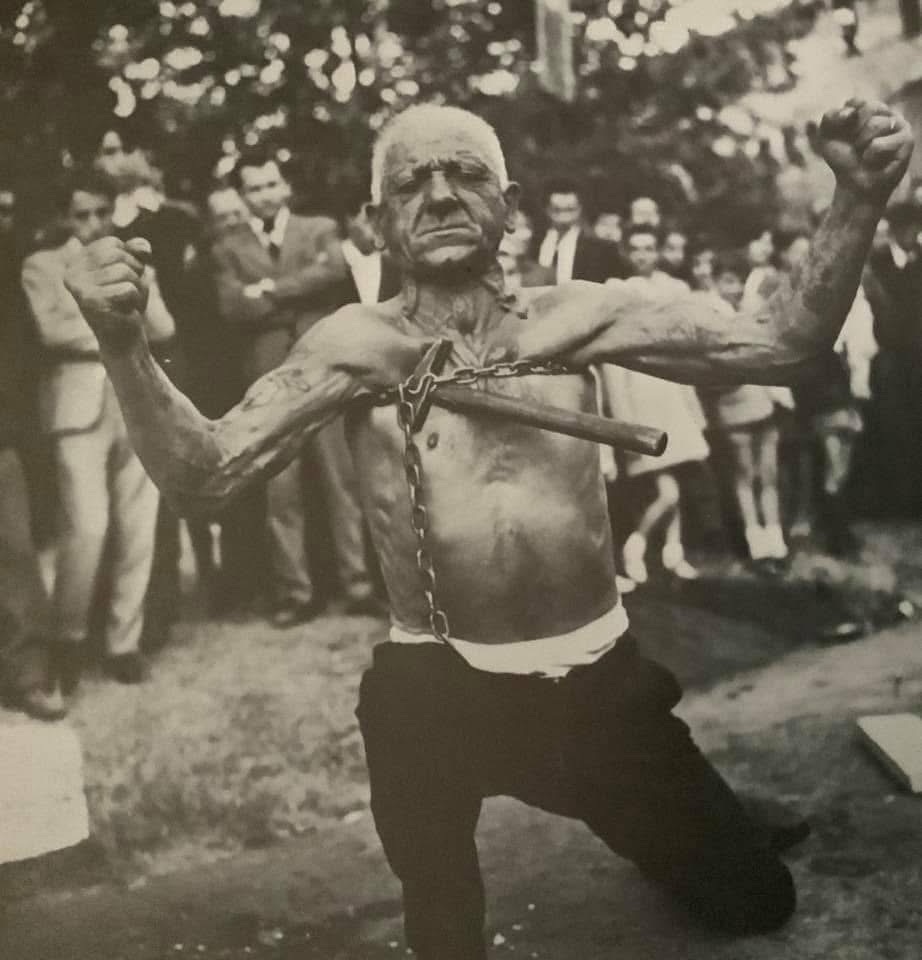
SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 18

di Fabio Fumagalli
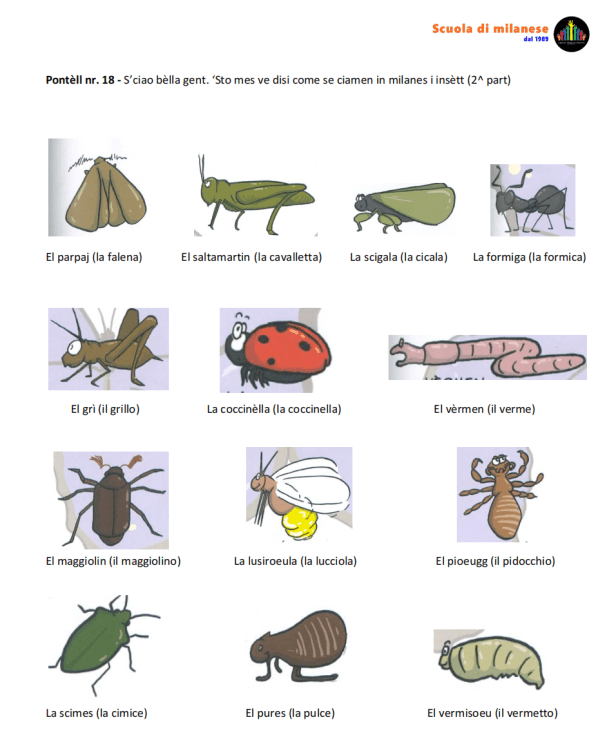

GOING THE DISTANCE

di Giacomo Pio Augello
Ben ritrovati!
Spero abbiate trascorso bene le Feste quanto me.
Per cominciare l’anno nel migliore dei modi, partiamo subito con il concetto che gli anglosassoni usano per dire: “Ce la posso fare!”.
Nell’ultimo numero (allego qui il link per chi non ha ancora potuto leggerlo https://nuovecronache23.com/2025/12/31/find-your-center/), abbiamo parlato dell’equilibrio e ci eravamo lasciati con una domanda scomoda: “Si può cadere?”
La risposta lo è ancora di più: SI.
Perché?
Perché cadere è naturale.
Noi siamo esseri vulnerabili.
Il nostro corpo alla stanchezza.
La nostra mente al dubbio.
Il nostro animo alla comodità.
L’ambiente in cui viviamo può pesare su di noi fino a farci cadere.
Ma cadere vuol dire perdere?
E perdere significa anche fallire?
Non necessariamente.
Cadere, perdere e fallire, anche se spesso coincidono, non sono sinonimi.
Tuttavia, è molto facile confonderli.
Per capire bene queste differenze dobbiamo chiamare come ospite un personaggio d’eccezione.
Il suo nome?
Rocky Balboa.
Concepito da Silvester Stallone nel 1975, è divenuto l’incarnazione stessa della resilienza.
All’inizio della storia, però, non è un eroe.
Al contrario, è un pugile svogliato che non sfrutta il suo talento perché si accontenta di quello che ha già, per quanto poco.
E’ come un tronco che si lascia placidamente trasportare dalla corrente apatica di una realtà che non offre nulla se non un presente di miseria.
Ciò nonostante, non è un fallito.
Perché?
Perché, quando ha l’occasione della vita, l’incontro con Apollo Creed, Rocky rivela il tratto caratteristico della sua vera natura: volontà ferrea.
Sa benissimo di non avere la minima possibilità contro il campione del mondo dei pesi massimi (“Non ce la faccio. Non lo posso battere. Ma chi mi credo di essere? Io non ho la sua classe.”).
Eppure, non gli importa di perdere.
Perché l’unica cosa che vuole fare è resistere (Going the distance,appunto) fino all’ultimo gong.
E ce la fa.
Durante l’incontro è dominato da Apollo.
E’ pesto, sofferente, guercio.
Ma quando finalmente suona la campana del quindicesimo round, lui è ancora lì, in piedi.
Ciò che il campione si trova davanti, quindi, non è un avversario comune, ma un muro di resilienza contro i cui i suoi colpi sono destinati a infrangersi, senza riuscire ad abbatterlo.
Qualcuno, però, deve pur vincere l’incontro.
E i giudici decidono ai punti a favore di Apollo.
Rocky, dunque, non è un fallito perché, anche se ha perso un incontro, ha comunque raggiunto il suo obiettivo.
Che cosa ci insegna questa storia?
Che perdere è qualcosa che può succedere.
Ma non è, di per sé, un fallimento.
Ciò che rende una sconfitta un fallimento è solo il rifiuto di volersi rialzare e riprovare.
Perché?
Perché rialzarsi è un atto della nostra volontà che grida all’Universo: Io non mi arrendo!
E questo dipende solo da noi.
Siamo noi i responsabili della nostra sorte dopo che cadiamo.
Questa è la grande differenza tra un vincente e un perdente.
Perché il perdente è chi dà la colpa delle sue sconfitte a tutti gli altri, tranne che a sé stesso.
Io, lo confesso, mi sono sentito tante volte un po’ come Rocky.
Non partivo da una base di vantaggio e dovevo conquistarmi ogni gradino a lacrime e sangue.
La resilienza è sempre stato il mio superpotere (visto che, a breve, dovrebbe arrivare il salvifico “Avengers Doomsday” mi adeguo al trend).
Non sono stati rari i momenti in cui avrei desiderato avere qualche qualità in più, per sentire meno il peso della fatica.
Quando approdai alla scuola marziale che frequento tutt’ora, il mio insegnante seppe questi miei trascorsi e mi disse soltanto: “Tu pensa al tuo percorso”.
Quella semplice frase mi aiutò a compiere l’ultimo passo di un percorso che io, senza saperlo, avevo già iniziato.
Da quel giorno, smisi di paragonarmi agli altri e mi focalizzai solo su me stesso, non solo in palestra, ma in tutti i campi della mia vita.
E il mio percorso mi portò lungo un sentiero di cambiamenti che non avrei mai immaginato di potere affrontare.
Come è andata?
Lo scopriremo la prossima volta.
Buon inizio anno a tutti.
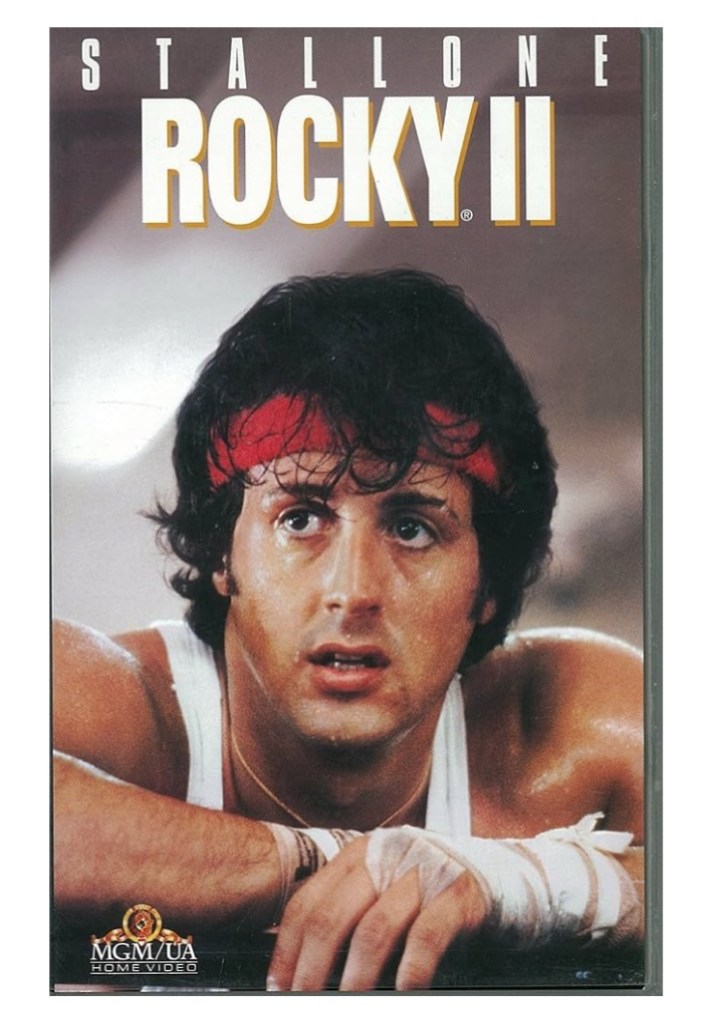
Nel prossimo numero: “La specie che sopravvive è quella che si adatta”. Guidati dalle parole di Charles Darwin faremo un viaggio che ci porterà a capire perché la chiave per la sopravvivenza è la capacità di adattamento.
GENTE DE LA RIPA

di Giorgio Righetti
IL “VICOLIN DI LAVANDEE”. Dei molti lavatoi della zona resta soltanto quello dell’ormai famoso “vicolin di lavandee” il primo a destra discendendo dall’Alzaia Naviglio Grande, il Vicolo mantiene ancora intatta l’immagine di una Vecchia Milano sconosciuta a molti dei suoi stessi abitanti. La “gente de la Ripa” come era chiamata esercitava professioni legate in qualche modo alla Darsena, barcaioli, carrettieri, scaricatori di sabbia, ma l’attività prevalente era quella del lavandaio. Il Vicolo dei Lavandai è oggi un luogo incantevole dove con la fantasia si può tornare indietro nel tempo e si può immaginare le lavandaie impegnate nel loro lavoro. Chi esercitava il lavoro erano soprattutto le operaie dei lavandai, un mestiere durissimo, soprattutto in inverno, chine sul “brellín”, una cassetta di legno a tre sponde con impugnatura, che le lavandaie portavano con sé e posavano dietro la “preja”, usata per sbattere la biancheria. In inverno le lavandaie non dimenticavano lo “scaldino” per le mani, un piccolo recipiente di latta riempito con carbone e brace e la “zaína” una bottiglietta capace di un poco di grappa, per difendersi dal gelo. E così in Inverno o in Estate con le artriti, le bronchiti, i geloni alle mani e ai piedi passava la loro vita. Queste donne non possono che richiamare la poesia di Giovanni Pascoli imparata a scuola tanto tempo fa, dal titolo “Lavandare”, appartenente alla prima raccolta, “Myricae”: “E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene….”. Su quella tavola di legno, appoggiata al mastello e pieno di acqua saponata e lisciva, era la consuetudine della “bugada”; (il bucato). In inverno senza un accogliente impianto di riscaldamento con il gelo, o in estate con il caldo torrido questo era l’impegno massacrante delle lavandaie, fatto di mani e di braccia, aveva la possibilità di rigenerare, come nuova, tutta la numerosa biancheria della famiglia. Erano gli impervi e travagliati sentieri del vivere quotidiano.

IL RITORNO DI AGAPÈ: MILANO, INIZIO D’ANNO

di Maria Mihaela Barbieru
Nel cuore di Milano, in un elegante edificio di vetro e acciaio, il gruppo di una società di consulenza stava rientrando al lavoro dopo la pausa natalizia. L’aria era densa di promesse non dette, buoni propositi scritti frettolosamente su agende nuove, e quella sottile ansia da ripartenza che solo gennaio sa portare.
Agapè, figura silenziosa e magnetica, fece il suo ingresso nella sede come consulente esterna per un percorso di riorganizzazione interna. Era speranzosa.
I giorni trascorsi nel suo villaggio natìo, tra le meraviglie silenziose della Cappadocia, le avevano riempito l’anima di calma e visioni ampie, come quei cieli tersi che sembrano non finire mai.
Non portava slide né grafici.
Portava invece un’agenda ancora da riempire, occhi pieni di ascolto e sorrisi sinceri.
E grinta, quella che nasce dalla terra rossa e antica, fatta di resilienza e storie tramandate.
Dalla Cappadocia aveva preso il gusto dell’essenziale e la profondità dei silenzi.
Quel giorno era pronta a seminare idee nuove nel cuore del lavoro quotidiano — con rispetto, presenza e coraggio.
Il team era affiatato ma sembrava stanco. I risultati dell’anno precedente erano buoni, ma si avvertiva un senso diffuso di disconnessione e frustrazione. «Lavoriamo tanto, ma non sappiamo più perché», sbuffò Carla, team leader, durante il primo incontro. «Abbiamo perso l’allineamento, come se ognuno andasse in direzioni diverse.» Eh già, direzioni diverse, non condivise…
Agapè propose allora un esercizio semplice. Avvicino altavolo della riunione una grande lavagna bianca e disse: «Scrivete un solo proposito professionale per questo nuovo anno. Non per l’azienda. Per voi.»
Ci fu silenzio. E ancor silenzio. Poi i colleghi, uno alla volta, si misero a scrivere:
– “Avere il coraggio di dire di no senza sentirmi in colpa.”
– “Imparare ad ascoltare senza voler rispondere subito.”
– “Prendermi il mio tempo, anche al lavoro, senza sentirmi inadeguata.”
– “Ritrovare entusiasmo nelle piccole cose.”
– “Essere chiaro con me stesso e con gli altri.”
Agapè osservò attentamente, poi aggiunse: «Questi non sono solo desideri. Sono semi. Ora serve il terreno giusto per farli crescere.»
Il suo sguardo attraversò la sala, posandosi sui volti dicolleghi assorti, presi dai ritmi frenetici di inizio anno. I buoni propositi scritti su post-it colorati, affissi alla lavagna come un grande albero condiviso, parlavano di ascolto, collaborazione, tempo per sé, chiarezza, coraggio.
«Un seme ha bisogno di tre cose per germogliare: spazio, cura e pazienza. E anche voi, come questi propositi, avete bisogno di ambienti che vi nutrono, di relazioni che vi rispettano, di leadership che sa fare spazio. Non dimenticatelo.»
Poi si voltò verso Carla, team leader da poco, che con uno sguardo tra il dubbioso e l’illuminato chiese: «E se il terreno fosse duro?»
Agapè sorrise. «Eh già…Allora bisogna lavorarlo. Insieme.»
E lì, nel cuore di quell’ufficio milanese ancora sonnolento dopo le vacanze, nacque l’idea di un percorso condiviso: non solo individuale, ma collettivo.
Un piccolo passo verso un nuovo modo di lavorare. Con radici e visione.
Nei giorni seguenti, lavorò con il gruppo sulla costruzione di rituali quotidiani di chiarezza: 10 minuti di allineamento mentale al mattino, uno spazio settimanale per feedback autentici, un patto di comunicazione empatica durante le riunioni. Non grandi rivoluzioni, ma piccoli gesti coerenti.
Il cambiamento fu visibile già dopo due settimane. Le tensioni si scioglievano più facilmente, le responsabilità erano più condivise. Qualcuno disse: «Mi sembra di lavorare con persone, non solo con ruoli.»
Prima di concludere il suo incarico, Agapè lasciò a ciascuno una domanda scritta a mano. Era diversa per ognuno.
1. Qual è la tua vera intenzione ogni volta che inizi una nuova giornata di lavoro?
2. Cosa stai trattenendo per paura del giudizio, e come influisce sulla tua efficacia nel gruppo?
3. In che modo il tuo contributo quotidiano riflette ciò che per te ha senso?
4. Quale limite personale puoi trasformare in risorsa in questo nuovo anno?
5. Che tipo di collega vuoi essere, anche quando sei sotto pressione?
Quando se ne andò, non salutò. Lasciò solo un biglietto sulla porta della sala riunioni:
“Le intenzioni non bastano. Ma sono il primo passo verso un lavoro che abbia anima.”
Firmato: Agapè.

URLA DALLA TERRA

di Giorgio Righetti
27 Gennaio. LA FORZA DELLA MEMORIA
CONTRO L’ORRORE DELLA SHOAH.
La principale impressione che mi è rimasta dalla mia visita nei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenao e Treblinka è stata un’impressione di morte come se quella signora aleggiasse ancora nell’aria. I campi di sterminio furono sei sparsi in tutta la Polonia e funzionarono dal 1941 al 1944. Erano campi di concentramento diversi dai molti lager di lavoro e di punizione o da quelli per prigionieri di guerra. Completamente privi di infrastrutture, se non camere a gas, forni crematori, abitazioni per le Ss, baracche per i prigionieri e una struttura per lo smistamento dei beni tolti alle vittime. Il loro scopo era quello di eliminare fisicamente il maggior numero di esseri umani, in prevalenza ebrei, ma anche zingari, omosessuali, asociali, disabili, testimoni di Geova e tutte le categorie giudicate dal nazismo sotto-uomini. Quattro di questi campi erano meri luoghi di sterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka. In pratica erano dei “terminal” ferroviari mimetizzati e nascosti dove fin dal loro arrivo, i deportati venivano condotti direttamente nelle camere a gas, per essere assassinati. Altri due campi Lublino-Majdanek e Auschwitz-Birkenau, all’inizio campi di concentramento per politici e di lavori forzati, all’interno dei quali in seguito vennero predisposti centri di sterminio con istallazione di camere a gas e annessi forni crematori. Così Claude Lanzmann nel suo libro SHOAH (dal cuore dell’inferno), descrive l’arrivo di un trasporto di ebrei ungheresi a Birkenao nel giugno del 1944. “In effetti si puo affermare che nessuno dei deportati è mai stato ad Auschwitz, perché coloro che vi sono stati deportati e che sono morti subito, in realtà, non hanno conosciuto Auschwitz, non hanno fatto in tempo a sapere ciò che era, e non hanno certo potuto vedere le fiamme e il fumo della loro stessa morte. Chi arrivava a Auschwitz e veniva gassato e ridotto in cenere entro due ore, moriva nella radicale incomprensione della propria morte”. Due precisazioni si rendono necessarie per comprendere meglio questa distinzione. Diversamente dai campi dì concentramento che servivano principalmente come campi di detenzione e lavoro, i campi di sterminio erano vere e proprie fabbriche della morte. Nei campi di concentramento o di lavori forzati vi furono praticate delle gassazioni saltuarie, nei campi di sterminio, conosciuti anche come (campi della morte) avvenne lo sterminio sistematico dei deportati con il gas in termini di assassinii di massa. In questi sei campi le SS e la polizia tedesca assassinarono quasi 2.700.000 esseri umani tramite l’uso di gas tossico.
IL DOTTOR MORTE. Tra le figure delle SS. evocate dai sopravvissuti di Auschwitz-Birkenau, ha lasciato un ricordo macabro quella del dottor Joseph Mengele, medico capo del campo. Scendendo dai carri piombati, uomini e donne, vecchie e giovani, con i neonati in braccio e i bambini più grandi per mano, scorgevano questo criminale nazista, noto per i suoi esperimenti sugli esseri umani, che soprintendeva alla selezione con un frustino in mano, Mengele designava le vittime con un gesto dell’indice, fischiettando un’aria della Tosca. Tra gli assassini di Auschwitz il più pericoloso era questo criminale fornito di poteri vastissimi. Nessuno dei vari esperimenti che si effettuavano a Auschwitz, erano così macabri come quelli effettuati da Mengele sui bambini e sui gemelli deportati nel campo. Mengele operava nel blocco numero 10 di Auschwitz, senza anestesia, mutilazioni e inoculazioni di batteri, castrazioni e congelamenti. Inoltre, sperimentò vari metodi di sterilizzazione di massa sulle donne ebree asportando loro l’utero o iniettandovi acidi corrosivi per renderle infeconde.
L’INFERNO DI TREBLINKA. Riporto qua sotto un passaggio del “Reportage dai campi”, uscito nel 1944 sulla rivista “Znamja” e firmato dal più popolare e seguito corrispondente di guerra dell’Armata Rossa Vasilij Grossman:
“Le SS infierirono ferocemente soprattutto sui ribelli del ghetto di Varsavia. Sceglievano donne e bambini e, invece di portarli alle camere a gas, li conducevano alle graticole. Li costringevano le madri impazzite per l’orrore a mostrare ai loro figli le griglie incandescenti dove, fra le fiamme fumo, i corpi si accartocciavano a migliaia, dove i morti parevano riprendere vita e contorcersi, dimenarsi, dove ai cadaveri delle donne incinte scoppiava il ventre e quei bambini morti ancor prima di nascere bruciavano fra le viscere delle madri. Certe scene avrebbero sconvolto la mente dei più temprati fra gli uomini, ma l’effetto era cento volte maggiore su quelle madri che con le mani tentavano di coprire gli occhi ai figli, e i tedeschi lo sapevano. “Mamma bruceranno anche noi, che cosa ci faranno?”, urlavano i bambini impazziti, correndo a stringersi a loro. E dopo essersi goduto il terribile spettacolo, i tedeschi li gettavano davvero tra le fiamme, i bambini.
Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda e, chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi, passi oltre, offende la memoria delle vittime. Chiunque rifiuta la verità non saprà mai contro quale nemico contro quale MOSTRO hanno combattuto fino alla morte le forze alleate.
Nella foto Auschwitz-Birkenao. Alle mie spalle all’entrata in alto, si intravede la scritta: “Arbeit macht frei”. “Il lavoro rende liberi”. Era la frase scritta che campeggiava all’ingresso dei lager nazisti. Un motto sadico e crudele che contrastava con la realta di morte dei campi dove furono sterminati milioni di uomini, donne e bambini innocenti.

LA CANZONE DEL MAGGIO

di Aurora Marella
In questi giorni freddi, di parabrezza ghiacciati, rumore di spatole sui vetri, giù in strada, alle 6.30 del mattino, aria di brina e mani rosse, di piante in attesa sui balconi e mai, mai un bucaneve pioniere, un canto, mille canti. La notte dell’11 gennaio, come a Capodanno, ha vibrato di voci. Milano e provincia costellate di piazze e circoli in canto. La penisola tutta con le stesse parole e lo stesso ritmo. Ritmo di Bocca di rosa, di La guerra di Piero, di Via del Campo, e Fiume Sand Creek.
Le “cantate anarchiche” hanno fermato il tempo per una notte e lo hanno riavvolto all’indietro e in avanti contemporaneamente per rivivere emozioni che non invecchiano e non passano. Restano e rinnovano, anno dopo anno e canto dopo canto.
Il mese di gennaio ricorda, tra le numerose sue evocazioni, il cantautore ligure Fabrizio De André. Il giorno 11, la sua dipartita da questo mondo, qui a Milano, avvenuta nel 1999. E il 18 febbraio si replicherà per ricordarne la nascita nel 1940 a Genova.
Preparandomi appunto per una delle tante cantate anarchiche, mi sono servita di motore di ricerca di canzoni in internet e ho cercato quelle più famose ed emblematiche del Genovese.
Una delle prime opere comparse sullo schermo è stato l’album Storia di un impiegato, anno di uscita 1973. E uno dei primi brani proposti nella lista di ascolto è stato la Canzone del maggio. Guardando bene accanto al titolo, lo stesso motore di ricerca presentava una nota tra parentesi che diceva (cit.): “liberamente tratta da un canto del maggio francese 1968”.
E così ho fatto una brevissima ricerca. Già conoscevo qualcosa a riguardo, ma ho approfondito la questione che vorrei condividere qui.
La Canzone del maggio che cantiamo a squarciagola si adatta perfettamente ad ogni epoca, anche odierna, purtroppo. Siamo sempre e da sempre in mezzo a proteste per le disparità sociali. Si potrebbe pensare sia stata scritta per noi negli anni Settanta.
Essa, invece, nasce per parlare delle proteste operaie francesi della fine degli anni Sessanta. La canzone originale è stata scritta dalla francese Dominique Grange. Si intitolava Chacun de vous est concerné. E parlava della rivolta della classe operaia e della coscienza di classe che andava sempre più rafforzandosi opponendosi alle disparità sociali. Sembra oggi, appunto, in altre parti, troppe, del mondo. Fabrizio De André ha potuto utilizzare il testo perché l’autrice aveva concesso i diritti di traduzione ma non ha utilizzato la trasposizione letterale francese perché nell’originale è presente la frase “Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo”. Questa frase esprime chiaramente le ineluttabilità dell’onda che si era ormai generata con le proteste e chi si opponeva non avrebbe mai potuto fermare la coscienza di classe, la nuova consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto ad un sistema non equo del trattamento lavorativo perpetuato dalla classe sociale dirigente. Ormai il vento era partito e avrebbe toccato tutti e ogni tempo e questo concetto nella canzone francese emerge e volava imponente nelle manifestazioni, negli slogan e negli striscioni dell’epoca nelle vie di Parigi e della Francia tutta.
Nella canzone di De Andrè non ci sono queste stesse parole ma sono sostituite da “Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”. Questa frase come quella francese travalica il tempo. Conferma le responsabilità del fare ma anche del non aver fatto nulla, di chi non ha parlato, per chi non ha impedito, per chi non ha collaborato verso la giustizia. Illumina qualcosa che cerca restare un po’ nell’ombra, l’atteggiamento del non sentirsi coinvolti direttamente nelle proteste dei lavoratori perché ci si sente salvi comunque, perché la propria situazione non è come quella di chi scende in piazza. E Fabrizio accende un occhio di bue su chi si gira dall’altra parte e resta nell’indifferenza.
Entrambe le versioni sono appassionate ed entrambe le ho sentite risuonare nelle diverse cantate anarchiche che hanno avuto luogo e tempo in questo mese di gennaio.
L’anno è iniziato così: con il ricordo di un evento passato accaduto 10 anni prima della mia nascita, con il canto e le parole e la memoria della voce calda del nostro cantautore, con l’idea che quelle parole abbiano senso oltre il tempo.

BUON NATALE

di Nurgul Cokgezici
Auguri a tutti voi, cari amici cattolici. Che questa vigilia di Natale sia un tempo di pace profonda, di presenza e di luce gentile. Che i desideri più autentici del vostro cuore trovino spazio per germogliare, con naturalezza e silenzio.
Anche se non appartengo a questa tradizione, porto nel cuore l’amore per questa festa. Fin da quando ero piccola ho ricevuto e donato con gioia, sperimentando come il dono non sia solo un oggetto, ma un gesto consapevole, un atto di connessione.
Il Natale, come ogni festa sacra nel mondo, è un momento di scambio energetico, di compassione, di rafforzamento dei legami umani. È un’occasione per ricordare l’impermanenza e, proprio per questo, la preziosità dell’incontro.
Per questo auguro a tutti serenità, consapevolezza e benevolenza.
Ogni festa che celebra la luce, in qualunque religione, appartiene a tutti noi.
Che il bene che coltiviamo oggi ritorni moltiplicato.
Auguri carissimi!!!

SCINTILLE DI CAPODANNO

di Giorgio Righetti
Ho davanti un vecchio almanacco milanese del principio del secolo scorso, zeppo di consigli quotidiani con le previsioni sul bello e sul brutto tempo, le eclissi, i mercati, le ricette contro il mal di stomaco e le strane credenze e superstizioni che difettano di solidi sostegni storici. 31 DICEMBRE: Aprire le finestre prima di mezzanotte per far uscire gli spiriti maligni; Indossare qualcosa di rosso; Evitare il colore nero; Stappare le bottiglie di spumante a mezzanotte in punto, un grande no a granchi e gamberi, camminano all’indietro quindi porterebbero regresso e così via. Sicuramente ci sarà ancora qualche cara vecchietta che trarrà il pronostico delle lenticchie. Secondo la tradizione se mangiati a mezzanotte questi legumi garantiscono soldi e prosperità e un futuro di abbondanza e ricchezza. In questa notte sussiste l’usanza di spari e mortaretti, non solo allo scopo di esprimere festosità, ma anche per certi intermezzi ancestrali con un significato che ricalca antichi riti di scongiuro contro gli spiriti malefici. Siccome le forme rituali abbiano lo scopo di propiziarsi l’abbondanza è normale che si cerchi ancora con ogni mezzo di raggiungere questo fine con la scelta di cibi che in un modo o nell’altro richiamino alla mente le monete, così vengono serviti piatti di lenticchie con lo zampone e grossi grappoli d’uva conservati con cura, perché: “Chi mangia uva al primo dell’anno, maneggerà soldi tutto l’anno”. 1 GENNAIO. Attenti a chi incontrerete per primi uscendo di casa la mattina di Capodanno, vivrete molto più a lungo se sarà una persona anziana, se vi troverete poi davanti un gobbo sarà una autentica fortuna, non è un buon segno se vi troverete davanti un bambino o ancor peggio un prete. Quanto a certe altre credenze superstiziose si potrebbe scrivere un grosso volume. Il fuoco sbuffa nel camino con insistenza, sicuramente sarà una visita, altro avvertimento ronza per casa una vespa o un moscone, idem come sopra. Se vi sentite fischiare l’orecchio sinistro, qualcuno sta certamente parlando male di voi. Se volete poi individuare la persona che lo sta facendo semplicissimo, vi fate suggerire un numero purché rientri tra i primi ventuno dell’alfabeto e identificate poi la persona che conoscete dall’iniziale del primo nome che vi viene in mente. Aprire ombrelli in casa porta malanni e attenti ai gatti neri tanto nefasti, attenzione anche a non rovesciare sale o olio in tavola arriverebbero a breve grossi guai. Un consiglio sistemare degli spizzichi di sale negli angoli della propria abitazione contribuirebbe a tenere lontano la sfortuna. E quanti altri pregiudizi rendono la vita difficilmente alle persone superstiziose nel credere che determinati gesti o comportamenti siano in grado di influenzare o cambiare gli eventi.
IL PASSAGGIO DEL TEMPO
Ho incontrato per la via
un vecchietto tutto bianco,
camminava curvo e stanco
pieno di malinconia.
Tristemente ha mormorato:
“Sono l’anno che è passato”.
Saltellando poi veniva
un allegro fanciullino
e rideva birichino
dietro l’anno che finiva.
Pien di gioia mi ha cantato:
“Sono l’anno appena nato”.
Tra le pagine ingiallite di un vecchio libro di scuola ho trovato questa simpatica filastrocca, che propongo volentieri a tutti gli amici di NUOVE CRONACHE insieme agli AUGURI PIÙ GRANDI, AFFINCHÉ L’ANNO CHE VERRÀ SIA VERAMENTE PIENO DI COSE BELLE.

FIND YOUR CENTER

di Giacomo Pio Augello
In questo articolo, mi avvarrò di un Avatar che chiamerò il “Praticante”.
Perché?
Perché il praticante è ognuno di noi, che ogni mattina ci alziamo e pratichiamo il duro mestiere della vita.
Ma veniamo al tema di oggi.
Quando si pensa al Kung Fu, una delle immagini che viene in mente, dopo l’iconica guardia da schermidore di Bruce Lee, è quella del monaco Shaolin in meditazione su un palo.
Le arti marziali tradizionali danno grande importanza all’allenamento dell’equilibrio, che, non a caso, è uno dei tratti fondamentali di queste discipline.
Questo anche se, in una situazione di combattimento reale, non è consigliabile sacrificare la sicurezza di poggiare su entrambe le gambe.
Ci si chiede allora: a che serve imparare a stare in equilibrio su di un palo?
Per rispondere a questa domanda, prendiamo il nostro praticante, poggiamolo su un palo piantato nel letto di un fiume e osserviamolo.
A prima vista, si potrebbe pensare che il tenere una posizione faticosa alleni la sopportazione del dolore.
Ma la realtà è molto più complessa di così.
Partiamo dalla base.
O meglio, dal palo.
Salire su un palo permette, innanzitutto, di cambiare prospettivaperché eleva lo sguardo del praticante verso orizzonti più ampi di quelli imposti dalla natura.
L’atto di porsi al di sopra del livello del suolo, poi, crea una distanza di sicurezza dall’ambiente circostante.
Badiamo bene.
Il praticante non è disgiunto dalla terra, ma semplicemente distante abbastanza da preservare la sua integrità.
Questa riflessione applicata alla vita quotidiana, ci porta a trarre la seguente conclusione.
La nostra esistenza è, in fin dei conti, un fiume di eventi che scorre verso l’infinito.
Panta rei, insegnava Eraclito.
Noi viviamo immersi in questo fiume.
A volte le sue acque scorrono placide e tranquille.
Altre volte ribollono furiosamente, sconvolte dai venti impetuosi delle situazioni difficili, o dirottate dagli imprevisti o gettate nei baratri del tracollo.
Il “porsi su un palo” ci consente di assumere una posizione di sicurezza e osservare lo scorrere del fiume senza essere travolti dalle sue correnti.
Tornando al praticante, notiamo che la ridotta superficie di appoggio lo obbliga ad assumere una posizione precaria per stare in equilibrio.
Ma, se sale su un palo per non essere travolto dal fiume, perché non sta semplicemente e comodamente seduto?
Presto detto.
Lo stare seduto non gli permetterebbe di capire quale sia il suo vero potere e che cosa meriti davvero la sua attenzione.
Al contrario, la scomodità dello stare eretto su una gamba sola, gli consente di sviluppare la consapevolezza che, per mantenere l’equilibrio, le uniche cose su cui può esercitare il controllo sono il suo corpo e la sua mente.
Nella vita di tutti i giorni vale la stessa dinamica.
Se inseguiamo ciò che non dipende da noi, cadiamo.
La vertiginosa sensazione di distacco dal resto del mondo, poi, sviluppa nel praticante la consapevolezza del fatto che l’unico momento che davvero merita la sua attenzione è il presente, il qui e ora.
Divagare pensando al passato o al futuro, infatti, fa oscillare il baricentro indietro o in avanti.
E, di conseguenza, si cade.
Come insegnava il Maestro Oogway allo sconfortato Po di Kung Fu Panda: “Ieri è storia. Domani è un mistero. Ma oggi è un dono. Per questo, si chiama presente”.
Pensiamoci bene a queste parole.
Noi siamo naturalmente portati a pianificare la nostra vita con progetti che possono coprire pochi giorni, come molti anni. Questo perché siamo consapevoli che il nostro tempo è limitato e, quindi, va gestito.
In questo periodo, poi, ci confortiamo pensando a come erano belle le Feste passate, quando eravamo bambini e il Natale ci appariva come un periodo al fuori dal tempo, immerso in una favolosa atmosfera di magia.
Ma l’amara realtà è che noi non sappiamo quanto tempo abbiamo davvero.
A ben pensarci, non sappiamo nemmeno che cosa ci accadrà nel corso della giornata né se saremo vivi il giorno dopo.
Questo perché, ogni giorno che ci è dato da vivere non ci è dovuto.
Non importa chi tu sia o quali responsabilità tu abbia.
Quel giorno che vivi ti è donato perché non ti è dovuto.
Per questo, è importante prestare attenzione al momento presente.
Veniamo adesso alla domanda cruciale del tema di oggi: Una volta che il praticante è sul palo, come trova il suo equilibrio?
Il segreto sta nel saper dare energia a tutte le parti del corpo coinvolte.
Non è solo la gamba di appoggio, ma anche quella sollevata, il tronco, le mani e i piedi, tutti concorrono a mantenere il corpo in equilibrio.
Ed è questa cooperazione che permette al praticante di ergersi per elevarsi al Cielo.
La natura ha insegnato questa lezione, non l’uomo.
Quando nel 1994 uscì il Re Leone, re Mufasa spiegò a suo figlio Simba che la prosperità del suo regno non derivava dalla tirannica imposizione della sua forza, ma dal rispetto di un delicato equilibrio che collegava tutte le creature, dalla piccola formica alla saltellante antilope.
Anche nella nostra vita vige questa regola.
Se una parte è troppo tesa e l’altra del tutto rilassata, si collassa.
“ When you find your center, you are sure to win!” cantava il capitano Li Shang a Mulan.
Veniamo all’ultimo quesito. Una volta salito sul palo e trovato il proprio equilibrio, che cosa può fare il praticante?
Può scegliere.
Scegliere se farsi turbare da una folata di vento più forte delle altre o dal rombo profondo e minaccioso delle acque sotto di lui, oppure rimanere concentrato su sé stesso e adattarsi ai cambiamenti climatici per mantenere l’equilibrio il più a lungo possibile.
Si stancherà?
Si
Cadrà?
Probabilmente Si.
Si rialzerà?
Forse.
E se cadrà, avrà fallito?
Lo scopriremo la prossima volta.
Un caro saluto e Buone Feste.
Nel prossimo numero: Riuscire e fallire. In ogni contesa, ci sono sempre due soggetti che si fronteggiano. Solo uno riuscirà a vincere.
L’altro dovrà perdere.
Ma cos’è un vincente? E cos’è un perdente?
Ve lo racconto presto.
Vi aspetto.

IL SENSO DELLA PAROLA “ATTESA”

di Aurora Marella
Sono una sostenitrice del valore delle parole, della loro storia e del loro significato più originario. Sono anche convinta che, se si conosce bene la storia delle parole che usiamo, almeno di alcune, o di quelle più frequentemente pronunciate o quelle a cui si è più affezionati, andiamo ad incontrare la nostra Storia, la Storia con la esse maiuscola. Incontriamo le origini e le tradizioni che hanno messo le radici nei vocaboli che tutti i giorni escono dalle nostre bocche. Basta pensarci un attimo e scegliere un piccolo tempo per soffermarsi. Anche le parole hanno le radici che le ancorano come alberi secolari alle nostre abitudini e consuetudini.
Ad esempio, a me piace molto usare a proposito i verbi dimenticare (qualcosa che mi scappa dalla mente) o scordare (qualcosa che, più importante, mi scappa dal cuore) perché l’impatto emotivo sicuramente mi è diverso.
In questi giorni, una parola mi ha incuriosito perché sentita frequentemente: la parola “attesa”.
Durante il mese del Natale è la parola più diffusa, dai sermoni alle pubblicità. E tutti gli anni in questo mese sentiamo dire di prepararci nell’attesa e che l’attesa è quasi più importante dell’evento stesso del Natale. Quando tutti noi abbiamo studiato Leopardi, già ce lo narrava nel suo Sabato, giorno di attesa luminosa: il dì di festa quasi si allunga di malinconia.
L’attesa acquista così un significato bello, elettrico, dinamico, caldo, avvolgente e pieno di aspettative, qualcosa, appunto, che si aspetta.
Però le parole attendere ed aspettare non sono proprio sinonimi.
Se l’attesa è davvero sempre bella e carica di sogno e di desiderio, non è bello attendere un semaforo lunghissimo o restare per ore nella sala d’attesa del medico in ritardo sugli appuntamenti o in coda al supermercato o in un ufficio.
La parola attesa ha in sé una tensione verso qualcosa che si anela come appunto il Natale, una nascita, di un evento importante.
La parola stessa ce lo racconta: è una parola che deriva dal latino ad tendere, cioè essere tesi verso ciò che desideriamo.
La parola aspettare non è proprio la stessa cosa. Infatti la sua origine latina è ex spectare, cioè guardare fuori o guardare attentamente e non ha niente a che vedere con il desiderio o la tensione verso qualcosa. Riguarda l’essere spettatori passivi di un avvenimento, non coinvolti in modo emotivo.
Allora sarebbe meglio dire che si aspetta fermi e più o meno pazienti ad un semaforo ma, mentre guardo la partita, attendo in punta di sedia, pronto ad esultare, il gol della mia squadra preferita.
L’attesa quindi è propria di questo periodo dicembrino, il mese del solstizio d’inverno, che per il 2025 è stato il 21 dicembre alle 16.03, ora italiana, il giorno in cui il dì è stato il più corto dell’anno, anche se i detti popolari lo riferiscono al giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre.
In questo periodo di attesa del Natale si lascia che il tempo trascorra le proprie ore in santa pace si spera meno travolti dalle frenesie.
Becket, con il suo Godot (il quale, nel titolo, viene aspettato, non propriamente atteso, ma ugualmente aspettare questo personaggio trasforma il tempo in attesa e scoperta), ci ha parlato di come l’attesa resti un tema delle nostre esistenze, costantemente. E a volte attendiamo l’inarrivabile. E per questo rischiamo di non godere del piacere di percorrere l’attesa, vivendola.
Con questo contributo voglio ricordare, a me stessa e a tutti quelli che vogliono leggerlo, di pensare a come si affronta l’attesa, nel vero senso della parola, riscoprendo senza retoriche una dimensione più umana di questo periodo dell’anno, di queste feste tanto amate e tanto odiate.
Se riuscissimo a dare retta ai latini che ci hanno spiegato con un infinito presente preceduto da una preposizione semplice (ad tendere) il senso da dare al calendario dell’avvento o alla fine dell’anno o alle celebrazioni del solstizio invernale, scopriremmo che non c’è attesa migliore che vita stessa, da vivere in una tensione benevola e rassicurante, dedicando il tempo, il bene più prezioso, ai nostri desideri, soprattutto quelli da condividere.

L’ALBERO DEI DESIDERI DI AGÀPE – UNA STORIA DI SPERANZA

di Maria Mihaela Barbieru
Era la Vigilia di Natale, e una neve lieve cadeva silenziosa sui tetti del piccolo villaggio di Agàpe. Le luci calde delle case tremolavano come stelle, ma nel cuore della giovane donnaAgàpe brillava qualcosa di ancora più luminoso: un’idea.
Quel pomeriggio, guardando l’albero spoglio nel salotto, Agàpe pensò che quest’anno avrebbe fatto qualcosa di speciale. Sì, decisamente. Non voleva solo decorarlo con palline colorate e fili dorati. No, il suo albero doveva parlare. Doveva raccontare sogni, speranze, promesse. E così prese carta, forbici e un filo di lana rossa, e iniziò a creare.
Ogni pallina che costruiva racchiudeva un desiderio, annotatocon cura:
“Vorrei avere il coraggio di parlare quando ho paura.”
“Spero che la mia famiglia rimanga sempre unita.”
“Non mi fermerò davanti all’indifferenza di alcune persone.”
“Imparerò ad ascoltare di più e a giudicare di meno. Spero di farcela”
Mentre le scriveva, si accorgeva che non erano solo sogni: erano intenti, piccoli semi che voleva piantare nel Nuovo Anno.
Invitò anche le persone a lei più care, e spiegò la magia che stava creando. In pochi minuti, il tavolo si riempì di fogli, colori, e parole sincere. C’era chi desiderava più tempo da trascorrere insieme, chi sperava in un mondo più gentile, chi prometteva di aiutare i propri amati in difficoltà.
Quando l’albero fu colmo sembrava vivo. Ogni pallina raccontava un pezzo del suo cuore sfilato. Era un albero che non brillava solo fuori, ma dentro.
La notte di Natale, Agàpe si sedette ai piedi dell’albero e chiuse gli occhi. In silenzio, sussurrò una promessa:
“Custodirò ogni intento come una scintilla. Li farò crescere, giorno dopo giorno.”
Il vento gelido che soffiava fuori, nel piccolo villaggio in Cappadocia, non spegneva il calore del salotto. Perché un albero decorato con verità e amore ha il potere di scaldare anche l’inverno più spietato.
E così, nell’abbraccio di una notte silenziosa, Agàpe ci insegnò che il futuro si costruisce con piccoli gesti, parole delicate, e la volontà di essere ogni giorno un po’ migliori.
E quest’albero, anno dopo anno, rimarrà sempre lì — a ricordarle e ricordarci che ogni desiderio è il primo passo di un cammino.
Perché, quando si decora con l’anima e in autenticità, anche un semplice albero diventa poesia.”
Spazio di introspezione e crescita personale
Potresti ispirarti alla storia di Agàpe, pensata per stimolare la tua consapevolezza, riflessione e azione personale:
1. Qual è il desiderio che abita silenziosamente nel tuo cuore, e che forse non hai ancora avuto il coraggio di pronunciare?
2. Se potessi dare un colore o una forma a questo desiderio, come sarebbe la “pallina” che lo rappresenta sull’Albero dei tuoi desideri?
3. Quale parte di te vorresti lasciare andare prima di entrare nel nuovo anno? E quale parte vorresti coltivare?
4. Quale promessa vorresti fare a te stesso/a per il nuovo anno, proprio come ha fatto Agàpe?
5. Se potessi sussurrare un’intenzione al vento della notte di Capodanno, quale sarebbe la tua preghiera per il tempo che verrà?

DAL BUCO DELLA SERRATURA
Pettegolezzi solitari

di Luigi Filipetto
Il paravento delle persiane. Lassù di fronte sono un mistero. Dico di fronte perché dovrei avere il collo di una giraffa per vedere dal mio balcone le porte e le finestre del mio palazzo. Ma lassù nel palazzo di fronte non posso non vedere e nemmeno non sentire.
Insomma, lassù sono perennemente chiuse, anche quando c’è qualcuno dentro perché a volte si vede la luce. A volte, non sempre, che vuol dire che chi ci abita viene una volta ogni tanto. Le ombre dentro si vedono muoversi, ma la tua curiosità finisce lì. Pensi che se incroci il portinaio di là magari gli chiedi qualcosa. Poi ti dici: chi te lo fa fare? Fino a qualche anno fa ci stava una coppia che teneva tutto aperto. Anche troppo. Oh, non è che facessi il ficcanaso, ma certe cose se sei alla finestra non puoi non vederle. Lui poi d’estate prendeva il sole, sdraiato alla finestra con le gambe allungate fuori dal davanzale. Non era un gran bello spettacolo, né lui né la scena in sé. C’erano poi i miei vicini che si stavano trasferendo ed erano in trattative per vendere. Fatto sta che la vista di quel brutto coso alla finestra non avrebbe costituito una convincente attrattiva per un futuro acquirente. E un giorno gli diedero la voce: scusi signore, può levarsi da lì, sa stiamo vendendo la casa. A buon intenditor poche parole. Il tipo aveva tirato dentro le gambe e anche il resto.
All’altezza del mio piano le persiane a volte sono aperte a volte restano chiuse. Sono una seconda casa di una signora con cui ci si scambia anche il saluto quando arriva. È una grande amante dei fiori, quando viene ne porta di nuovi. Poi ogni giorno li guarda, li rimira, sposta i vasi un po’ qua un po’ là, toglie le foglioline secche. Poi di colpo le persiane restano chiuse e ti dici: è ripartita.
Flora abita al piano di sotto. Lei guarda spesso in su quando esce sul pianerottolo e allora grandi saluti. Eravamo la sua unica compagnia. Ci si chiedeva anche come va come non va. Poi è andata avanti con gli anni e allora è rimasto solo il saluto con le mani. Ultimamente c’era una ragazza che la assisteva. Poi le persiane sono rimaste chiuse giorno e notte. Ti chiedi che cosa può essere successo, ma questo prima o poi lo scoprirai. Nel frattempo ti era capitato di assistere a una scenata del suo vicino. In un primo momento senti solo gridare, poi guardi meglio e vedi il tipo con la testa dentro alla casa di Flora. Poi sbatte la porta e se va sempre gridando: mi sono rotto i co…ni. Cose da correre lì e prenderlo a calci. Fresco di questa scenata, qualche mattina fa ti vedo sua figlia fuori sul pianerottolo in compagnia di un ragazzo. Sono ancora in mutande e fumano la sigaretta. Poco dopo si fa vivo un altro ragazzo pure lui in mutande. Nel pomeriggio tre cuscini sono esposti al sole. Metti in azione una serie di elucubrazioni. Conclusione: è chiaro che la ragazza ha preso al volo una delle rare assenze di mamma e papà. Soprattutto di quel papà che a occhio rompe le scatole anche agli altri vicini. Pochi giorni dopo la scenata con Flora, lo vedi in compagnia della figlia che esce dalla porta accanto dove si è installata una nuova coppia. Visto il tipo, pensi che sia andato dai nuovi a mettere i puntini sugli i, magari con una formula vellutata, un gesto di buona vicinanza per dare il benvenuto. E resti di questa idea.
Alcune note che venivano dal palazzo di fronte ti risvegliarono qualcosa che non ti era nuovo. Giù al secondo piano, seduto a terra sul pianerottolo, un ragazzino dell’età delle medie teneva nelle mani un flauto. Gli occhi erano fissi su un foglio che teneva sulle ginocchia. Provava e riprovava a mettere insieme le note di un pezzo, quasi come un compito da svolgere a casa. Non sai ancora perché e come, dicesti a te stesso: aspetta aspetta. Cerchi fra i dischi vecchi Il Bolero di Ravel. Lo metti al volume idoneo per arrivare alle orecchie del ragazzo. Che dapprima si gira di qua e di là, poi alza lo sguardo e dopo un attimo di perplessità fa un veloce cenno con la mano. Tu hai ricambiato il saluto e hai lasciato la musica andare con un tono più sommesso. Un’amicizia volante e piuttosto piacevole.
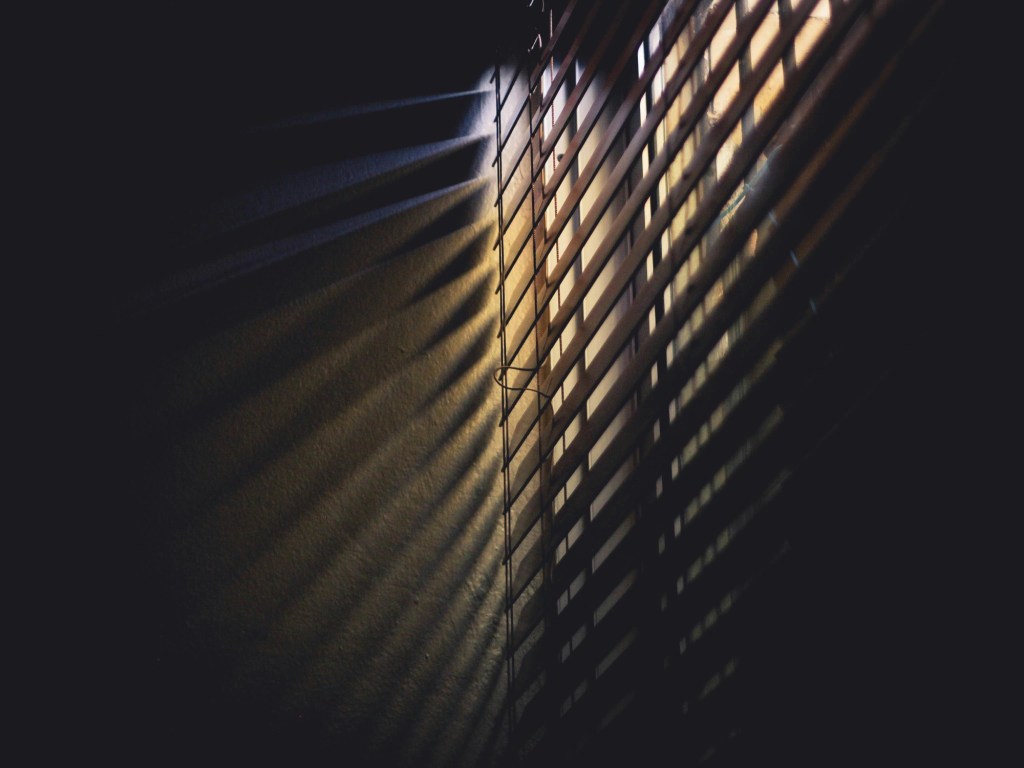
SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 17

di Fabio Fumagalli


QUANDO A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA

di Giorgio Righetti
LA BEFANA DEL VIGILE. Nel 1946 nacque una bellissima usanza a Milano quella di portare davanti alle postazioni dei Vigili Urbani nel giorno della Santa Epifania alimenti vari come olio, pasta, spumanti, bevande e, gli immancabili panettoni simboli di Milano, i regali erano talmente tanti da creare problemi di traffico e per non abbandonare il loro posto i cari Ghisa dovevano farsi aiutare dai cittadini a disporre con un certo ordine i regali ricevuti. In seguito i Vigili Urbani decisero di destinare quanto veniva dato loro alle famiglie più povere, aggiungendo anche il denaro di una colletta personale fatta tra tutti i Ghisa milanesi. La Befana del Vigile non ebbe però vita lunga. Nel giro di pochi anni, così come era apparsa, uscì di scena dal costume e dalle usanze dalla vita milanese senza una motivata spiegazione. Nel 1971 si disse che la Commissione interna della Polizia Municipale di Milano aveva deciso di interrompere la tradizionale festa della Befana del Vigile perché sfruttata dai produttori di dolciumi e alimenti per farsi propaganda e, ormai ridotta a una enorme macchina pubblicitaria. Un vero peccato perché quella bella tradizione rappresentava un momento di forte solidarietà, manifestando lo spirito che caratterizzava il Natale in quel tempo lontano, questa bellissima usanza era anche un gesto di riconoscenza verso i cari Ghisa che ogni giorno con ogni tempo, garantivano (e garantiscono), la sicurezza e l’ordine per 6le strade di Milano.

GRAZIE, OCCIDENTE

di Alessandro Bocci
Nell’introduzione ad un suo saggio, Federico Rampini nota che “grazie” ed “Occidente” sono due termini che non sentiremo mai pronunciare insieme. Ringraziare l’Occidente sembra essere infatti un’oscenità.
Eppure non possono esserci dubbi sul fatto che senza la cultura, la tecnologia, la medicina e i nostri valori il mondo sarebbe un luogo ben peggiore di quello che è.
Nel settore primario, i fertilizzanti chimici, le sementi geneticamente modificate e le biotecnologie occidentali hanno permesso a tanti stati africani ed asiatici di sconfiggere la fame. Nel subcontinente indiano, le disponibilità alimentari si sono moltiplicate non grazie al sistema delle caste, ma alla presenza di multinazionali straniere.
Senza la rivoluzione industriale la stragrande maggioranza della popolazione vivente semplicemente non ci sarebbe, ma l’industrializzazione occidentale viene spesso presentata come la madre dell’ inquinamento del pianeta. In realtà, i modelli energetici preindustriali di Asia ed Africa erano ben più dannosi per l’ambiente. Se oggi il miliardo e mezzo di cittadini africani producesse energia con le stesse modalità con le quali veniva prodotta prima dell’arrivo degli europei sarebbe davvero la catastrofe ambientale. In Asia, il modello industriale sovietico ha prodotto un numero impressionante di disastri che non vale nemmeno la pena elencare. Basti pensare, comunque, all’inquinamento della penisola del Tajmyr o a quello della zona dell’ex lago d’Aral.
I medici occidentali, a partire da Jenner che introdusse il vaccino per il vaiolo e da Fleming che scoprì la penicillina, hanno introdotto innovazioni che hanno permesso l’allungamento della vita media, a livello planetario, di quasi cinquant’anni.
Eppure nelle università statunitensi, in primis quelle con rette a partire da novanta mila dollari annui, si raglia contro la nostra civiltà. Per non parlare di certi movimenti femministi, disponibili anche a manifestare al fianco di fanatici che mettono il burqa alle loro compagne. Per un numero crescente di persone andare a votare è semplicemente una scocciatura e le parole di Churchill che ci ricordava che la democrazia era la peggiore forma di governo eccetto tutte quelle sperimentate fino a quel momento sembrano essere completamente dimenticate.
Forse pensando all’Iran di Khomeini, nelle cui carceri si stupravano le donne che si ribellavano alla sharia, lo scrittore libanese Maalouf nota che tutti coloro che criticano l’Occidente vanno incontro a fallimenti clamorosi. È davvero anomalo e singolare che sia un intellettuale arabo a ricordarcelo. Noi invece preferiamo marciare per la pace, e incolpare i nostri governi di complicità in tutti i conflitti del mondo, senza riflettere sulla circostanza che se i giovani statunitensi avessero fatto la stessa scelta negli anni quaranta del secolo scorso oggi ci sarebbero ancora i nazisti.

TEMPO CHE FU. I CANTASTORIE

di Giorgio Righetti
Recentemente in un mercatino di cose vecchie, ho trovato un antico canzoniere autografato, di quelli che il Barbapedana distribuiva nelle osterie dopo le sue esibizioni. Il Barbapedana era di certo il più sincero e spontaneo cantastorie milanese. Girava fiero e spavaldo di osteria in osteria con la sua chitarra, sempre vestito con una vecchia zimarra color marrone intenso e con un cappello a cilindro adorno di un codino di scoiattolo calcato sulla testa. Lo si trovava di solito all’osteria di Loreto dove raccoglieva i suoi memorabili successi. Autentico anticipatore dei cantautori di oggi ironizzava su se stesso con una sua sigla musicale.
Barbapedana el gh’aveva on gilé / senza el denanz cont via el dedree / con i oggioeu longh ona spanna / l’era el gilé del Barpedana!…
Rivediamolo dunque al Loreto il caro Barbapedana con la canzonetta che fu il suo cavallo di battaglia.
De piscinin che l’era
el ballava volentera
el ballava su on quattrin
de tant che l’era piscinin…
La canzone era interminabile, il Barbapedana la sapeva sempre aggiornare e renderla attuale con nuove strofe. Altra canzone famosa fu “La tegnoeula”:
Me regordi che on di, in la mia scoeula
ho veduù sgorattà una tegnoeula…
Tutt stremii me son miss a vosà:
“Tè la chì!… te la lì… te là…”.
Inutile dire come gli spettatori si divertissero nel seguire l’immaginario volo del pipistrello che il Barbapedana sapeva benissimo rincorrere con lo sguardo, accompagnato da gesti di su e di giù, di qua e di la. Dopo aver fatto il giro dell’osteria con il piattello per raccogliere qualche soldino il Barbapedana era costretto a concedere il bis. GioIosa fu sempre la vita di questo cantastorie milanese di osteria, serena fu la sua vecchiaia al termine della sua carriera, dove concluse gli ultimi anni della sua vita alla Baggina in piena povertà. Indubbiamente, al giorno d’oggi, il suo nome non dice assolutamente nulla, eppure, ai suoi tempi era notissimo! Arrigo Boito (1842-1918), dopo averlo incontrato in un’osteria di Porta Tosa si sofferma a lungo a parlare di lui, in una delle sue novelle: “La musica in piazza” (scritta fra il 1870 e il 1871) dove menziona Enrico Molaschi, come il più famoso e conosciuto di una successione di cantastorie che circolavano ai suoi tempi di locanda in locanda, nei vari paesi, fra Lombardia ed Emilia. Pure Gaetano Crespi, illustre ed apprezzato poeta dialettale, autore del Canzoniere milanese, narrò ampiamente nella sua opera le imprese di questo singolare personaggio, che lui amava chiamare Barbapedanna (con la doppia “n”), il caro paffuto cantastorie milanese, tarchiato e rubicondo, gioviale e chiassoso
Ch‘el ghaveva on gilè
senza el denanz e cont via el dedree.
P.S. Morto ormai da tempo Enrico Molaschi, durante la Guerra d’Africa si cercò di far rivivere il personaggio del Barbapedana, parafrasando la famosa filastrocca con questa tiritera di propaganda:
Barbapedana el gh’aveva on s’cioppètt
per sparagh ai soldaa de Maomètt
e ‘sto s’cioppètt l’era longh ona spanna,
l’era el s’cioppètt del Barbapedana.
E da bersaglier che l’era,
el sparava volentera,
el sparava col s’cioppettin
contra i trupp di beduin.
Altri volonterosi cantastorie ambulanti cercarono di far rivivere il personaggio del Barbapedanna, attribuendosi identità e qualità false, ma senza fortuna.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.16

di Fabio Fumagalli

AGÀPE – CRONACA DI UN CAMBIAMENTO MAGICO E CONSAPEVOLE
di Maria Mihaela Barbieru
“Agàpe camminava ogni giorno verso lo stesso ufficio, tra e-mail, scadenze e telefonate. Nella sua testa si affollavano pensieri come: “Non sono abbastanza veloce”, “Se sbaglio, deluderò tutti”. Questi pensieri, spesso invisibili, creavano emozioni pesanti: ansia, senso di colpa, inadeguatezza, frustrazione.
Un giorno, nel bel mezzo di una riunione, un collega sbottò con tono un po’ aggressivo. Agàpe sentì salire l’emozione della rabbia, tuttavia qualcosa in lei si fermò.
Respirò. Agàpe scelse parole diverse:
“Mi rendo conto che siamo tutti sotto pressione. Possiamo parlarne senza accusarci?”
Quel gesto, semplice seppur potente, cambiò l’atmosfera. I colleghi iniziarono ad aprirsi, a collaborare. Un comportamento diverso aveva creato un legame nuovo. Un ponte.
Agàpe, tornando a casa, annotò consapevolmente nel suo diario:
“I pensieri sono misteri, ma posso osservarli. Le parole sono magiche: scelgo di usarle con cura. Le emozioni sono ponti: attraversarle con consapevolezza mi porta dall’altra parte, dall’Altro. I comportamenti creano connessioni vere.”
Fu allora che comprese anche il valore del tempo.
Non era solo questione di fare tutto, ma di scegliere cosa conta.
Non era una corsa contro l’orologio, ma una danza tra priorità, emozioni e relazioni.
Da quel giorno, Agàpe iniziò ogni mattina, chiedendosi:
“Dove posso mettere oggi la mia energia, in modo utile e umano?”
“Che cosa posso creare oggi di magico e di valore?”
La storia di Agàpe evidenzia un viaggio di introspezione che porta verso una magica e crescente consapevolezza.
Ogni gesto era preciso, ogni parola misurata con cura, ma dentro di lei qualcosa sussurrava: un bisogno di ascoltarsi, di fermarsi e disquisire, di scegliere, di fare luce, di ritrovarsi.
La sua consapevolezza cresceva come il respiro: lenta, naturale, profonda.
E da quella luce interiore iniziò a gestire il tempo con intenzione, scegliendo ciò che nutre, lasciando andare ciò che pesa.
Da quel giorno Agàpe si è incontrata.
Il suo e nostro percorso di crescita personale si configura spesso come un processo intenzionale di superamento di schemi mentali limitanti, una progressiva espansione dei confini percettivi oscurati da incertezze e ambiguità. Tale cammino implica una trasformazione simbolica, nella quale l’individuo impara a discernere tra illusioni seducenti e autenticità profonda, scegliendo di elevarsi al di sopra di costrutti identitari superficiali e socialmente imposti.
In questo processo, emerge l’esigenza di sostare, di prendersi cura di sé nelle dimensioni più umane e terrene, per poi riconnettersi con la propria aspirazione al cambiamento e all’evoluzione.
Il tempo, inteso nella sua accezione filosofica di Chronos, diviene maestro silenzioso e guida nel cammino verso l’amore di sé che trascende l’ego. È in questa consapevolezza che nasce la volontà profonda: quella di voler proseguire, di voler scegliere sé stessi nel significato stesso di agape.
Ed è questo il mio augurio a chi sente il richiamo del cambiamento, a chi desidera riconoscersi oltre le maschere, a chi è pronto a intraprendere un viaggio di consapevolezza autentica.
È un mio invito, al contempo, a rallentare, ascoltare, sentirsi. A scegliere sé stessi. A camminare insieme nel tempo dell’anima, dove ogni passo è un atto d’amore verso la propria essenza.
Che Agàpe possa vivere in chiunque sente il richiamo del cambiamento nel cuore, a chi avverte dentro di sé un’emozione che spinge a esplorare in profondità, a chi si commuove nel percepire che “qualcosa” sta per nascere.
La sua storia è un invito a dare voce alla propria vulnerabilità, a sentire la paura e trasformarla in coraggio, a lasciare che la malinconia diventi tenerezza verso sé stessi, a mediare per trasformare la rabbia in confine sano, la gioia in spinta, il silenzio in presenza.
È un susurro a volersi bene nel chronos giusto, a camminare dentro le proprie emozioni, a farsi spazio e darsi il permesso di esistere.
Magica-mente!
Estratto dal mio libro “Ponti di Emozioni” che sarà a breve pubblicato.

Mi occupo di:
Formazione e consulenza linguistica (con focus su comunicazione professionale e interculturale);
Mediazione interculturale, agevolando il dialogo tra persone provenienti da contesti culturali diversi, in contesti professionali (es. aziendali, legali, formativi);
Coaching individuale e di gruppo: supporto a professionisti e aziende per migliorare le competenze relazionali, comunicative e interculturali.
ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO

di Giacomo Pio Augello
Me lo ricordo ancora.
E me lo porterò dentro per tutta la vita.
Il mio primo esame.
“Tra una settimana ti fai l’esame” mi aveva detto il Maestro 8 giorni prima.
Non ci potevo credere.
Io, fino a quel momento, avevo praticato sport, ma mai con uno scopo preciso.
Mi “tenevo in forma” semplicemente perché ero (e lo sono ancora) convinto che il segreto per una vita felice risiedesse nell’equilibrio tra l’attività intellettuale e l’esercizio fisico.
Ne avevo avuti tanti di esempi di persone che si erano distrutte per non aver saputo dare il giusto peso ad entrambe le cose.
Io volevo essere diverso.
Volevo dimostrare che, per poter conseguire grandi risultati nel proprio lavoro, è indispensabile godere di una salute fisica forte e l’unico modo per ottenerla è attraverso l’allenamento costante.
Nonostante i miei intenti, le mie scarse qualità atletiche non mi avevano consentito, né, tantomeno, fatto sperare, di raggiungere un qualche risultato.
Fino a quel momento.
Era una sera di aprile.
In palestra, respiravo un’atmosfera intensa ed elettrizzante.
Ancora non lo sapevo, ma ero io a renderla tale.
Per l’emozione che mi animava al pensiero di stare per compiere un passo verso un livello superiore di preparazione.
Dopo il rituale di apertura della lezione e il riscaldamento, i due allievi più anziani del corso mi portarono in una stanza appartata.
Si sedettero su una panca con un quaderno e una penna e mi chiesero di eseguire in un’unica tirata le sequenze che avevo imparato fino a quel momento.
Lì dentro, lontano dagli sguardi dei miei compagni e dalla voce del Maestro, mi confrontai per la prima volta, in uno scontro diretto, con i miei limiti.
E le mie capacità.
Finita la lezione, il Maestro mi invitò sotto l’altare e, davanti a tutti i presenti, in una formale cerimonia, mi consegnò il diploma per il superamento dell’esame.
Non ci potevo credere.
Io, che ero stato dato per spacciato già dopo il primo giorno di lezione, avevo conseguito un risultato in uno dei sistemi di arti marziali più completi al mondo.
Quell’esperienza mi cambiò per sempre.
Fin da quando ho iniziato a praticare, ho sempre saputo che il Kung Fu è un percorso di crescita che porta a migliorarsi attraverso l’acquisizione di abilità che prima non si possedevano.
Per questo l’ho scelto come una parte integrante della mia vita (chi ha letto il numero di giugno” La più universale delle domande” lo ricorderà).
Ma l’esperienza di quel primo esame, traguardo che mi era costato fatica e impegno, ma, soprattutto, che non era affatto scontato che raggiungessi, mi rese consapevole del fatto che io potevo essere artefice del mio Destino, tanto in palestra quanto in tutti gli altri aspetti della vita.
Questa presa di coscienza mi fece pensare ad Efesto, il più umano tra gli Dei dell’Olimpo.
Perché vi dico questo?
Perché Efesto è un dio imperfetto.
Al contrario delle altre divinità del pantheon greco, bellissime nei lineamenti e nelle proporzioni, lui è zoppo e sgradevole alla vista.
Il suo aspetto è talmente insolito per gli standard del suo mondo, che, quando nasce, Era, inorridita dalle sembianze storte di quella creatura generata con il marito fratello Zeus, lo getta già dall’Olimpo.
Ora, immaginate il dolore di questo bambino.
Ripudiato dalla sua stessa madre solo perché era quello che era.
Un diverso.
Ma, come oggi ci sono figure che proteggono queste creature, anche l’arcaico mondo greco aveva i suoi Angeli Custodi.
Ed Efesto li trovò nelle ninfe del mare, Eurinome e Teti, la futura madre di Achille.
Furono loro a raccogliere il piccolo Efesto dopo un volo durato un giorno e una notte.
Lo accudirono, lo nutrirono. Lo portarono per la prima volta nel cratere di un vulcano.
Lì, l’andamento claudicante della fiamma viva incendiò lo sguardo e la mente del piccolo e la sua luce rossa gli indicò la strada per il suo riscatto: la divina agilità delle sue mani.
Ed Efesto seguì quella strada divenendo il dio metallurgo.
Grazie alla sua abilità, creò opere straordinarie, capaci di stupire sia per la loro bellezza che per il loro potere distruttivo.
E’ questa la caratteristica che fa di Efesto un dio unico del suo genere.
Mentre le altre divinità non fanno niente, a parte infliggere solenni castighi ai mortali magari per una frase inappropriata detta in un momento particolarmente emozionante (la povera Niobe, pur trasformata in roccia, sta ancora piangendo la morte dei suoi 50 figli per mano dei 2 crudeli gemelli di Latona, Apollo e Artemide), Efesto lavora.
Non ha tempo di curarsi delle sciocchezze dei mortali.
Ora, le sue opere più celebri sono le folgori di Zeus.
Ma (lo dico da appassionato), la sua opera più bella è l’armatura di Achille.
Perché dico questo?
Perché quell’artefatto forgiato solo dalle sue mani divine fu, in realtà, un gesto d’amore.
Omero, infatti, racconta che dopo la morte di Patroclo, Teti si recò da Efesto e inginocchiatasi ai suoi piedi lo pregò di fabbricare per il figlio un’armatura che lo proteggesse dalla morte.
Il dio metallurgo, memore di quanto la ninfa aveva fatto per luiquando era piccolo, pensò: “E’ grande dovere pagare a Teti riccioli belli tutto il compenso!” e subito le disse: “Coraggio. Questo non ti preoccupi il cuore. Con me, avrà armi bellissime, tali che ognuno le ammirerà che le veda, anche fra molti mortali. (Iliade Canto XVIII vers. 440 – 465”).
E così fece.
Mettendo la sua arte al servizio della sua benefattrice, forgiò in una sola notte un capolavoro di bronzo, stagno e oro.
Tanto prezioso da generare, al momento della morte del Pelide, una odiosa contesa tra Aiace Telamonio, la gigantesca rocca degli Achei, e il Laerziade Odisseo, maestro di inganni.
Tornando a me, ogni volta che faccio un esame, mi viene sempre in mente quella stanza e penso: “ Non stai solo facendo un esame. Stai forgiando il te stesso di domani”.
Ora che conoscete la storia e il mito, provate anche voi ad utilizzare gli strumenti donati dalla Natura per realizzare opere straordinarie.
Così potrete essere come i protagonisti del film “Il Volo della Fenice”: artefici del vostro Destino.
Un caro saluto.

UNA STORIA CHE CONOSCIAMO TUTTI, O FORSE NON LA CONOSCIAMO TUTTA:LA STORIA DELLE PANCHINE ROSSE

di Aurora Marella
Durante questo ultimo mese mi sono imbattuta in una serata strana, diversa dalle serate di divulgazione o di intrattenimento che generalmente cerco per arricchire le mie giornate, la mia consapevolezza, le mie attitudini e il mio sapere sulle cose del mondo e sui punti di vista.
In una di queste serate ho incontrato un cantastorie.
Ecco, io pensavo che questo lavoro non esistesse più e che fosse oggetto di studio delle metodologie didattiche dell’antica Grecia o del Medioevo nelle corti.
Gli aedi e i menestrelli, i giullari, si presentavano come coloro che insegnavano alla gente del popolo le storie antiche, i miti, le leggende, le imprese eroiche e anche la Storia, fino ai fatti di cronaca, raccontati cantando, danzando, suonando, per far ridere fino a far piangere dalla commozione. La gente restava attorno, faceva capannello e fissava lo sguardo.
Il mio cantastorie, quella sera, mi chiese di quale storia avessi bisogno e al momento io non lo sapevo. Abbiamo comunque parlato e, alla fine, una storia di cui avessi bisogno c’era e l’abbiamo costruita insieme ed è stato un momento molto tremolante, come la fiammella di una candela che resiste e illumina un piccolo angolo di buio facendo tutta la differenza.
Durante questo mese ho scoperto la storia di cui ho bisogno adesso e, dato che il cantastorie non è più a mia disposizione, la scrivo io e divento io il mio cantastorie. E spero anche vostro.
Voglio cantare la storia delle panchine rosse di cui in questi giorni sentiamo parlare da tutte le parti. Ma mi sono resa conto che io non sapevo niente delle panchine rosse, della loro storia. Le conosco come le conoscono tutti o quasi tutti quelli a cui ho chiesto se possiedano saperi sulla la storia delle panchine rosse: le si conosce come simbolo attuale contro la violenza sul genere femminile, senza sapere in che modo siano stati scelti la panchina, il rosso, quando, da chi.
Chiedendo in giro di qua e di là, alla gente che con cui mi relazioni, ho scoperto che nessuno conosce il motivo per cui ci sono proprio delle panchine rosse ma tutti sappiamo che ci sono e sono lì per insegnare e far ricordare.
Quindi, la mia storia parte da quando le panchine rosse non c’erano.
La prima panchina rossa nasce da un progetto torinese nel 2014, quando a novembre il giorno 26, venne installata la prima nel capoluogo piemontese. La panchina voleva ricordare la donna uccisa da un componente familiare conosciuto, amato, e da cui, in teoria, bisogna sentirsi protetti. Quindi, la prima panchina voleva già ricordare quello che sappiamo tutti oggi cioè la vittima di un amore che amore non è. La panchina era stata posta in un luogo pubblico, di viavai. Un monito. Dipinta rosso sangue, due occhi grandi femminili. Un’intuizione dell’artista Karim Cherif. Guardami, dicono gli occhi disegnati sulla panchina. Non voltarti dall’altra parte. Un appello. Passante, siediti, parla, ascolta.
Si ricorda a novembre, il 25, la Giornata contro la violenza sulle Donne per non dimenticare il fatto che ha portato alla scelta di questo mese e giorno per questa commemorazione tanto triste quanto assurda ma purtroppo sempre attuale, pur con variabili e concause diverse che corrono dal sociale, al politico al domestico.
Si sceglie novembre perché nel 1960, nella Repubblica Dominicana, due attiviste furono uccise violentemente da dei sicari mentre si recavano in carcere a trovare i loro mariti, prigionieri politici.
Altro luogo, altro continente, altra epoca storica, altro movente. Stesso crimine.
Tornando alla nostra storia locale, a Torino, dove è partito tutto in Italia, vennero installate altre dieci panchine rosse, e poi ancora altre dieci, ma queste furono ricoperte di polemiche sterili relative ai pregiudizi sugli immigrati ritenuti la causa unica dei problemi di violenza di genere. Il senso della lotta contro un’educazione violenta che parte dalla propria casa è stato un po’ stravolto attraverso queste polemiche perché la panchina non nasceva per simboleggiare la criminalità cittadina, problema diffuso certamente ma non era quello il tema, ma, come sappiamo, era lì – occhi negli occhi di tutti – per urlare in
silenzio di quei delitti passionali, di controllo, interni alla sfera delle conoscenze familiari, interni alla propria casa e famiglia, quelle gabbie segrete fatte di grovigli emotivi mai sciolti.
Altra cosa, insomma. Qualcosa di cui ancora la politica, la società, l’educazione non si stavano prendendo carico.
Dal torinese, la storia delle panchine rosse è passata nella Lomellina, in provincia di Pavia, dove una bibliotecaria ha portato avanti con attivismo e vigore questo discorso fino a convocare nella vicina biblioteca di Magenta nel settembre del 2016 l’Assemblea degli Stati Generali delle Donne “in memoria di tutte le donne uccise per mano di chi diceva di amarle”, rendendo inequivocabile la tematica, chiara, delineata. Questa era la frase di presentazione che definiva il Convegno, anche questo dal nome che prendeva spunto chiaramente dalla Rivoluzione Francese, perché stava avvenendo una rivoluzione sociale.
Ecco, una questione di educazione, di percorso attento alla salute della famiglia e dei
sentimenti. Una novità.
In questa ricerca ho scoperto anche da dove viene il color rosso. Ovviamente, rosso sangue. E dalle scarpe rosse, in un’installazione artistica nella piazza della città messicana Ciudad Juarez. Un’installazione dell’ottobre del 2009 dell’artista Elina Chauvet.
Trentatré paia di scarpe rosse per ricordare centinaia di donne uccise, moltissime in quella stessa città, in un circolo caotico e terribile di omicidi seriali di giovanissime lavoratrici nell’industria del tec-duty free. Un caso sociale che ha scosso il mondo di cui si parla ancora troppo poco e su cui è stato girato un film, un po’ action a dire il vero, ma comunque a testimonianza dei fatti, Bordertown.
Il rosso delle panchine deriva da quelle scarpe rosse della città messicana. In comune hanno la triste matrice del femminicidio ma, pur partendo e concludendo nello stesso concetto, le panchine e le scarpe fanno due giri storici e sociali diversi.
Nel 2021 il simbolo della panchina rossa è stato dichiarato come il marchio che doveva avere la garanzia che venisse usato per finalità sociali e politiche con il chiaro intento di essere utilizzata per dire no alla violenza di genere e, nello specifico, alla violenza domestica per mano dei familiari.
Adesso tutta l’Italia è costellata di panchine rosse che rappresentano un punto di incontro simbolico, un invito a sedersi e parlare in mezzo alla natura di un parco o su un marciapiede.
Un invito silenzioso, intimo, discreto in un luogo aperto e sicuro come qualsiasi luogo dovrebbe essere, soprattutto la propria casa. Perché il senso della vita e del rispetto deve essere fatto crescere dentro e guidato, preso in carico da tutti.
E così, mi sono trasformata in un cantastorie. Ho raccontato la storia di cui avevo bisogno.
L’ho raccontata a me e l’ho raccontata per chi ha voluto leggerla, a tutti coloro che si sono posti la mia stessa domanda sulla storia sulle panchine rosse oppure no.
Le panchine rosse, ora, per me, hanno un senso in più.

IL PANETTONE MILANESE

di Giorgio Righetti
Il panettone tradizionale sulla cui nascita la fantasia popolare ha creato simpatiche leggende, in origine non era altro che un grosso pane il (pangrande), alla preparazione del quale doveva sovrintendere il capo famiglia, che prima della cottura vi incideva col coltello una croce in segno di fedeltà e benedizione. Il pangrande veniva consumato dalla famiglia riunita per la “Tradizione del ciocco”, l’usanza di far ardere un grosso tronco di legno dalla Vigiglia di Natale all’Epifania. Il pangrande a tutti gli effetti può essere considerato il diretto antenato del moderno panettone, questo sicuramente molto più elaborato e gradevole. Sono però le leggende ad accrescere il fascino dell’immancabile dolce delle feste di Natale. Eccovi secondo me le due più belle.
“EL PAN DEL TONI”. Era la vigilia di Natale, alla corte di Ludovico Maria Sforza detto il Moro, quella sera si dava al Castello di Milano un pranzo di gala, tra le musiche i canti e i giochi dei giullari, avevano trionfato su tavole riccamente imbanditi i piatti più ricercati ed elaboratissimi, manicaretti, frutta esotica, pollami, il tutto arricchito con vini pregiati. Un banchetto di lusso da far onore alla cucina ducale che doveva concludersi con un delicatissimo dolce. Anche in quell’occasione il capo cuoco aveva predisposto un dolce particolare, degno di chiudere con successo il favoloso banchetto, ma sul più bello il dolce chiuso nel forno era bruciato. Come rimediare, non rimaneva tempo sufficiente per prepararne un’altro. I commensali cominciavano a rumoreggiare reclamando con alte grida: “il dolce, il dolce”, il Toni, lo sguattero della cucina si fece timidamente avanti e con voce tremante disse al capo cuoco: “Io con gli avanzi dell’impasto che avevate preparato per il grande dolce, con l’aggiunta di qualche uovo, un poco di zucchero, un poco di uvetta, del cedro e del burro ho preparato un dolce tutto mio per festeggiare il Natale con alcuni amici, se volete è lì”. Il capo cuoco guardò il Toni con aria di compatimento, ma non aveva altra scelta, o portare in tavola quel dolce che sembrava una grossa forma di pane o incorrere nelle ire di Ludovico, il semplicissimo dolce fu sistemato su un grande vassoio e portato in tavola. Dopo il primo momento di stupore dei commensali il dolce ebbe un successo clamoroso. Ludovico si congratulò con il capocuoco. Grazie al “pan del Toni”, il banchetto si era concluso con un trionfo e, il “pan del Toni” o panettone, come in seguito venne chiamato, divenne il dolce più famoso di Milano. Anche se questa storia è una delle tante versioni sulla nascita del panettone, a Milano e non solo si usa celebrare il Natale consumando questo dolce tipico milanese, largamente diffuso in tutto il mondo.
VI È UN’ALTRA VERSIONE MENO ACCREDITATA DELLE ALTRE CHE RITERREBBE LA NASCITA DEL PANETTONE COLLEGABILE A SUOR UGHETTA. Era un convento molto povero quello di Suor Ughetta, nemmeno con l’avvicinarsi del Natale le suore erano riuscite a mettere insieme un po’ di soldini per acquistare l’occorrente per preparare un buon pranzetto per l’occasione. Suor Ughetta addetta alla cucina del convento, si sentiva quasi in colpa, con quello che era rimasto nella dispensa non si poteva fare molto. Era la vigilia di Natale e a suor Ughetta sarebbe piaciuto preparare un dolce magari anche piccolo e semplice per le sue consorelle, considerando anche che nelle famiglie più povere a Natale non mancava mai qualcosa di buono per festeggiarlo, la suora ispezionò ancora una volta le riserve della povera cucina, non era rimasto quasi niente per il pranzo di Natale, ma Ughetta ebbe un’idea, prese della pasta che aveva preparato per il pane, aggiunse delle uova, le ultime rimaste, dello zucchero e del burro, poi trovo nella dispensa dell’uvetta e qualche candito e delle spezie, aggiunse anche quelle. Lavorò bene l’impasto, gli diede la forma di una grossa pagnotta, con il coltello tracciò poi una croce sulla superficie del dolce e lo mise in forno. Quando il dolce fu pronto la giovane suora ebbe una sorpresa, cuocendo si era innalzato a forma di cupola e la croce sulla superficie si era spaccata formando un rilievo. Il giorno dopo era Natale suor Ughetta portò in tavola il dolce, che tra esclamazioni di gioia in poco tempo non rimase che poche briciole. La fama del convento e del dolce di suor Ughetta si sparse e la cucina del piccolo convento cominciò a lavorare a pieno ritmo per soddisfare le richieste del dolce tanto decantato.

UNA FLEBILE SPERANZA

di Alessandro Bocci
Anni fa, nel libro “Notte a Caracas”, Karina Sainz Borgo, in chiave parzialmente autobiografica, descriveva la fuga di una giovane donna dalla capitale venezuelana. Quella donna riuscì a raggiungere Madrid, lasciandosi alle spalle un paese devastato dagli squadroni della morte filocastristi, i Figli della Rivoluzione, che operavano agli ordini di Hugo Chavez, il Comandante Presidente.
Rimasto al potere fino alla morte, come ogni tiranno che si rispetti, Chavez venne sostituito, nel 2013, da Nicolas Maduro, che continuò ad applicare le teorie del “Socialismo del XXI secolo”.
Oggi il Venezuela, paese estremamente ricco di petrolio, di gas naturale e di altre importanti materie prime, è ridotto in uno stato di povertà diffusa, per acquistare il pane occorre la tessera annonaria, e i risultati elettorali sono regolarmente alterati in favore di Maduro. Non a caso, a livello internazionale, il Venezuela è sostenuto da Russia, Bielorussia, Cuba, Corea del Nord, Repubblica Sudafricana.
In questo quadro l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace, “per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”, alla politica venezuelana Maria Corina Machado, già insignita nel 2024 del Premio Sacharov per la libertà di pensiero dal Parlamento europeo, è una bella notizia.
Laureata in ingegneria, la Machado è una donna di ispirazione cristiana e si è più volte espressa in favore delle liberalizzazioni economiche. Per quanto concerne le politiche scolastiche, vorrebbe permettere, tramite l’introduzione di un sistema di sussidi, alle famiglie di poter scegliere tra istruzione pubblica e privata.
Accusata da Maduro di cospirazione contro la patria, la Machado rischia di essere incarcerata. Di lei si continua a parlare molto poco ed è facile immaginare che se i suoi convincimenti ideali fossero stati diversi sarebbe un simbolo femminile della battaglia per la democrazia nei paesi del Sud del mondo.
L’auspicio è che l’attribuzione del Premio Nobel alla Machado favorisca un maggior coinvolgimento della comunità internazionale nelle vicende venezuelane. La Notte, a Caracas, ha significato morte, terrore, tortura, espropriazioni, povertà. L’alba deve tornare a sorgere il prima possibile.

IL FAMEDIO DI MILANO TRA CURIOSITÀ E LEGGENDE

di Giorgio Righetti
IL CIMITERO MONUMENTALE DI MILANO fu progettato dall’architetto Carlo Maciachini nel 1863, anno in cui il suo progetto fu dichiarato vincitore in un concorso bandito dal Municipio di Milano per la realizzazione del Nuovo Cimitero Monumentale che doveva sostituire i vecchi cimiteri periferici. I lavori di costruzione del Famedio iniziarono nel 1864 e il cimitero fu ufficialmente inaugurato il 2 novembre 1866 sebbene incompleto con una solenne cerimonia dal sindaco di Milano Antonio Beretta (primo sindaco della Milano postunitaria) e da monsignor Antonio Calvi che benedisse il cimitero e il primo defunto che ebbe “l’onore della inaugurazione” – se così si può dire – il giovane e bravo musicista Gustavo Adolfo Noseda, di 27 anni che stava per debuttare alla Scala e che già da qualche anno dava dei concerti di musica classica a casa di amici e del padre banchiere. Il Tempio Crematorio al Monumentale, venne invece inaugurato otto anni dopo dallo stesso fondatore, l’oriundo svizzero Alberto Keller, industriale cattolico di successo e commerciante nel ramo della seta, volato in cielo dopo una breve malattia, il quale aveva finanziato l’edificazione del Tempio Crematorio e che volle così dare, sicuramente senza nessun entusiasmo, per primo il buon esempio di essere cremato proprio li. Una delle tante leggende del Famedio vuole che l’anima di Alberto Keller dopo la cremazione, iniziasse a vagare all’interno del cimitero e spaventasse i visitatori. Leggende certo ma che hanno fatto sì che dagli anni ‘70 il Tempio Crematorio finisse in disuso. ll Famedio divenne in breve tempo la più ricca esposizione di arte funeraria in Italia, ma più aumentavano i monumenti più diminuiva lo spazio per i suoi futuri ospiti, così nel 1895 si dovette aprire il Cimitero di Musocco, senza una partecipazione molto gioiosa dei suoi prossimi clienti, ma sicuramente più cimitero, dove si andava per pregare e, non un luogo pubblico destinato al commercio.
2 NOVEMBRE. “I MORT” come dicono a Milano, i cimiteri diventano sacri, coperti di fiori, illuminati da mille ceri, poiché in tutti è molto sentito il culto dei morti. 2 Novembre giorno triste di memorie e di ricordi. “Sarete voi ciò che noi siamo adesso”. “Chi si scorda di noi, scorda se stesso”, si legge sul frontone dell’ossario del “Fopponino” alla Porta Magenta, particolarmente ricca di storia e, questo monito si adatta a questo giorno più che mai. Ai cimiteri si recano i parenti dei defunti, con fiori e fiammelle, e ovunque crisantemi i “Sancarlitt”, come vengono chiamati a Milano, esprimono il sentimento dei vivi per i cari defunti. L’È EL DÌ DI MÒRT, ALEGHER, è il titolo di una famosa lirica di Delio Tessa: ALEGHER di sicuro, malgrado la tristezza del giorno, perché oggi c’è un pranzo fantastico: zuppa di ceci, tempia di maiale lessata con contorno di sottaceti; formaggio grana, vino dolce, e alla fine il dolce della ricorrenza il pane dei morti. Oggi la mamma raccoglie i figli intorno a un piatto di castagne fumanti e, si recita il rosario. E sembra che per qualche istante le anime dei cari morti ritornino nelle nostre case e rivivano con noi un po’ di quella vita che fu loro e che fu nostra. In questo giorno quando la nebbia scende tra le piccole croci si vedono brillare nei vecchi cimiteri migliaia di fiammelle, tremulano come fuochi fatui e pare che nel silenzio si diano una voce. E la notte scende mentre tutte le fiammelle si consumano sussurrandosi forse l’un l’altra il proprio dolore.
Nella foto: 2 Novembre 1866. Inaugurazione del cimitero Monumentale di Milano.

CHI DECIDE COSA È GIUSTO E COSA È SBAGLIATO? LE MIE DUE CULTURE E LA PAURA DEL DIVERSO
di Nurgül Çokgezici
Siamo noi, esseri umani, a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non esiste una verità universale, ma solo regole create e imposte da una società che, spesso, si illude di essere più giusta delle altre. In realtà, dietro ogni norma morale si nasconde la storia, la cultura e la paura di un gruppo umano.
Lo dico partendo da me stessa. Mi sono sposata a diciotto anni, troppo presto per capire davvero cosa fosse la vita. Sono cresciuta a Milano, dai nove anni in poi, sospesa tra due mondi: quello curdo e quello italiano. Due universi che parlavano lingue diverse, pensavano in modi diversi, eppure condividevano un medesimo bisogno: quello di sentirsi al sicuro.
Ciò che mi ha spinta a un matrimonio così precoce non è stata l’ingenuità, ma il peso delle tradizioni che accompagnano tante famiglie migranti. Noi immigrati ci aggrappiamo con forza alle nostre origini, non perché siamo “arretrati”, come spesso veniamo descritti, ma perché abbiamo paura. Come ogni essere umano che lascia la propria terra, temiamo la novità, il cambiamento, il rischio di perderci in ciò che non conosciamo.
E questa paura non è solo nostra. Come noi diffidiamo dei “locali”, anche gli autoctoni hanno paura di noi. È un istinto primordiale: ogni creatura tende a difendere il proprio territorio, il proprio equilibrio. Ma a volte, questa difesa diventa autodistruzione. Come nel mio caso, quando la mia famiglia, credendo di proteggermi, mi ha fatta sposare da giovanissima.
Oggi la società è cambiata. Essere separati o risposarsi non è più uno scandalo, come lo era quindici anni fa, quando ho divorziato per la prima volta. Anche nella mia comunità curda qualcosa si è mosso: ciò che un tempo era considerato una vergogna oggi è più accettabile. Forse, nel mio piccolo, ho contribuito a questa trasformazione.
Ma la strada è ancora lunga. Insegno in una scuola dove incontro studenti e studentesse provenienti da molte parti del mondo: Pakistan, Siria, Afghanistan, Marocco. Le loro storie si somigliano. Proprio ieri ho parlato con una studentessa musulmana, arrivata in Italia da bambina, quella che in sociologia si definisce una “1.5 generazione di immigrati”. Mi ha confessato di essersi innamorata di ragazzi italiani o di altre nazionalità, ma mai del suo stesso paese. Quando le ho chiesto se i genitori lo sapessero, ha risposto: “No, prof, se lo scoprissero, succederebbe un disastro.”
Quel dialogo mi ha fatto riflettere. Nonostante il tempo trascorso, le barriere culturali resistono. Cambiano le leggi, si modernizzano le città, ma la mentalità resta spesso ancorata al passato. È per questo che oggi più che mai serve il lavoro dei mediatori interculturali e interreligiosi: figure capaci di costruire ponti, di creare fiducia, di spiegare che la diversità non è una minaccia ma una ricchezza.
Sabato scorso, durante una lezione, ho chiesto ai miei studenti quanti di loro volessero restare in Italia e quanti invece desiderassero andarsene. Il 90% ha alzato la mano per dire che vorrebbe lasciare il Paese. È un dato che colpisce. Forse indica che viviamo in un mondo sempre più globale, dove i giovani sognano di esplorare, di conoscere l’altro, di uscire dai confini.
Eppure, la storia ci insegna che l’umanità avanza e regredisce allo stesso tempo. Siamo una civiltà con oltre diecimila anni di storia, ma non credo che siamo più evoluti dei Sumeri, degli Ittiti o dei Babilonesi. Nemmeno delle comunità preistoriche di Göbekli Tepe, scoperte solo di recente. Cambiano i mezzi, ma l’uomo resta lo stesso: fragile, impaurito, desideroso di potere e di amore.
Alla fine, ciò che dobbiamo imparare, o forse reimparare, è insegnare ai nostri figli ad accettare l’altro. A capire che non siamo poi così diversi come crediamo.

CENERE, ACQUA E DIGNITÀ: IL LAVORO DEI LAVANDAI NELLA VECCHIA MILANO

di Angelo De Cristofaro
All’inizio, a Milano, furono gli uomini a lavare i panni per conto delle famiglie benestanti. Esisteva persino una Confraternita dei Lavandai, già nel Settecento, che organizzava il lavoro: raccoglievano la biancheria di casa in casa, la portavano lungo i navigli e la restituivano pulita. Non a caso, il vicolo sul Naviglio Grande porta ancora oggi il nome di Vicolo dei Lavandai, al maschile.
La Confraternita dei Lavandai di Milano nacque nel XVII secolo e riuniva i lavandai e le lavandaie che lavoravano lungo i Navigli. Il loro compito era lavare e candeggiare i panni delle famiglie milanesi agiate, spesso in condizioni faticose, poco salubri e pericolose date le numerose cadute nel naviglio. Aveva sede nella chiesetta di Santa Maria delle
Grazie al Naviglio, nei pressi di San Cristoforo, ed era posta sotto la protezione di Sant’Antonio da Padova, scelto come patrono. Oltre ad avere una funzione religiosa e devozionale, la confraternita serviva anche a garantire mutuo soccorso tra i membri: aiutava i confratelli in difficoltà, organizzava funerali e momenti comunitari.
Ogni settimana la città seguiva un ritmo preciso. Il lunedì gli uomini giravano coi carri a ritirare i capi che erano già stati portati nelle portinerie, mentre i garzoni correvano tra le vie gridando “s’cenderèe, s’cenderèe…”, chiedendo la cenere dei camini spenti. Era un ingrediente prezioso per la liscivia, che rendeva candide le lenzuola e brillanti le federe. Nelle case, vicino al focolare, c’era sempre la “tabella della lavandera”, una lavagnetta su cui si annotavano i capi consegnati: i “bragh” (pantaloni), le “fodrette” (federe), la “pedãgn” (gonna), la “sôca” (sottana), i “fregoni” (strofinacci), gli “àbet” (abiti), la “vestina” (abitino da bambina), i “bindell” (nastri e fasce), i “bratei” (bretelle), i “ciapin” (presine), la “cappòtta” (mantello), gli “scalfarott” (calzettoni di lana), il “tüin” (giacca corta da uomo), il “gilé” (panciotto), la “blüsg” (blusa da operaio), il “golettone” (un grande scialle di lana).
Nei lavatoi, uomini e poi via via sempre più donne, si inginocchiavano protette dal tabàr , il mantello da lavoro, davanti al “brellin” o “âsa”, una cassettina di legno che conteneva un cuscino dove le lavandaie si inginocchiavano per lavare. Sull’ angolo di vicolo lavandai, c’è un ristorante adesso. Si chiama “El Brellin” che anticamente era il negozio del paltonatt, il venditore di sapone, liscivia e tutto quanto serviva alle lavandaie.
La pietra inclinata, dove sfregare i panni, era la prea. Per la prea si scatenavano violenti litigi, risolti a colpi di panni bagnati. Infatti ogni lavandaia sceglieva la prea che dava, a suo giudizio, i migliori risultati di lavaggio. Esiste un proverbio che recita “la cattiva lavandera troeva mai la prea giusta” a significare che una cattiva lavandaia otteneva risultati di lavaggio pessimi, e ne incolpava la prea che non andava bene. Vicino c’erano la “sidela” (il secchio) e il “sigiun” (il mastello). Con le mani immerse nell’acqua gelida, usavano il “paltun”, una miscela di cenere, liscivia e talvolta sterco di vacca, per sgrassare i tessuti. Purtroppo erano le ginocchia ad essere a rischio, il famoso ginocchio della lavandaia era un ginocchio disastrato da affezioni reumatiche determinate dall’appoggio su superfici fredde e umide.
Il martedì era ancora dedicato a sciacqui e bolliture in mastelli pieni di acqua bollente con soda da bucato. Nel vicolo all’interno del civico 6 c’era una grande centrifuga in cemento con braccio a molla.
Il mercoledì, se il tempo era bello, i prati diventavano un mosaico di lenzuola e abiti stesi al sole; d’inverno, invece, si ricorreva a grandi stanze riscaldate. Giovedì mattina, all’alba, ogni indumento era piegato, diviso per famiglia e caricato sui carri. Dal giovedì pomeriggio fino al sabato, i lavandai si occupavano degli alberghi, che pretendevano la pulizia due volte alla settimana.
Nel 1901 un censimento registrò oltre 3.600 persone impegnate in questo mestiere, con giornate di lavoro che potevano arrivare a venti ore. Erano uomini, donne, giovani garzoni: tutti piegati sul bucato. E solo la domenica, finalmente, le mani screpolate, i ginocchi doloranti e i corpi stanchi potevano fermarsi.

C’ERANO UNA VOLTA LE SCOPE

di Luigi Filipetto
Uno arrischia di passare per nostalgico dei tempi che furono. I tempi cambiano si usa dire. Se in meglio o in peggio, anche qui dipende dall’età di chi giudica.
Prendiamo la scritta di un negozio che resiste ancora. Ma con le saracinesche abbassate da oltre vent’anni. Prendiamo anche il portinaio di quel numero civico che ora, con la mano sinistra in tasca e la destra sul soffione, non raccoglie le foglie e le carte dal marciapiedi ma le sospinge sulla strada. Poi passerà il camion dell’AMSA che raccoglierà tutto. Non c’è più posto per la scopa nella sua portineria.
Andiamo a quei tempi e alle scope che riempivano le case, le stalle, i cortili. Veniva l’autunno, nelle stalle di sera uomini e donne se la raccontavano mentre le mani esperte adattavano la lunghezza e la resistenza dei rami di saggina, li sagomavano a forma di scopa e le donne muovevano abili le dita e intrecciavano i fili dei gomitoli di lana. Ah, le pecore generose! Da noi veneti di quelle serate si diceva fare filò.
Certo che, a parte tutto, le scope duravano fino all’autunno successivo e anche oltre. I soffioni odierni dopo qualche mese non trovi più nessuno che li ripara se non funzionano, trovi chi te ne vende uno nuovo.
Oggi ho saputo di un sondaggio sulle nascite degli ultimi tempi. Un calo preoccupante. Problemi di soldi? Rivedere la politica sui migranti che assicurano figli a non finire? I migranti che pare siano in grado di sostenere l’Italia con le loro braccia, visto che, come dicono, in giro non c’è più voglia di lavorare? Chi ha fatto della cancellazione dei migranti il problema della sua sussistenza, non lo dice ma ci pensa. C’è di mezzo però anche il problema dei cagnolini. Tenuti al guinzaglio non solo da chi ha superato la verde età ma anche da chi è nel pieno dei verdi anni, addirittura scarrozzati sui passeggini e sui seggiolini delle bici e che hanno spodestato i neonati bipedi un tempo detentori di questa prerogativa. A quando un sondaggio su questo squilibrio gerarchico?
Piagnone eh? Prima di chiudere però c’è una cosa che proprio non mi va giù. Va bene, i neonati residui sono portati ancora nei loro passeggini. Ma come accessori. I rimorchiatori procedono lentamente e con solennità con il cellulare incollato all’orecchio. E non lo staccano neanche se battono il piede contro una radice.

ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

di Giacomo Pio Augello
Ai miei cari – moglie, parenti, amici, compagni di allenamento, colleghi di lavoro. Avete arricchito la mia vita. Spero di poter arricchire la vostra.
Questo mese di ottobre vedrà il debutto al cinema e su Netflix del “Frankenstein” di Guillermo del Toro.
Ricordo che, quando uscì la notizia, lessi su “Coming Soon” che il film sarebbe stato: “Una storia di genitori e figli. Non un horror.”
Quel titolo mi rimase talmente impresso che mi portò a chiedermi: “Che cos’è la famiglia?”
E soprattutto: “Che cosa fa famiglia?”
Queste domande potrebbero sembrare banali perché il fenomeno di bambini concepiti all’interno di un gruppo di persone uniti da legami parentali, chiamato famiglia, è talmente diffuso da sembrare ovvio.
La realtà, però, è molto più complessa e molto meno scontata.
Ma andiamo con ordine.
La famiglia, in senso ampio, è l’elemento fondamentale di ogni società, il luogo dove la vita nasce e si trasmette (Enciclopedia Treccani).
Se, però, ci si chiede che cosa fa di un gruppo una famiglia, bisogna distinguere tra scienza e diritto.
Come insegnavano i personaggi di “Esplorando il corpo umano”, una famiglia si forma quando due esemplari della stessa specie e di sesso opposto si accoppiano per generare un loro simile.
Questo significa che, biologicamente, l’elemento fondamentaleper la costituzione della famiglia è il sangue.
Il diritto, invece, in particolare l’art. 29 della nostra Costituzione, fonda la famiglia sul matrimonio.
Orbene, combinando le due prospettive, si può concludere che una famiglia si forma quando un uomo e una donna si sposano e danno alla luce un figlio e/o una figlia.
Qualche volta è così.
E qualche volta no.
E a ricordarlo è proprio la legge.
La legge sull’adozione (L. 184/1983) disciplina la difficile procedura di dare una casa a tutti quei bambini che non hanno una famiglia che li accolga.
La normativa che disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita (L. 40/2004) tutela il diritto delle coppie sposate che non possono procreare naturalmente, ma che meritanocomunque una possibilità di diventare genitori.
La Legge Cirinnà (L. 76/2016), infine, tutela i diritti di chi, pur dello stesso sesso o senza voler matrimonio, desidera costituire una famiglia con la persona che ama.
I fatti di cronaca, anche piuttosto recente, di figli che uccidono o tentano di uccidere i genitori, di madri che sopprimono i loro stessi bambini, eco moderna della Medea di Euripide, di fratelli che si fanno la guerra per spartirsi l’eredità (La roba, come avrebbe detto Giovanni Verga) e, cosa ancora più inquietante, di figli che si ritrovano a fare da genitori a coloro che li hanno generati (il film “Per te” appena uscito parla proprio di questo), mostrano alla comunità la crisi della famiglia così come si crede di conoscerla.
La domanda, allora, diventa: “Cosa fa davvero famiglia?”
Io, grazie alla mia scuola di arti marziali, credo di avere trovato una risposta.
E ora voglio condividerla con voi.
Soprattutto con chi, come me, lavora in un ambiente strutturato e trascorre la maggior parte del tempo con altre persone estranee al proprio nucleo familiare.
Da quando iniziai a praticare, scoprii che ogni lezione era preceduta dal rituale di preparazione della sala.
Per prima cosa, montavamo il tatami tutti insieme.
E poi ognuno contribuiva a rendere l’ambiente “marziale”.
Chi sistemava l’altare, chi prendeva l’attrezzatura, chi sgombravala sala da oggetti inutili.
Poi si iniziava.
Tutti insieme spingevamo al massimo delle nostre forze,sostenendoci l’uno con l’altro nel sopportare i massacranti allenamenti cui il Maestro ci sottoponeva.
Il risultato era la creazione di un legame fatto di sudore, passione, impegno, determinazione, ma anche gioia e divertimento.
Un legame forte come il sangue e sacro come il matrimonio.
E, davanti a tutti noi, a ispirarci, a guidarci, a curarci, a farci vedere come si fa a costruire una famiglia, c’era sempre lui: il Maestro.
Che si allenava con noi, faticava con noi, soffriva con noi.
Ci dava l’esempio.
In definitiva, posso dire che, la frequentazione di questa scuola mi ha insegnato che ciò che fa davvero famiglia è la stessa forza che “move il sole e le altre stelle”, per dirla con le parole di Dante: l’amore.
L’amore per ciò che si fa, per l’ambiente in cui si opera e per le persone che lo vivono insieme a te.
Tutto questo ci fece famiglia.
Fratelli, sorelle, zii, padri e figli.
Ad alcuni di loro, la vita concede le ali.
E li trasforma in angeli.
Persone che, quando te lo meriti, ti colpiscono duro “che neanche una madre è così” (per citare i Pooh), ma che ti circondano per condividere con te il peso di un dolore insopportabile e che, in certi casi, possono arrivare ad aprire il cielo (e io l’ho visto accadere).
Come lo so?
Perché l’ho imparato da esperienze esterne alla scuola, in cui, però, ho ritrovato gli stessi principi e le stesse dinamiche.
Me lo ha insegnato l’ostinata generosità di un amico che mi ha scarrozzato in giro per anni perché non avevo i soldi per la benzina.
Me lo ha insegnato la genuina complicità di un gruppo di ragazzi che mi ha accettato come uno di loro e mi ha regalato momenti di deliranti felicità donandomi la forza di affrontare i miei guai.
Me lo ha insegnato l’amore di quella ragazza che poi ho sposato,che mi ha scelto quando non avevo niente da offrirle tranne il mioamore.
Me lo ha insegnato l’amico della vita, che mi ha raggiunto ovunque fossi e non mi ha mai lasciato solo.
E me lo hanno insegnato gli occhi scintillanti di un bambino quando, sapendo che ero a lezione per lui, mi ha stretto in un abbraccio così forte da disintegrare l’angoscia che mi opprimeva il cuore.
Ecco, io devo ad un allievo, che mi ha scelto come guida, la gioia di avere amato come un padre.
Anche il mio attuale posto di lavoro me lo ha insegnato.
Perché, quando fui presentato ai Colleghi, mi si disse: “Questa è la famiglia”.
Come tale mi hanno trattato.
E come tali li ho trattati a mia volta.
Vedete come, alla fine di questa analisi, possiamo dire che la parola di cui abbiamo parlato:
si scrive “Famiglia”. Si legge “Insieme”.
Perché “Insieme” è tutto quello che serve per fare la famiglia.
E poco importa se chi vi guarda dall’esterno vi giudica strani o eccentrici.
Questo me lo ha insegnato una persona che mi ha amato come un figlio, perché, quando da bambino le dicevo: “E ma gli Addams sono strani”, mi rispondeva sempre: “Sì. Però si vogliono bene.”
Al prossimo numero.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.15

di Fabio Fumagalli
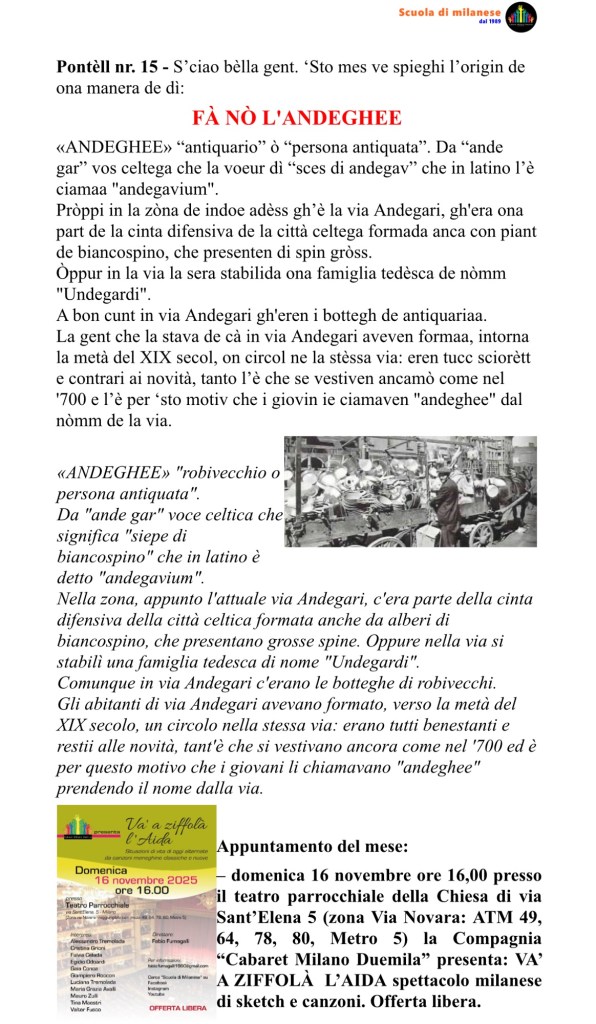

I FEEL FOOD
Pubblichiamo volentieri quanto fattoci pervenire da Annalisa Fattori e Paola Nobile di Delos-Servizi per la cultura di Milano.
Parte in occasione in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il progetto di edutainment I Feel Food promosso dal National Biodiversity Future Center (NBFC), primo centro di ricerca nazionale sulla biodiversità.
L’iniziativa coinvolge circa 300 studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio nazionale, per sensibilizzare sul legame tra alimentazione sana, sostenibilità e tutela della biodiversità.
Dai quiz interattivi ai laboratori di coprogettazione, lo scopo è quello di promuovere un consumo responsabile attraverso linguaggi e format adatti ai giovani.



EL DONDINA. UN PERSONAGGIO AVVOLTO DAL MISTERO

di Giorgio Righetti
Negli ultimi decenni dell’Ottocento la delinquenza Meneghina costituiva un grosso problema al punto che alcuni quartieri non erano accessibili neanche alla polizia a meno di non avere il coraggio dell’appuntato Carlo Mazza sopranominato “el Dondina” che andava dove voleva ed era lui a mettere paura. Per quanto fosse di statura sotto la media era dotato di una forza formidabile, le sue mani sembravano tenaglie d’acciaio, il suo pugno un maglio. I teppisti avevano più paura di questo omiciattolo che di tutti i “ciappa, ciappa” (questurini) di Milano e manifestavano apertamente lo sdegno per il suo modo di camminare dovuto probabilmente a un difetto fisico ma per i borsaioli, i teppisti e la popolazione ladra del Tivoli era conseguenza del gran bere e quando compariva ridicolizzavano la sua andatura con questa canzone.
El Dondina quand l’è ciôcch
el va attorna a ciappà i lôcch
e je me menna a San Vittôr
a vede quant’hin i òr.
L’è la vuna – l’è. I dò
el Dondina l’è atorna an’mò.
Sona i tre, e sona i quatter,
el Dondina l’è a teater,
e sona i cinq e sona i ses,
el Dondina l’è andrèe a bev,
e sona i sett e sona i vott
el Dondina l’è sul casot.
Tra la mala milanese il nome Dondina, era sinonimo di castigo, Carlo Mazza conosceva perfettamente il gergo della mala, il suo regno era tra i “locch”, veri e propri delinquenti, esperti nel’usare “el maresciall”, il coltello ricurvo tenuto in tasca dalla “mala”, tra i ”forlinn”, i venditori ambulanti che non disdegnavano il furto e la truffa, tra i “tirador de spada”, i vagabondi che chiedevano la carità, e intanto sfilavano il portafoglio dalla tasca dei malcapitati e, tra i tipi loschi e ambigui della locanda del Berrini. Nato e cresciuto in mezzo allla Ligera capiva subito il nascondiglio dei delinquenti e dove andare a prenderli. Quando metteva le manette a qualche ladro e questo lo chiamava col suo vero cognome “scior Mazza” lui che era un po’ balbuziente rispondeva: “A… che.. che ades mi sono el… el scior Mazza vera? Ma quand te set foeura di me ong a… allora sì che… che… sont el Dondina”. (Adesso sono il signor Mazza vero, ma quando sei fuori dalle mie grinfie, allora si che sono el Dondina). Durò più di trent’anni il suo vigile vagabondare di giorno e di notte. Compariva sempre in mezzo ai Lôcch, quando meno se lo aspettavano, ove vi fosse una rissa, un furto, qualcosa di irregolare, era acuto pronto nell’intuire, incorruttibile, il dovere era la norma costante della sua vita, era illletterato per questo non fece mai carriera, rimanendo un semplice appuntato. Aveva confidenti in ogni ramo della malavita e quindi riusciva a mettersi sempre sulle tracce dei colpevoli. Le più delicate indagini sui delitti più oscuri erano affidate sempre a lui. Il suo metodo era quello di usare una delinquente per snidarne un’altro, additava le persone sospette di reato e diceva: “Che vun, ch’eee duuu, cheee triii, via con mi”. E bisognava seguirlo al Santa Margherita, il Carcere della Questura, demolito nel 1864 per far posto alla Galleria Vittorio Emanuele. Cambiati i suoi superiori l’indipendenza del Dondina venne annullata, incominciarono a trovare assurdo che un agente che non sapeva neanche l’alfabeto e parlava solo il dialetto milanese fosse tenuto in considerazione, poi introdussero il sistema che il subalterno non doveva avere segreti con i superiori, pretendendo i nomi dei suoi informatori, el Dondina rifiutò gli sembrava di tradire. Fu collocato in pensione dopo quasi quaranta anni di servizio con trentasei lire al mese. Dopo avere salvaguardato la società dai malviventi “El scior Dondina”, aspettava la conclusione della sua vita in una misera soffitta di via Borromei. Le proposero di scrivere le sue memorie, ma el Dondina non sapeva scrivere e la sua memoria aveva perduto la forza di una volta e non sapeva più racappezzarsi di nulla. Morì in miseria dimenticato da tutti assistito dalla moglie, una donna che si rendeva utile a tutto il vicinato con piccoli servizi ricevendo modesti compensi.
P.S. El Dondina ha ispirato molti scrittori, diventando protagonista di romanzi di fantasia, ma le scarne notizie su El Dondina che arrivano a noi sono documentate solo da tre giornalisti. Dallo scapigliato Giuseppe Rovani, in ”Cento anni” (1859) un romanzo ciclico in cui convivono trama romanzesca, discressioni storiche e inserti saggistici; da Francesco Giarelli, che nel suo “Vent’anni di giornalismo” edito nel 1896 ne traccia un bellissimo e amaro ritratto e da Paolo Valera in “Milano sconosciuta” (1879) una raccolta di 11 reportage giornalistici romanzati. Tutto il resto è qualcosa privo di dettaglio e completamente inventato.

LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO

di Giorgio Righetti
Robusta e alquanto grintosa, caparbia a volte scostante, animata da un evidente ma celata antipatia per i bambini che disturbavano in cortile fuori dagli orari stabiliti, la portinaia è stata un’istituzione autenticamente milanese, non solo una custode, ma una confidente dell’ordine, provvidenziale per gli anziani e le persone sole, sempre molto rispettosa con gli adulti e nello stesso tempo sbrigativa con i bambini e i ragazzi. Abitava in un piccolo locale in un rientro dell’abitato, subito dopo la porta di ingresso, prima dell’inizio delle scale. Oltre la portineria prima della rampa delle scale esisteva quasi sempre un ampio cortile, dove si radunavano furtivamente i ragazzini che con il loro comportamento la facevano disperare. Il tono perentorio della sua voce con loro era un ordine che non si poteva ignorare. Se aveva un marito questo era sempre fuori casa e lo si poteva trovare nella vicina osteria. La nostra portinaia, delegava a lui qualche incombenza, per poter accudire meglio alla pulizia dello stabile. La vera passione della portinaia era quella delle chiacchiere, esuberante, linguacciuta, sapeva sempre i fatti di tutti e non solo degli inquilini, ma anche quelli del rione. Consapevole dell’importanza del suo ruolo, chiacchierava con il postino sempre in milanese, interessata alle notizie della zona, distribuiva la corrispondenza leggendo e borbottando con tono di malcontento tutte le cartoline. Un’altra passione della portinaia era per i gatti, in Estate nelle ore più calde del pomeriggio dopo una mattinata di duro lavoro stanchissima era facile vederla addormentata su una sedia davanti alla guardiola con qualche gatto vicino, in realtà era una vigilanza costante bastava che qualcuno si avvicinasse perché aprisse di colpo gli occhi per vedere cosa stava succedendo. Ho voluto in questa breve cronaca prendere spunto della mia vecchia casa, perché così erano quasi tutti i caseggiati della Milano anni Cinquanta. Oggi le case con i cortili, sono quasi tutte scomparse, le rampe delle scale sostituite dagli ascensori. La portinaia custode di tutti i segreti del condominio, rimpiazzata purtroppo da soluzioni tecnologiche.

IL TEMPO DELL’ODIO

di Alessandro Bocci
Quel medesimo sentimento di odio che aveva partorito Auschwitz, il gulag, il maoismo e il fondamentalismo islamico sembra oggi riaffermarsi nella forma dell’annientamento fisico e morale di chi la pensa diversamente.
Negli Stati Uniti, all’indomani del barbaro assassinio di Charlie Kirk, l’influecer fondatore di Turning Point, percentuali significative di elettorato repubblicano e democratico ritengono che il ricorso alla violenza nei confronti degli avversari politici sia inevitabile. In Italia, riferendosi a Kirk, Roberto Saviano ha dichiarato: “ Non riesco ad accordarmi al coro morale di chi dice che ogni vita va rispettata”.
Nel saggio “La società aperta e i suoi nemici”, Karl Popper riteneva la tradizione storicista, iniziata da Platone, arricchita da Hegel e portata al suo apice da Marx, la madre di tutti gli autoritarismi e la nemica di ogni libertà. Una corrente filosofica, dunque, anche giustificatrice della violenza politica.
La senatrice Liliana Segre, oggetto in questi mesi di vergognose campagne antisemite, sostiene che nel momento nel quale si concede il passaporto alle parole si autorizzano anche i fatti, le azioni. Un ragionamento, quello della Segre, che evidenzia come la violenza verbale possa trasformarsi facilmente in incitazione all’aggressione fisica. Siamo lontani anni luce dal Saviano pensiero.
Occorre allora riflettere sulla circostanza se le parole d’odio debbano essere sempre considerate come libertà di espressione e se i mezzi che potrebbero essere utilizzati per contrastarle non siano, in realtà, peggiori dello stesso male.
È difficile mettere in discussione la libertà di espressione, ma quest’ultima, come anche la satira ingiuriosa, non può non aver limiti.
Anche pensando a quello che accade sui social, accanto all’introduzione di severe sanzioni penali, le attuali sono ridicole, occorrono classi dirigenti e forze politiche che sappiano promuovere battaglie culturali contro il virus dell’odio.
Molto probabilmente, se guardiamo al progressivo affermarsi, in Europa e negli Stati Uniti, di estremismi, fanatismi e radicalismi di ogni tipo, c’è troppo poco per poter essere ottimisti.
Sul quotidiano “Il Foglio”, il saggista e studioso Michele Magno ci ricorda al riguardo le parole che Eugenio Montale aveva utilizzato in un verso di una sua poesia: “un imprevisto è la sola speranza”.
Purtroppo, è davvero così.

SUL FRECCIAROSSA CON FANON: QUANDO IL COLONIALISMO RISUONA IN BUSINESS CLASS

di Nurgül Çokgezici
Stavo leggendo I dannati della terra di Frantz Fanon, proprio il passaggio in cui il pensatore martinicano scrive del colonizzato che “invidia” il colono, quando un ricordo mi è tornato prepotente alla mente. Era un pomeriggio di qualche anno fa: io e la mia amica africana, entrambe mediatrici linguistiche e per la Prefettura di Bologna, tornavamo a Milano sul Frecciarossa, biglietti business class pagati dall’amministrazione. Eravamo stanche ma felici di sederci comode, tra giacche eleganti e laptop aperti.
Con noi viaggiava un ingegnere di una nota compagnia petrolifera, reduce,come si vantava, da lunghi progetti in Nigeria. Dopo le prime frasi di circostanza, la conversazione scivolò inevitabilmente sull’immigrazione. Gli dicemmo che eravamo meditarci presso la Commissione territoriale. Notai subito un cambio d’espressione sul suo volto, un fremito che la mia amica africana colse allo stesso modo: fastidio, forse stupore, come se due “immigrate” non avessero diritto a quel sedile.
Quel microsegno mi riportò alla teoria di Fanon: il disagio del dominante di fronte al colonizzato che esce dal margine e occupa spazi simbolici di prestigio. Glielo dissi senza mezzi termini: “Dà fastidio vedere immigrati in business class, vero? Dà fastidio quando gli ultimi non restano ultimi.”
Il discorso degenerò quando lui ricorse al vecchio argomento della “missione civilizzatrice”: “Gli africani ci devono molto: strade, asfalto, sviluppo. Senza di noi non avrebbero mai sognato tanto.” Lo interruppi: “Questo non è progresso, è spoliazione. L’umanità è condivisione, non lasciare briciole dopo aver portato via il petrolio.”
Mentre cercava di recuperare la sua posizione di potere, tentò anche un approccio personale nei miei confronti. Lo rifiutai con un sorriso e vidi la sua irritazione trasformarsi in rabbia: la maschera di cortesia si incrinò. Io e la mia amica africana decidemmo di alzarci, lasciandolo alla sua frustrazione. All’uscita gli dissi: “Per secoli avete snobbato noi, guardandoci dall’alto in basso. Io non lo faccio per vendetta, ma per restituirvi per un istante il sapore di ciò che abbiamo vissuto.”
Ripensandoci oggi, quel vagone non era solo un mezzo di trasporto: era un palcoscenico di storia. Fanon aveva ragione. Le catene non si vedono più, ma restano negli sguardi, nei discorsi che giustificano lo sfruttamento come dono, nelle microaggressioni che riaffiorano quando chi era escluso si siede allo stesso tavolo. La decolonizzazione non è un trattato del passato: è un gesto quotidiano, un posto a sedere conteso, una frase che spezza un silenzio troppo lungo.

CATTANEO E MILANO: ECONOMIA, LIBERTA’ E LA LEZIONE CHE PARLA AL PRESENTE

di Emanuela Maritato
Milano è spesso raccontata come capitale economica e innovativa d’Italia. Una città che corre, che attrae investimenti, che punta su università, startup, grandi eventi. Ma questa Milano moderna ha radici profonde, e una di queste porta il nome di Carlo Cattaneo, intellettuale milanese dell’Ottocento, spesso dimenticato nei manualima sorprendentemente attuale.
Cattaneo fu economista, politico, filosofo. Ma soprattutto fu un osservatore lucido della sua città: la Milano che si industrializzava, che apriva scuole tecniche, che cominciava a pensarsi come polo europeo. Per lui, l’economia non era mai fine a sé stessa, ma lo strumento per costruire una cittadinanza libera e consapevole. L’istruzione tecnica, il progresso scientifico, l’impresa moderna erano – a suo avviso – i veri pilastri della democrazia.
«Il popolo non è libero se non è istruito; e l’istruzione non deve essere privilegio di pochi, ma patrimonio di tutti.»
Il cuore del pensiero cattaneano era il federalismo: un’Italia costruita dal basso, da comunità autonome capaci di valorizzare le proprie risorse. Un’idea che oggi suona sorprendentemente attuale in un Paese dove la questione dell’autonomia regionale torna con forza al centro del dibattito politico. Per Cattaneo, l’efficienza economica e la buona politica nascevano sempre dalla responsabilità dei territori. Milano, con la sua tradizione mercantile e manifatturiera, era per lui il modello di una comunitàcapace di autogovernarsi.
Guardando all’oggi, Milano continua a misurarsi con le stesse sfide: crescere senza lasciare indietro nessuno, essere internazionale senza perdere la propria identità civica, attrarre capitali senza smarrire coesione sociale. Dal caro-affitti per studenti e giovani lavoratori, alla necessità di coniugare sviluppo immobiliare e sostenibilità, la città vive tensioni che Cattaneo avrebbe probabilmente letto come segnali della necessità di un equilibrio nuovo tra mercato, diritto e responsabilità collettiva.
Se c’è un lascito da riscoprire, è la convinzione cattaneana che economia, politica e diritto non possano viaggiare separati. Una città prospera non è solo quella che cresce nei numeri del PIL o del turismo, ma quella che investe in conoscenza, riduce le disuguaglianze e valorizza la partecipazione civica.
Nel cuore della Milano contemporanea – fatta di grattacieli, coworking, università che attraggono studenti da tutto il mondo – il pensiero di Carlo Cattaneo resta una bussola preziosa: ricordarci che il progresso, per essere vero, deve essere anche libertà condivisa.

MISURARE SE’ STESSO E MISURARSI CON SE’ STESSO
“Che cos’è il valore?”

di Giacomo Pio Augello
A M.C.
Ho voluto iniziare il mio nuovo articolo con questa domanda perché settembre è il mese che chiude la stagione estiva e apre il quadrimestre di fine anno.
Per molte persone, me compreso, questo è il periodo in cui si misura la propria capacità di essere utili per sé stessi e per la società.
Il “valore” è un tema che ha affascinato filosofi, sociologi e psicologi per l’influenza che i suoi diversi significati sono in grado di esercitare sul singolo individuo che sulla comunità.
Vista la vastità dell’argomento, ho ritenuto opportuno procedere per gradi.
Partiamo, quindi, dalla sua definizione.
Secondo enciclopedia Treccani, il valore, riferito alla persona, è il possesso di alte doti intellettuali e morali o alto grado di capacità professionale.
Sorge spontaneo chiedersi: “Come si può misurare la statura intellettuale, morale e professionale di una persona?”
Cos’ è che ci dà valore, insomma?
Per rispondere a questa domanda, la sociologia ha identificato il valore con lo status sociale e di riconoscimento all’interno della società.
Sotto questa prospettiva, i parametri di misura del valore sono relativi e variano da popolazione a popolazione, da paese a paese, da epoca a epoca.
Gli antichi eroi omerici, ad esempio, misuravano il valore di un guerriero dall’atto di spogliare il nemico ucciso sul campo di battaglia.
Ne è un esempio il Troiano Ettore che nel Sesto canto dell’Iliade prega Zeus che un giorno qualcuno dica di suo figlio Astianatte: “E’ molto più forte del padre. Quando verrà dalla lotta. Porti egli le spoglie cruente del nemico abbattuto, goda in cuore la madre”, mentre nel Sedicesimo canto, uccide il greco Patroclo e lo spoglia delle armi appartenute ad Achille.
Questa testimonianza letteraria dimostra che, fin dagli albori della civiltà, l’uomo ha avuto bisogno di darsi un metro con cui misurare sé stesso per trovare così il proprio posto nel mondo.
Gli esponenti della filosofia moderna hanno messo in discussione questa definizione di valore e hanno ritenuto che ogni persona, in quanto tale, possiede una dignità che gli spetta in quanto uomo e che prescinde da qualsiasi caratteristica particolare o merito personale.
Kant, in particolare, nella “Fondazione della metafisica dei Costumi” scrive che: “Nel regno dei fini, ogni cosa ha un prezzo e una dignità. Ciò che si eleva al di sopra del prezzo e che quindi non ammette eguali ha una dignità. Di conseguenza, la moralità e l’umanità, in quanto capaci di moralità, sono le sole cose che possiedono dignità”
Oggi, questo principio di pari dignità degli uomini in quanto tali,apre la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo all’ art. 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza ed è scolpito tra i principi fondamentali della nostra Costituzione all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali).
Esso risuona nelle coscienze di tutti con tanta forza da avere generato una consapevolezza etica diffusa che promuove l’uguaglianza e si esprime attraverso movimenti sociali per la dignità di tutte le categorie.
Ciò nonostante, il bisogno ancestrale dell’uomo di misurare sé stesso continua ad esigere di essere soddisfatto.
Ci si chiede, allora: in una società che riconosce e promuove l’uguaglianza e, in particolare, nel Nostro Paese che “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (Art. 11 Cost.)” quali possono essere i parametri con cui si può misurare il valore di una persona?
Se ci rifacciamo alla definizione sopradetta della parola valore, pare che gli unici metri idonei a misurarlo siano la produttività e la popolarità, preferibilmente sui social.
Ora, sarebbe una ingenuità identificare la causa di questo fenomeno semplicemente nell’idea diffusa che siamo schiavi di un sistema che pensa solo al profitto e che ci fa vivere in realtà alternative per tenerci buoni e trasformarci in pile per alimentarsi, come gli esseri umani coltivati nel film “Matrix”.
A mio avviso, la ragione è un’altra.
Se si osserva bene, ci si accorge che questi parametri, produttività e popolarità, appunto, sembrano misurabili perché forniscono numeri.
Danno, cioè, dati certi sull’ammontare delle ore di lavoro svolte, sulle somme depositate sul proprio conto e quindi sul proprio potere d’acquisto e nonché, attraverso i like, sull’indice di gradimento dei propri pensieri.
Diventa quasi naturale, allora, concludere che più alti sono questinumeri più si ha valore.
Se a ciò aggiungiamo il fatto, scientificamente provato, che le reazioni ricevute ai propri post stimolano la secrezione di dopamina, che è l’ormone del piacere, l’associazione con il valore diventa anche qualcosa di gradevole.
Pericolosamente gradevole.
Questo modello, tuttavia, ha delle pesanti conseguenze sia per il singolo individuo che per la comunità cui appartiene.
Sul piano individuale, infatti, collegare l’autostima al rendimento porta ad una profonda svalutazione di sé quando gli obbiettivi non vengono raggiunti e una eccessiva autocelebrazione quando gli standard vengono soddisfatti o, meglio ancora, superati.
La persona, insomma, vive costantemente sospesa “tra il tormento e l’estasi” e perde la capacità di equilibrare il rapporto con sé stesso e con gli altri.
Dal punto di vista sociale, invece, il mancato rispetto di determinati standard di “successo” può portare alla discriminazione di intere categorie di soggetti, fino a giungere (ed è già successo) ad azioni oggi catalogate come Crimini contro l’Umanità. L’Olocausto è, ancora, la testimonianza più viva e crudele di questa cultura.
C’è da chiedersi allora: il rendimento è davvero l’unico metro con cui misurare il nostro valore? E se non è questo, cos’altro lo è?
La mia partecipazione ad una scuola tradizionale di arti marziali cinesi mi ha fatto scoprire una misura alternativa del mio valore.
Molto meno distruttiva e molto più gratificante.
In un ambiente in cui sono costretto a misurarmi con me stesso(non a misurare me stesso, attenzione!), ho imparato che ognuno di noi ha un valore inestimabile a prescindere da ciò che effettivamente è in grado di fare.
Questo perché, ogni volta che si partecipa ad una lezione, si sceglie di donare a quell’ambiente e alle persone che lo vivono una risorsa che non sarà mai restituita: il proprio tempo.
Questo gesto, di per sé, è in grado di arricchire l’ambiente in cui ci si trova.
Non perché si sia migliore di altri.
Ma perché si sta donando l’unica cosa che non ci può essere resauna volta spesa.
Questo è ciò che dà valore a una persona.
Poi, il livello di prestazioni raggiunto indica solo la nostra scelta o di restare come si è perché ciò ci fa sentire pienamente soddisfatti, o di migliorarci perché vogliamo dare di più, oppure di non volere investire altre risorse perché abbiamo bisogno di altro.
Il raggiungimento di una determinata soglia di rendimento, come si vede, è solo l’espressione di una nostra scelta e, quindi, una nostra responsabilità.
Ma non è un metro di valutazione del nostro valore.
Noi abbiamo valore a prescindere dal nostro rendimento.
Perché, ogni volta che varchiamo la soglia di un qualunque ambiente, sia esso l’ufficio, la casa (propria o di un amico) oppure la palestra, scegliamo di investire in quella micro-realtà una parte del nostro capitale, chiamato tempo, che non tornerà indietro.
Tocca a noi, poi, decidere se investire bene o male questo capitale.
Ma questa è una scelta individuale dettata dalle circostanze del momento.
A chi ha avuto la pazienza di leggermi fin qui, rivolgo un invito.
Provate a pensare a quanto possa farvi sentire liberi la consapevolezza di avere valore a prescindere dal vostro rendimento.
Pensateci.
In questo modo, come il leggendario Conan il Barbaro di Arnold Schwarzenegger potrete “capire il senso del valore. Del Proprio valore!”
Un caro saluto.
Al prossimo numero.

A MALEZZA

di Angelo De Cristofaro
VERSIONE IN NAPOLETANO
A quistione è chesta:
se po’ cunta’ ‘na storia ca fernesce ‘int’ ‘a malezza?
Certo ca se po’. Anzi, certe storie vogliono fernì accussì.
Nun pecché manc’ ‘e fantasia o ‘e speranze,
ma pecché, ‘nfunno a ‘e cristiani,
ce sta ‘nu bisogno secco, duro comm’ ‘a petra:
poter guardà ‘o fallimento proprio dint’ a chello ll’ate.
A malezza nun è sulo tristezza.
È ‘nu guasto lento, ‘na crepa ca nun se vede,
ca cammina pe’ ‘e cose, senza fa’ rumore,
senza ca nisciuno se n’accorge subito.
È chello punto addò ‘o destino nun sbarella,
ma va ‘nnanze, tranquill’,
verso ‘na rassegnazione ca pare normalità.
È ‘o finale addò nisciuno more,
ma nisciuno campa pe’ davero.
È quanno ‘a speranza resta,
ma ‘nu poco meno ‘e chello ca ce vò.
A malezza è ‘o nun succiesso ca resta llà.
È ‘a vita ca nun chiude ‘e porte,
ma ‘e lassa appena appena scostate,
fin’a quanno t’accuorge ca dinto nun ce sta cchiù nisciuno.
A malezza nun fa rumore.
Ma ogni juorno se assetta vicino a te.
Pecché sentì ‘na storia addò nun se salva nisciuno
ce dà ‘o permesso ‘e accettà ‘a nostra ombra.
Pecché ce rassicura
ca nun simmo sulamente nuje a nun ce essere riusciti.
E pecché, certe sere, ‘a felicità ll’ate pesa.
Nun ce sta tragedia,
nun ce sta trionfo.
Sulo ‘na cosa ca nun è succiuta.
E ca continua a nun succedere.
Ma ce sta, pe’ chi sape guardà.
Chi s’avvicina a ste storie,
cu ‘nu nodo ‘a ‘a vocca e ‘o stommaco chiuso,
nun vo’ esse cunzulato.
Vo’ sulo sapè ca nun è sule.
E se vede, dint’ a chelle parole.
LA MALEZZA
VERSIONE IN ITALIANO
La questione è:
si può raccontare una storia che finisce in malezza?
Certo che si può , anzi, certe storie pretendono di finire così.
Non perché manchino d’immaginazione o di speranza ma perché, nel fondo della persone , esiste un bisogno preciso, duro come la pietra: poter riconoscere il proprio fallimento in quello altrui.
La malezza non è semplicemente la tristezza.
È un guasto lento, una crepa invisibile che corre lungo le cose, senza che nessuno la noti subito. È quel punto in cui il destino non deraglia , continua dritto, con calma, verso una rassegnazione che si confonde con la normalità.
È il finale in cui nessuno muore, ma nessuno vive davvero.
È quando la speranza resta, ma un filo sotto il necessario.
La malezza è l’incompiuto che resta lì.
La malezza è quando la vita non sbatte le porte. Le lascia solo socchiuse, finché ti accorgi che dentro non c’è più nessuno.
La malezza non fa rumore . Ma ogni giorno si siede accanto a te.
Perché sentire una storia dove non si salva nessuno, ci dà il permesso di accettare la nostra ombra.
Perché rassicura che non siamo i soli a non essere riusciti.
E perché certe sere la felicità degli altri pesa.
Non c’è tragedia, non c’è trionfo. Solo qualcosa che non è successo.
E che continua a non succedere.
Ma c’è, per chi sa vedere.
Chi si accosta a queste storie, con un nodo alla gola e lo stomaco chiuso,
non vuole essere sollevato. Vuole sapere di non essere l’unico. E in quelle righe, si riconosce.

MILANO E “EL PRET DE RATANÀ”: QUANDO LA LEGGENDA SUPERA LA REALTÀ

di Giorgio Righetti
La sua vita e i suoi miracoli sono sempre stati oggetto di racconti e leggende, la più frequente è quella riferita al tram per Baggio e alla fermata con via Forze Armate, chiamata un tempo dalla gente “fermata Gervasini” o anche “la fermata del pret de RATANÀ”. La leggenda è questa: una giorno don Gervasini, prese il tram della linea n. 34 per andare verso il centro di Milano, ma non aveva soldi con se, il bigliettaio non volle sentir ragioni, il prete fu costretto a scendere dal tram cosa che fece imprecando a voce alta: “Va’, va’ che a Milan rivi prima mi de tì”. E infatti il tram si bloccò e non ci fu più verso di farlo ripartire. Da questo episodio derivano molte varianti, dove cambiano le destinazioni del tram e le circostanze dell’episodio, ma la sostanza è sempre quella. Nella Milano di cento anni fa si andava dal Pret de Ratanà per ogni necessità, consigli, problemi spirituali, richieste di guarigioni e di farmaci che la medicina ufficiale non era in grado di fornire. Giuseppe Gervasini, questo era il suo vero nome, dopo qualche brillante risultato nel risolvere e guarire alcune infermità divenne una specie di “medegon”, (guaritore). Appassionato di medicina empirica, aveva acquistato una pratica nella medicina naturale e qualche sua guarigione aveva del prodigioso. Con le sanguisughe e cento impiastri curava i suoi ammalati: “Ciáppa stà érba chì e falla bùj, béven on cugiàa a la mattìna, in còo a óna settimàna te gh’hee pù niént”. Per questo fu accusato di imputazioni sicuramente false e, subì una sospensione “a divinis” (privazione dei poteri sacerdotali) a causa dei suoi metodi di cura. Sebbene fosse stato poi reintegrato dal cardinal Schuster, questi eventi alimentarono ulteriormente l’ambiguità che lo circondava. La sua fama crebbe in breve volger di tempo divenne popolarissimo, il detto di allora per ogni problema era: “Và a dill al Pret de Ratanà”. Per i dottori don Giuseppe era un prete che esercitava abusivamente l’arte medica, ma quale colpa aveva se i pazienti ricorrevano a lui, dopo che inutili erano stati i costosi rimedi di dottori e professori celebri. Il più delle volte dal “Prêt de Ratanà” si otteneva quello che i professionisti non erano riusciti a risolvere. Don Giuseppe vestiva sempre da prete all’antica, con una lunga “tonaga” aperta davanti. Burbero, disordinato, lunatico, se ne infischiava delle buone maniere, il suo linguaggio era considerato rustico e popolare, lontano dalla formalità tipica del prete, una lunga terapia di parolacce, qualche volta trattava bruscamente i pazienti che ricorrevano a lui, ma non lasciava mai che nessuno se ne andasse senza un consiglio, in fondo era molto buono e generoso. Non chiedeva nessun compenso per le sue prestazioni, accettava solo offerte spontanee che poi distribuiva a chi ne aveva bisogno. Abitava in quel di Baggio in via Fratelli Zoia 182, con la sola compagnia della fedele servente, dove aveva anche arredata una cappelletta nella quale poteva celebrare la messa. La gente lo venerava perché era amico di tutti, ricchi e poveri, che trattava allo stesso modo, parlando e imprecando sempre in dialetto. Se ne andò la sera del 22 novembre 1941, una folla immensa seguì il suo funerale e molti fecero donazioni per dargli sepoltura nel Cimitero Monumentale di Milano. La sua tomba fu in seguito spostata in un’area con uno spiazzo più vasto a causa del flusso continuo di visitatori, che accorrono ancora oggi sulla sua tomba per una richiesta di aiuto.
P.S. Don Giuseppe Gervasini, meglio noto come “el Pret de Ratanà”, così soprannominato dai milanesi, perchè a Retenate dal 1897 al 1901 ebbe il suo primo incarico sacerdotale. Ritornato a Milano nel 1901, passò da un incarico all’altro, fu anche cappellano del conte di Bussero Giuseppe Greppi, poi allontanato perché il prete aveva assunto una netta posizione a favore delle rivendicazioni dei contadini, nel 1926 gli fu lasciata in dono una casa con un piccolo orto, al numero 182 in Via Fratelli Zoia (zona Baggio), dove visse fino alla sua morte avvenuta nel 1941.
Nella foto: Il monumento del “Pret de Ratanà”, ovvero don Giuseppe Gervasini al Cimitero Monumentale di Milano, precisamente nel campo XX. La sua tomba è un luogo di devozione molto frequentato, con fiori freschi e lumini sempre accesi.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 14

di Fabio Fumagalli
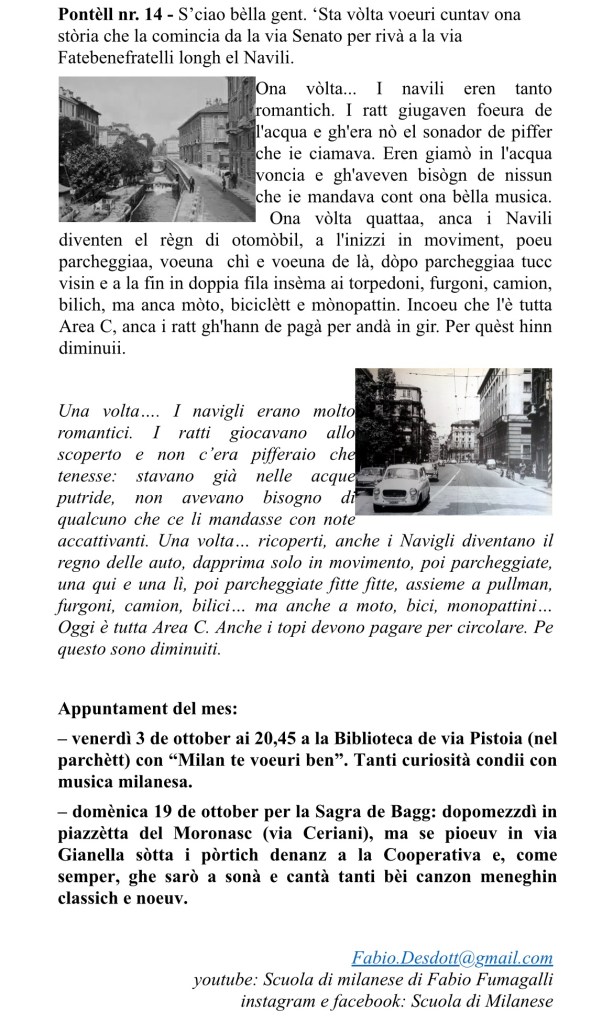

ACCADE IN VIA PORPORA
Pubblichiamo volentieri l’interrogazione a risposta scritta rivolta all’amministrazione di Milano inviataci dal consigliere comunale Marco Cagnolati in merito ad un grave incidente stradale accaduto in via Porpora.
OGGETTO: SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA PORPORA CIV. 154
Premesso che:
Recentemente un giovane è tragicamente deceduto a seguito di un investimento sulle strisce
pedonali di via Porpora altezza civico 154, da parte di un’autovettura condotta da un agente di
polizia fuori servizio;
lo stesso attraversamento è stato più volte segnalato dai residenti come particolarmente
pericoloso e causa di numerosi incidenti ai danni dei pedoni;
sono state riportate anche altre testimonianze di incidenti e mancati incidenti nello stesso punto,
segno della persistente criticità;
Considerato che:
la conformazione del tratto di via Porpora e la velocità sostenuta dei veicoli rendono
l’attraversamento pedonale esposto a gravi rischi;
la vicinanza con esercizi commerciali, fermate di mezzi pubblici e residenze comporta un costante
flusso pedonale, inclusa la presenza di bambini, persone anziane e persone con ridotta mobilità;
sono disponibili strumenti di moderazione della velocità del traffico (dossi rallentatori,
attraversamenti pedonali rialzati, segnaletica luminosa) che in altri contesti cittadini hanno
contribuito a ridurre sensibilmente gli incidenti;
Tutto ciò premesso e considerato si chiede al Sindaco ed agli Assessori competenti:
- se siano a conoscenza della grave situazione di pericolo presso l’attraversamento pedonale
di via Porpora 154 e degli incidenti che vi si verificano; - se non si ritenga urgente predisporre interventi strutturali di sicurezza stradale (dossi
rallentatori, attraversamento pedonale rialzato, segnaletica luminosa, telecamere di
controllo velocità) per garantire l’incolumità dei pedoni; - se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici o studi di incidentalità sul tratto in oggetto e, in
caso contrario, se si intenda avviarli con urgenza; - entro quali tempi si preveda di intervenire per la messa in sicurezza del punto segnalato, al
fine di scongiurare ulteriori tragedie.
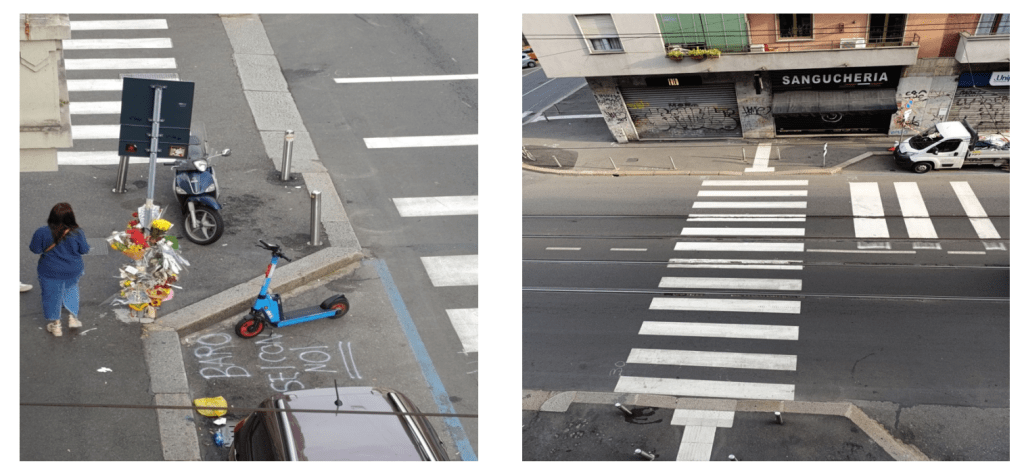
FAUSTO AMODEI

di Aurora Marella
Questo 22 settembre 2025, giorno dell’equinozio d’autunno e giorno dello sciopero generale, e anche mese dell’eclissi lunare e della Luna Rossa, rappresenta un giorno simbolico ed evocativo per dedicare qualche parola alla Storia, a un pezzettino di Storia che ha lasciato il segno nella collettività e che ho cantato in coro.
Prima di iniziare a scrivere di Fausto Amodei, persona e personaggio a cui voglio dedicare questo contributo, vorrei condividere una piccola riflessione sulla Storia. Esiste la Storia, che procede senza subire le interferenze causate dai moti umani e si manifesta negli incastri planetari nel cielo e in quel che resta delle vecchie care stagioni; e poi c’è la Storia dell’umanità, qui sulla Terra, che zoppica, tra il Seveso che oggi ha invaso le strade di Milano e dintorni e fa bloccare auto e tombini, e le tragedie del mondo. C’è questa Storia vicina e lontana che unisce in una sola parola le coincidenze astronomiche, la ciclicità degli accadimenti, la quotidianità di ognuno di noi, le epoche, le guerre e le cesure indelebili di popoli interi.
Un ossimoro, visto da una scrivania con il rumore della pioggia. Le cronache di ognuno di noi e della collettività che si intrecciano mi hanno sempre stupito e con questo contributo desidero ricordare una voce importante proprio di questo intreccio miracoloso, stupefacente, spaventoso della Storia, a volte poco facilmente raggiungibile tra l’individuale, da cui ci si può sentire lontani, non coinvolti, e il collettivo, che chiede di partecipare, di ricordare, di contribuire alla Memoria.
Con questo scritto voglio ricordare un cantante e un cantautore delle cronache, un cantante e un cantautore della Storia, che è stato appunto Fausto Amodei.
Settembre, da ora in avanti, avrà anche la sua memoria perché è scomparso quattro giorni fa, a Torino. Fausto Amodei è stato il fondatore del gruppo torinese dei Cantacronache nel 1958 per cui l’anno scorso la città sabauda ha deciso di conferirgli un riconoscimento, il Sigillo Civico.
Ho conosciuto le parole di Amodei prima attraverso le celebri frasi della sua canzone più famosa, Per i morti di Reggio Emilia (1960), cantata e ascoltata nei raduni corali, ai concerti dei Gang, dei Modena City Ramblers, in un album di Guccini.
Il testo di questa canzone parla di un fatto storico di rivolta popolare conclusasi con una strage. Un’altra Memoria da tenere stretta.
Amodei cantava e con i suoi brani faceva anche un po’ di politica. Intanto, contribuiva ad inventare un genere musicale che trattasse di temi nuovi per la canzone italiana, relativi alla società, alla politica, alle cronache di tutti.
Le sue parole e le sue musiche sono state proposte da grandi voci come Vanoni, Milva e Jannacci, oltre ai già citati.
Le melodie e le tematiche dei Cantacronache restano in ogni coro polare, nelle piazze, nelle voci delle persone della Storia di tutti e della Storia di ognuno.
La biografia di Fausto Amodei è stata ricca di esperienze, collaborazioni, studi e partecipazione sociale, anche come deputato.
Nato a Torino, questa è stata la sua città fino alla fine.
Che non è fine: il suo canto resta vivo.

LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO

di Giorgio Righetti
Robusta e alquanto grintosa, caparbia a volte scostante, animata da un evidente ma celata antipatia per i bambini che disturbavano in cortile fuori dagli orari stabiliti, la portinaia è stata un’istituzione autenticamente milanese, non solo una custode, ma una confidente dell’ordine, provvidenziale per gli anziani e le persone sole, sempre molto rispettosa con gli adulti e nello stesso tempo sbrigativa con i bambini e i ragazzi. Abitava in un piccolo locale in un rientro dell’abitato, subito dopo la porta di ingresso, prima dell’inizio delle scale. Oltre la portineria prima della rampa delle scale esisteva quasi sempre un ampio cortile, dove si radunavano furtivamente i ragazzini che con il loro comportamento la facevano disperare. Il tono perentorio della sua voce con loro era un ordine che non si poteva ignorare. Se aveva un marito questo era sempre fuori casa e lo si poteva trovare nella vicina osteria. La nostra portinaia, delegava a lui qualche incombenza, per poter accudire meglio alla pulizia dello stabile. La vera passione della portinaia era quella delle chiacchiere, esuberante, linguacciuta, sapeva sempre i fatti di tutti e non solo degli inquilini, ma anche quelli del rione. Consapevole dell’importanza del suo ruolo, chiacchierava con il postino sempre in milanese, interessata alle notizie della zona, distribuiva la corrispondenza leggendo e borbottando con tono di malcontento tutte le cartoline. Un’altra passione della portinaia era per i gatti, in Estate nelle ore più calde del pomeriggio dopo una mattinata di duro lavoro stanchissima era facile vederla addormentata su una sedia davanti alla guardiola con qualche gatto vicino, in realtà era una vigilanza costante bastava che qualcuno si avvicinasse perché aprisse di colpo gli occhi per vedere cosa stava succedendo. Ho voluto in questa breve cronaca prendere spunto della mia vecchia casa, perché così erano quasi tutti i caseggiati della Milano anni Cinquanta. Oggi le case con i cortili, sono quasi tutte scomparse, le rampe delle scale sostituite dagli ascensori. La portinaia custode di tutti i segreti del condominio, rimpiazzata purtroppo da soluzioni tecnologiche.

SEMPRE PIÙ SPESSO

di Alessandro Bocci
Succede sempre più spesso, complice la certezza quasi assoluta dell’impunità. Uno degli ultimi episodi qualche settimana fa in via Fulvio Testi, a Milano. Di notte, un uomo di trentadue anni è stato accoltellato da due giovani nordafricani dopo che il fratello aveva subito uno scippo. I due nordafricani vivevano a Cinisello Balsamo e su uno di loro pendeva un’ordinanza di custodia cautelare, evidentemente non osservata.
Secondo l’ISTAT, circa il 75 per cento degli italiani teme di essere oggetto di episodi di violenza e, per questo motivo, il 25 per cento non esce di casa nelle ore notturne.
Come si è potuto arrivare a questo punto?
Sono indubbie le responsabilità morali di quei cattivi maestri che per gli accadimenti criminosi accusano la società nel suo complesso quando invece dovrebbe essere chiaro che le responsabilità penali sono individuali, di chi delinque. Diciamoci la verità, le spese di welfare, dirette e indirette, in favore dell’integrazione sono consistenti e devono rimanere tali. Chi vuole integrarsi è messo, giustamente, nella condizione di riuscirci e ci sono intere comunità che lo hanno fatto.
Il messaggio che alcune forze politiche danno al paese candidando, per una manciata di voti in più, chi ha commesso reati contro le persone e i loro beni appare devastante. È vergognoso criticare le forze dell’ordine che fanno il loro dovere per proteggere malavitosi che, per esempio, non si fermano nemmeno ai posti di blocco per darsi alla fuga. Sempre a Milano, c’è chi riesce a difendere la privacy delle borseggiatrici della metropolitana anziché le loro vittime e c’è perfino chi guarda i “maranza” con simpatia.
Coloro che di fatto proteggono chi delinque determinano il sorgere di spregevoli sentimenti razzisti. Favoriscono il razzismo per poi chiedere il voto di chi razzista non è; un vecchio giochetto sempre attuale e adattabile ad ogni evenienza. Chi difende coloro che non intendono integrarsi si schiera contro gli immigrati onesti ed operosi, che sono la quasi totalità degli stranieri in Italia e la cui presenza è indispensabile per tutti noi.
La gente deve potersi muovere liberamente di giorno e di notte, sia nelle periferie che in centro. Occorre una massiccia presenza nelle strade delle forze dell’ordine, che, da un punto di vista normativo, devono essere garantite sempre di più. E poi non ci si può limitare ad operare tramite il welfare, per altro sacrosanto, per l’inclusione. Le pene detentive e pecuniarie verso chi commette reati contro le persone devono essere incrementate ed essere certe. I cittadini devono essere tutelati.

L’ESPRESSIONE TRANSCULTURALE DEL LUTTO: IL DOLORE CORPOREO NEL RITUALE LURI E CURDO

di Nurgul Cokgezici
Nel corso delle mie ricerche nell’ambito della psicologia transculturale, mi sono imbattuta in diversi rituali ed espressioni legati al lutto in differenti culture. Questi studi mettono in evidenza una verità condivisa: il lutto non è solo un’esperienza individuale, ma anche un processo complesso in cui si intrecciano memoria collettiva, identità culturale e contesto socio-culturale. Ogni cultura interpreta e rappresenta la morte e il lutto attraverso un proprio sistema di simboli e linguaggi rituali.
In alcune comunità, specialmente in occasione della morte di giovani non ancora sposati, è possibile osservare cerimonie funebri accompagnate da tamburi, zurna e danze tradizionali come govend . All’apparenza, tali riti possono sembrare contraddittori; tuttavia, il loro significato è strettamente legato alla metafora dello Şeb-i Arûs (la “Notte delle nozze”) lasciata in eredità da Rumi. La morte, in questa concezione, rappresenta l’unione dell’anima con il divino, e viene vissuta come un ricongiungimento, non come una fine. È un passaggio, un nuovo inizio. Questa visione è profondamente radicata anche nel repertorio rituale ed emotivo di molte comunità curde alevite.
Le ricerche da me condotte sulla cultura luri hanno rivelato molteplici somiglianze tra i loro rituali funebri e quelli della cultura curda, in particolare all’interno della tradizione alevita di Pazarcık. Le melodie di lutto dei Luri presentano affinità sia strutturali che emotive con le narrazioni musicali dei curdi aleviti. Anche da noi esiste una forma di govend chiamata “sallama”, eseguita con ritmi lenti e ciclici: non è solo una danza, ma una forma di espressione corporea del dolore, della rabbia repressa, della resistenza. È un modo per rielaborare collettivamente emozioni represse attraverso il corpo e il movimento.
Un video che ho visto di recente ha dato una forma concreta a questo quadro teorico. Mostrava un bambino piccolo che, insieme ai genitori, ballava tra le lacrime. La scena, estremamente toccante, non esprimeva solo un dolore personale, ma anche una memoria collettiva, una narrazione incarnata del trauma intergenerazionale. È un materiale che sicuramente userò nei miei corsi, poiché rappresenta un esempio efficace dell’espressione culturale del lutto e della manifestazione corporea del trauma collettivo.
Tuttavia, alcuni commenti al video mi hanno profondamente colpita in negativo. Frasi come “Sono nato musulmano, grazie a Dio” completamente fuori contesto e cariche di giudizio, evidenziano quanto siano ancora diffuse la mancanza di empatia culturale e le logiche orientalistico escludenti. Tali affermazioni non solo oscurano il significato del rituale, ma danneggiano anche il valore della pluralità culturale. Esse non sono solo frutto dell’ignoranza, ma anche della mancanza di compassione e di apertura verso l’altro.
Eppure, se solo ci sforzassimo un po’ di più di osservare con attenzione, potremmo capire che ogni persona, ogni cultura, contribuisce all’umanità secondo i propri codici, le proprie credenze e le proprie esperienze storiche. Il lutto, la musica, la danza “govend” sono tutti linguaggi. Nessuno è superiore o inferiore all’altro. Sono semplicemente forme diverse di toccare l’umano, l’anima, il dolore.
Alla luce di tutto ciò, l’impegno per comprendere e interpretare la diversità culturale non dovrebbe limitarsi alla dimensione accademica, ma dovrebbe rafforzarsi anche a livello sociale. Un po’ più di rispetto, un po’ più di sforzo per capire… Forse allora potremmo finalmente vedere le nostre differenze non come minacce, ma come una ricchezza.

TEMPO CHE FU. GIOVANOTTI IN CAMERA!

di Giorgio Righetti
A Milano erano numerosi i “casott”, “el prezzi della marchètta” era indicato nel tariffario all’entrata, i “casot” del Bottonuto e del Verziere avevano nomi meneghini come El Serrali, El Tramway, El Cilinder, non meno famosi erano quelli di Fiori Chiari, S. Carpoforo, Bergamini, Chiaravalle, Poslaghetto, Visconti, le case in queste vie erano per chi aveva pochi spiccioli da spendere, militari e studenti squattrinati. Disciplini, San Pietro all’Orto, Villa Mary, per clienti facoltosi, la “maîtresse”, quasi sempre ex prostituta, tenutaria della casa di tolleranza esortava in continuazione i clienti con le stesse parole stimolandoli all’attività e al commercio della casa. Il tono degli slogan delle “megere”, era di una volgarità sguaiata e disgustosa e variava a seconda dell’ambiente e soprattutto dei clienti presenti in sala d’attesa.
“O commercio o si libera la sala”.
“Signori si sgombra! Se invece d’i donn vorì un bel mascett, andè al Parco Ravizza! Culatoni! Se stee chi a fà? Via, via!”.
“Oh ei biondin – “destra – economica”: su un po’ d’aria! ‘ndemm?!…
(riferimento al vizio solitario…).
‘“ ‘Ndemm in camera?! O faccio chiudere!… Inscì cambiom l’aria.”.
“Fate lavorare le ragazze che sono brave”.
E via dicendo.
La marchetta era una “fiche” che il cliente del “casott” trovava alla cassa e che indicava il prezzo da convenirsi con le signorine e rappresentava l’unità di misura della tariffa per le diverse prestazioni. Le signorine non si presentavano mai con il loro vero nome ma camuffate da nomi artistici o esotici: Dora regolizia, Camilla piccadora, la Scugnizza, Lola, F. … de tolla, madame Royale e così via. Il 20 settembre 1958 la Legge MERLIN, decretando la chiusura delle case di tolleranza, veniva approvata definitivamente, vennero chiuse 560 case di tolleranza dove erano ospitate circa 2700 signorine.
I “CASOTT “ DEL BRERA. El “Fior Ciar”, come era chiamato dai milanesi era situato in via Fiori Chiari al 17 ed era frequentatissimo, le signorine non erano giovanissime, ma ci sapevano fare e inoltre si praticavano giochi proibiti che incuriosivano e attiravano i clienti, el “Fior Ciar”, era dotato di un certo fascino derivatole all’ingresso da una scala a spirale, i letti avevano gli specchi alla testa e ai piedi, statue e quadri con relative scene di sesso che davano subito l’idea di trovarsi nel posto giusto. Sempre in zona “El San Carpin”, in via San Carpoforo 3, la “maîtresse” era una terribile megera la “Maria”, che aveva proibito alle signorine di contattare i clienti, guai a contrariarla, le signorine dovevano rimanere ferme e attendere che il cliente stesso le approcciasse. Più avanti al numero 5 le cose cambiavano completamente in quanto in questa casa si era ricevuti da un gruppo festante di signorine in costume da bagno o solo in gonnellino. Sempre in via San Carpoforo al numero 8 la tenutaria era la Augustina, una vecchia peripatetica con le figlie, tre sorelle che lei stessa aveva indirizzato a questa professione dandole nomi d’arte Dina, Delsa, Derna. Queste “tre grazie”tennero banco al “San Carpin” per molti anni. In questi tre “casott” vicini, l’un l’altro venivano rispettati i desideri dei clienti che trovavano nell’una o nell’altra casa il loro nascosti desideri, spettava alle signorine poi rompere il ghiaccio e ognuna lo faceva mostrando i propri attributi, la rotazione delle signorine ogni quindici giorni da una città all’altra creava nei clienti un’ansiosa impazienza. Il contrasto che regnava in questi posti fra le sfruttate e gli sfruttatori è raccontato da Giovanni Barrella nella sua commedia “Bal Tabarin”, dove l’autore mette in luce come la morte fisica alle volte fosse l’unica via d’uscita in una vita senza la minima speranza per togliersi dalla miseria e dai più impuniti “sfruttatori”, che vivevano sulle disgrazie altrui. Negli ultimi tempi della loro esistenza i “casott” erano ormai in numero limitato una decina a Milano tra cui el “Fior Ciar” e “Ciaravall”, prima che le signorine invadessero tutte le strade della città.
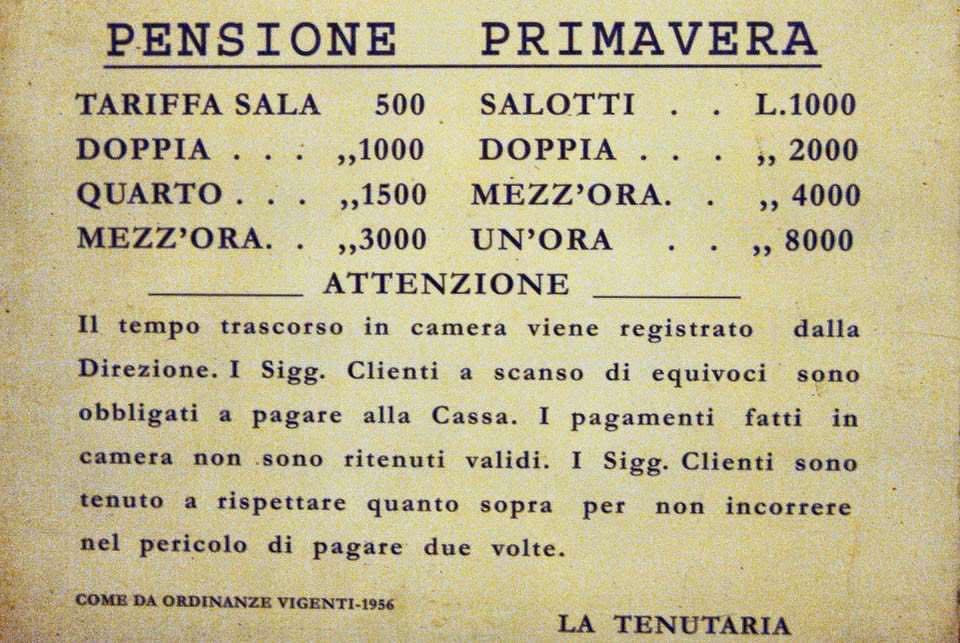
A 19 ANNI VIVO COSÌ

intervista a cura di Luigi Filipetto
Chiamami Igor, dice. Sta seduto accanto a una delle fontanelle di Milano che da quel dì si chiamano vedovelle e getta pezzi di pane ai piccioni. A volte lo vedi su un muretto che divora un panino, altre volte sui gradini della chiesa o fuori dal supermercato. Non chiede mai niente a nessuno, non fuma, solo la lattina di birra accanto a sé, vive come un alieno, il mondo è chiuso nella sua vita. Ti viene da parlargli ma non sai come partire, come reagirà. Così un giorno gli dici ciao, anche il giorno dopo e poi ti siedi accanto. Gli chiedi come va e diventa un fiume in piena. Non alza gli occhi, guarda il cellulare e parla e parla.
Legge sul cellulare e ne approfitti. Sei andato a scuola?, gli chiedi. Delle persone hanno convinto i miei a mandarmi a scuola, risponde, ho fatto le elementari. Sono l’unico, i miei fratelli non sanno leggere, neanche i miei genitori. Io sono il più vecchio dei miei fratelli. Quanti siete? Cinque, tre fratelli e due sorelle. Le mie sorelle fanno le dog sitter portano in giro i cani. Mio padre fa un po’ di tutto. Affila coltelli e forbici, ripara la luce, controlla e cambia le bombole del gas, aggiusta le tegole.
Veste dimesso ma non da straccione. È presto per entrare dentro la sua vita. Ci pensa lui. Ho cominciato a sedici anni, dice, lavoravo nei mercati, quelli che ci sono sulle strade. Pulivo intorno, mettevo i pomodori, l’insalata, le zucchine quando finivano, aiutavo a scaricare e a caricare le cassette. Il lavoro fisso non mi è mai piaciuto. Un prete me ne aveva trovato uno, ci sono stato un mese o due, non ricordo bene. Adesso non faccio più neanche i mercati. Comunque ho anche un bel ricordo perché il figlio di uno dei venditori mi aveva insegnato a suonare la chitarra e andavo con lui di sera a suonare. Avevo conosciuto anche una ragazza, ma ci sono stato insieme qualche mese e poi basta.
Io sto bene così, libero da tutto. Faccio quello che voglio. Mi alzo, giro per la città, alla sera torno a casa a dormire. I miei mi aspettano di sera perché ci lascio qualcosa. Non mi chiedono dove trovo i soldi, non gli interessa.
Ti viene anche a te la voglia di domandargli dove li trova. Certo che a volte lo incroci vestito piuttosto elegante, diciamo così, comunque un po’ meglio del suo abbigliamento abituale, con giubbone e scarpe da tennis colorate. Ci pensa lui anche qui. Porto la spesa a casa per qualche signora, dice. Sì, ma l’abbigliamento elegante? Poi ti capita l’occasione di incrociarlo vestito bene e scherzando gli chiedi se va una festa. Ho un appuntamento in un palazzo laggiù. Un giorno seduti sul muretto gli regali una sigaretta. Così i miei fratelli si comprano qualcosa per loro, ti dice quasi parlando con se stesso, e finalmente sorride.

EVENTI LOCALI CHE FANNO CULTURA: IL CASO DI GRAZZANO BADOGLIO

a cura di Teresa Tardia
Grazzano Badoglio, 27-28-29 giugno 2025
Le realtà locali con eventi e iniziative assumono un ruolo centrale nella vita culturale e sociale per il proprio sviluppo come borghi e città e per il territorio. Gli eventi organizzati, che spesso sono il risultato di iniziative private e pubbliche, in particolare nel periodo estivo o nel primo autunno, trovano terreno fertile per divulgare e far conoscere l’essenza del contesto, la storia, le tradizioni della specificità locale. Tutto questo ha anche uno scopo turistico ed economico: attirare flussi di turisti curiosi e interessati di quelle che sono le bellezze che si possono ammirare, ma dall’altro lato anche con le attività economiche, da quelle ricettive e ristorative a quelle museali che creano un beneficio sul contesto locale in termini di ricchezza.
È interessante il caso nel Monferrato, in particolare a Grazzano Badoglio, dove si è tenuto tra le colline un festival con direzione artistica dell’attore Marco Pagani, il festival “Monferrato ad alta voce, Sussurri d’arte tra le colline” – dal 27 al 29 giugno 2025.
E’ significativa la lettura del messaggio nel logo della manifestazione con la parola sussurri, ossia informazioni che vengono con gentilezza trasferite agli altri, si tratta in questo caso di eventi che si affermano piano piano e creano qualche cosa che è un fil rouge tra passato e presente e proiezione nel futuro; si è giunti alla quinta edizione con il sottotitolo alla ricerca del maschio perduto.
In generale, questi eventi, oltre a far conoscere storia ed arte attivano collaborazioni tra enti pubblici e strutture private in questo caso il Comune di Grazzano ha realizzato l’evento in collaborazione con l’associazione Liberi pensatori Paul Valery di Torino.
Sul sagrato dell’antica Abbazia di Sant’Aleramo e nella bella Chiesa barocca, nel punto più alto del borgo si sono mescolate parole e musica: performance di attori che si sono alternati con intrattenimenti musicali e letterari. Lo scopo è stato quello di creare divertimento intelligente ed emozioni.
Alla sua presentazione dell’evento il direttore artistico Marco Pagani ha dichiarato: «Monferrato ad alta voce, anche in questa quinta edizione farà riflettere con lievità. Intorno al festival si è creato un pubblico affezionato, che ci segue di edizione in edizione. C’è chi non ne ha persa nemmeno una. Forse perché tra queste colline si trova qualcosa che non c’è da nessun’altra parte: il luogo non manca mai di sorprendere per la sua dolcissima bellezza. Quindi, ci si ritroverà di nuovo, spero ancora in tanti, in questo palcoscenico a cielo aperto a rivivere belle emozioni, in un rito che si ripete: come per magia, appena cala la sera, si fa silenzio ed entrano gli attori, si è pronti a farci catturare da quello stupore che solo il teatro sa creare! Al festival si prova la piacevole sensazione di essere non solo spettatori passivi, ma parte attiva della festa. Invito quindi tutti a venire per incontrare gli artisti e, perché no, giocare, provare a giocare con loro, a tu per tu, proprio come tra amici» conclude Pagani.
Tutto il percorso è stato un programma di senso, di profumi e spazi, ma anche di sapori del luogo e dei gusti del luogo da l vino al food!
Tra i racconti oggetto di performance vi è stato anche “ Dieci storie (quasi) impossibili di Bruno Olivieri, una serie di racconti ai quali ha dato voce l’attrice Jenny De Cesarei, un viaggio ai confini del reale tra humour e magica quotidianità. L’autore, Bruno Olivieri, giornalista e direttore creativo, ha alle spalle anche una lunga storia nel mondo dello spettacolo. Dieci storie (quasi) impossibili (Edizioni Dialoghi, 2024) è il suo secondo libro di racconti dopo Un anno diverso dagli altri (Scatole Parlanti, 2022).
Ma va citata anche la parodia comica dei “Promessi Sposi” “ “I promessi storti” messa in scena dalla Compagnia Il Ronzinante.
Tutto questo ha un significato profondo come il localismo può generare valore e in questo specifico caso rendere un territorio di elevata qualità ad attrazione turistica, non va dimenticato che il Monferrato è parte del sito UNESCO “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, riconosciuto per il suo valore culturale e il suo paesaggio unico legato al mondo della tradizione vinicola con le sue cantine storiche e il disegno del territorio.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO

di Giacomo Pio Augello
Nel linguaggio comune, le qualità di una persona vengono identificate con le parole talento e abilità.
Tra le due, la più gradita all’orecchio è, fuor di dubbio, il talento.
Questo perché, almeno nella nostra cultura, il possesso della naturale propensione allo svolgimento di una determinata attività è percepito come una garanzia di successo.
Non a caso, i grandi eroi della mitologia greca (Perseo, Eracle, Orfeo e, in certe versioni, anche Odisseo) erano semidei dotati di armi e poteri, ricevuti direttamente dal loro parente divino, grazie ai quali compivano imprese proibite ai comuni mortali.
L’abilità, invece, è considerata una virtù di minor valore, perché confusa con lo sviluppo del talento stesso.
Bisogna chiedersi: è davvero così?
Il contatto con la cultura orientale mi ha fatto scoprire una prospettiva diversa che ridimensiona l’influenza del talento nella riuscita di un’impresa e, specularmente, esalta l’importanza delle abilità acquisite.
Fin dalle prime lezioni di Kung Fu, mi sono dovuto confrontare con la proverbiale durezza di questa antica arte marziale (che significa appunto “duro lavoro”) e con le difficoltà oggettive di abituare la mente e il corpo ad assumere posizioni e a compiere movimenti del tutto nuovi e molto distanti da quelli usuali.
Alcune di queste, poi, sembravano impossibili da eseguire perché richiedevano una elasticità che io, un po’ per natura un po’ per l’età, non possedevo.
Quando mi lamentavo di non poter compiere un certo movimento per mancanza di questa o di quella qualità, il Maestro mi interrompeva, chiedendomi:” E io che ci riesco, che cosa sono? Un privilegiato?”
Con un effetto domino, quelle parole abbatterono tanti preconcetti che avevo sul rapporto tra talento e abilità e mi portarono a scoprire quattro verità che, come le colonne di un tempio, reggevano la struttura del successo.
La prima era che, pararsi dietro frasi come: “Ma tanto non sono portato” oppure: “Tanto tu sei il maestro” era un modo di raccontare a sé stesso una confortante bugia (chiamasi “scusa”) per nascondere una scomoda verità, e cioè che il percorso di miglioramento mediante l’acquisizione di nuove abilità richiede, innanzitutto, il coraggio di uscire dai confini di ciò che si sa già fare (c.d. zona comfort).
La seconda è che, la riuscita di un’impresa non dipende tanto dal possesso di una attitudine naturale.
L’elemento determinante del successo è, invece, la volontà di riuscire in ciò che si sta facendo.
Il talento può sicuramente aiutare a fare meno fatica, ma serve a poco se non è supportato dalla determinazione di giungere al proprio obbiettivo.
La terza è che, ogni cosa nuova che si impara può essere scomposta nei suoi elementi essenziali e diventare così più gestibile.
Da qui, bisogna chiedersi: “Come faccio a imparare questa cosa?”
Interrogarsi sul modo di acquisire una nuova abilità è importante perché non tutti impariamo alla stessa maniera.
Ognuno di noi ha delle caratteristiche sue proprie che lo rendono idoneo a percorrere una strada e inadatto a percorrerne un’altra.
Come diceva il grande Miyamoto Musashi: “C’è più di un sentiero per arrivare in cima alla montagna.”
Trovare la propria strada è un passaggio fondamentale del percorso di crescita.
La quarta e ultima verità è che, attraverso questo percorso le abilità che non si possedevano all’inizio del viaggio possono essere acquisite.
Se, come detto, iniziare il percorso è un atto di volontà, allora il potere di costruire la nostra vita e, quindi, il nostro Destino sta in buona parte nelle nostre mani.
E questo vale tanto nelle arti marziali quanto nelle cose di tutti i giorni.
L’applicazione di questa tecnologia mentale a tutti gli aspetti della vita quotidiana mi ha permesso non solo di acquisire competenze che non avrei masi immaginato di ottenere, ma anche di superare tutte le sfide che ho dovuto affrontare in questi anni: esami di abilitazione, cambiamenti lavorativi, gestione dei rapporti familiari e sociali.
E continua ad essere valida soprattutto adesso che la tecnologia dell’Intelligenza artificiale sembra volerci portare a vivere con questo ritmo: “Ieri era oggi. Oggi è già domani”.
Vi chiederete: perché porsi così tante domande sul modo in cui si fanno le cose? Non sarebbe più semplice lasciare che il nostro approccio cambi da solo?
La risposta è che questa seconda opzione, per quanto comoda, non è ottimale perché, mentre il cambiamento è un processo automatico, il miglioramento non lo è.
È una scelta di vita, oltre che un atto di responsabilità.
Il progresso tecnologico porta cambiamenti nelle nostre vite.
Ma il miglioramento della nostra vita sta nel modo in cui decidiamo di utilizzarlo.
Quello è un nostro potere e, quindi, una nostra responsabilità.
A chi ha avuto la pazienza di leggermi fin qui, rivolgo questo invito: non lasciatevi limitare da falsi pensieri confortanti sui limiti delle vostre capacità.
Cercate sempre il modo di andare oltre ciò che sapete già fare.
Quando riuscirete, potrete esclamare come il mitico Dr. Frederick Frankenstein (si pronuncia FrankenstIn!, ricordatelo): “SI! PUO’!! FARE!!!”.
Buone vacanze. Al prossimo articolo.

LOUISE MICHEL

di Aurora Marella
Un anno fa di questi tempi, in estate, vivevo il porto di Lampedusa e le sue notizie.
Si parlava di una nave colorata di rosa che recuperava migranti in mare e li portava in salvo dalle onde tra polemiche, divieti e blocchi.
Ogni estate questa tematica diventa caldissima ma ormai non solo d’estate ed è una cartina tornasole per tutte le criticità di questa società impari.
La nave oggetto delle polemiche era chiamata Louise Michel. Era stata acquistata dal famoso street art Banksy e riportava sullo scafo la scritta “RESCUE” chiara e grande. C’era anche dipinta la sua famosa Balloon Girl che questa volta afferrava un salvagente a forma di cuore indossando un giubbotto di salvataggio.
L’artista, ho scoperto successivamente, aveva acquistato nel 2020 questa nave, dipinta, e donata per questo scopo equipaggiandola con dieci professionisti nel salvataggio marittimo, costituendo una ONG.
Mi sono chiesta come mai la nave avesse quel nome di donna.
Ho eseguito una breve ricerca che mi ha dato la possibilità di collegare diversi temi a me cari: la Storia dell’emancipazione femminile, della lotta di classe, dei migranti. E vorrei condividere qui quanto ho potuto apprendere.
Louise Michel, francese, è vissuta tra il 1830 e il 1905 ed è stata attiva partecipatrice agli avvenimenti della Comune di Parigi nel 1871, tentativo seppur breve di governo autogestito nella primavera della capitale. La Francia, dopo Napoleone III e la disfatta con la Prussia, era stata proclamata Terza Repubblica e, alla minaccia di tornare alla monarchia, Parigi aveva risposto con la Comune. L’autogestione fu repressa nella Semaine Sanglante nel maggio del 1871. I concetti dell’anarchia non piacevano ai sostenitori della monarchia né tantomeno a quelli della repubblica.
Dopo l’esperienza da comunarda finì in esilio per sette anni nella Nuova Caledonia (dall’altra parte del mondo) e sfruttò quegli anni per conoscere la cultura canaca e scriverne. Maturò anche delle idee più organiche sull’anarchia e sulle donne, soggette ingiustamente a un maggior peso sociale in quanto tali.
Louise Michel si definì, negli scritti in cui ha narrato la propria vita, appunto, con le parole donna e anarchica.
La Comune non fu l’unica situazione politica in cui partecipò attivamente: in gioventù riuscì a diplomarsi come istitutrice (traguardo raro per l’epoca) e fondò alcune scuole basate sui principi del liberalismo (influenzata dal pensiero filoilluminista della propria famiglia) e dell’uguaglianza tra i generi. Scrisse per giornali liberali e, tornata in Francia dall’esilio grazie ad un’amnistia, partecipò a diverse lotte sociali venendo più volte arrestata.
Subì anche un attentato per cui venne ferita superficialmente e alla fine si dedicò anche alla difesa della causa del proprio attentatore.
Louise Michel consacrò la propria vita all’azione sociale e non si sposò. Amò, si dice, un solo uomo, ma l’amore le fu portato via, giustiziato nella terribile settimana di sangue parigina post Comune.
L’ultima parte della vita fu dedicata alla divulgazione in Europa dei principi liberali e di uguaglianza. E durante uno di questi viaggi, morì a 75 anni.
Leggendo di questa Donna, ho scoperto un’altra storia nella Storia. Di due secoli fa ma ancora attuale per le tematiche che richiama.
Banksy ha scelto questo nome per la nave per ricordare questa Donna e, forse, per guidarci a riflettere, per provocarci, costringendoci a vedere il fianco scoperto della società di oggi che spesso dimentichiamo e per cui è complesso intervenire attivamente. Il primo passo, per tutti, è conoscere.

CHI NON LO RICORDA A MILANO

di Giorgio Righetti
Questo venditore non c’è più peccato, il venditore di acciughe sotto sale, lo si vedeva quasi sempre vestito con una giacca di velluto, tanto che se qualcuno non del mestiere la portava, si sentiva dire: “te sembret un ancioatt”. L’ancioatt era il venditore di acciughe e sardine in barile sotto sale fragranti e genuine, o anche vendute in scatole chiuse tenute a parte, girava per Milano munito di uno stretto carettino, tra le saracche, il baccalà e lo stoccafisso dominavano i due grandi barili di acciughe sotto sale, uno di prima scelta, l’altro di media. Il venditore non era… un milanese di Milano, “acciuga”, deriva dal genovese “ancioa”. Al suo grido: “Ancioeee! Belle inciode!”, nel nostro dialetto si dice anche “inciòda”, accorrevano le massaie, che stavano molto attente al peso giusto sulla stadera, molto dipendeva dalla correttezza dell’ancioatt, nell’eliminazione dell’abbondantissimo sale intorno alle acciughe, questo simpatico personaggio vendeva anche olive verdi e nere (così buone e gustose, che oggi è ben difficile trovarle) e con quel suo nasone dantesco che era un’attrazione, un invito al buonumore sostava un poco dappertutto, ma di preferenza davanti ai mercati o all’osterie e alle cooperative, erano tempi fortunati allora.

LA MEMORIA OSCURATA: PERCHÉ L’ITALIA E L’EUROPA DEVONO ASCOLTARE LA VOCE DEI CURDI

di Nurgül Çokgezici – Psicologa, pedagogista, mediatrice linguistico culturale e studiosa di cultura curda
In un mondo che proclama la libertà dei popoli e il diritto all’autodeterminazione, c’è ancora una nazione senza Stato, un popolo invisibile agli occhi di troppi: i curdi. Oltre 40 milioni di persone, sparse tra Turchia, Iran, Iraq e Siria, vivono da decenni sotto politiche di assimilazione, negazione identitaria e sistematica repressione. Eppure, la loro storia, la loro cultura e la loro resilienza gridano con forza, anche nel silenzio forzato imposto da regimi che li vogliono ridurre al silenzio.
Un popolo cancellato dalle carte, ma non dalla Storia
Fin dalla fine del XIX secolo, il popolo curdo aveva trovato nei giornali e nelle riviste il suo primo strumento di affermazione culturale. Pubblicazioni come Kürdistan, Roji Kurd o Jîn, stampate a Istanbul e distribuite in tutto il territorio curdo, testimoniavano la vivacità intellettuale di un popolo che cercava non la separazione, ma il riconoscimento. Tuttavia, con la nascita della Repubblica turca nel 1923, la linea ufficiale divenne chiara: i curdi non esistono, la loro lingua non esiste, il loro territorio non esiste. Da quel momento, chi parlava curdo diventava un problema da “rieducare”, e chi scriveva in curdo, un criminale.
Una repressione silenziosa, che continua ancora oggi
La negazione della cultura curda non è solo una questione del passato. Ancora oggi in Turchia, parlare in curdo in ambito pubblico o amministrativo è un atto di coraggio. Le scuole curde vengono chiuse, gli intellettuali incarcerati, i partiti politici messi fuori legge. L’Europa, spesso pronta a denunciare violazioni dei diritti umani nei Paesi lontani, resta ambigua e timida quando si tratta di uno Stato “alleato” come la Turchia.
La lezione di İsmail Beşikçi: la verità non ha passaporto
Ciò che rende la causa curda ancora più straordinaria è che spesso a difenderla sono stati “stranieri”, outsider morali. Come İsmail Beşikçi, sociologo turco che ha pagato con decenni di carcere la sua scelta di raccontare con onestà la condizione dei curdi. Come George Devereux, ebreo ungherese che, vivendo tra gli indiani d’America, scelse di schierarsi con i più fragili. Entrambi ci ricordano che la verità non ha passaporto e che la scienza, quando è onesta, diventa resistenza.
L’Europa non può più voltarsi dall’altra parte
Come cittadina europea, come teno-psicologa e come figlia di un popolo perseguitato, rivolgo un appello alle istituzioni e alla società civile: riconoscete il diritto dei curdi alla loro identità. Non si può parlare di democrazia se si ignora il diritto alla lingua madre. Non si può parlare di giustizia se si tace davanti ai massacri, ai bombardamenti, alle incarcerazioni arbitrarie. Il silenzio è complice. L’indifferenza è politica.
Una cultura che resiste, una memoria che insegna
Nonostante tutto, i curdi continuano a cantare, a scrivere, a danzare, a tramandare. Portano nel cuore la montagna e nel sangue la memoria. Insegnano che si può resistere senza odio, si può lottare senza distruggere. Ma hanno bisogno di una cosa: che il mondo li veda.
⸻
Questo articolo è dedicato a İsmail Beşikçi, con il quale ho avuto recentemente il privilegio di scambiare alcune parole. La sua voce, ferma e lucida, mi ha ricordato che anche il pensiero può diventare rifugio e arma, quando è guidato dalla verità.

UN’EUROPA FEDERALE, UN SOGNO O UN FUTURO DOVEROSO?

di Slobodan Fazlagic
È una domanda che si pone dai giorni della fondazione economica e antibellica… Una domanda che non è certo posta oggi da me, ma che nasce nei circoli progressisti ed intellettuali degli stati europei, in parallelo con il percorso di crescita, dai primi passi traballanti fino ad una maturità auspicata ma non certo raggiunta e a pieni voti… O, forse, non abbiamo ancora meritato l’ammissione all’esame? Dunque, un traguardo voluto, meritato, realistico o che non è mai stato tale?
Ma facciamo un passo indietro. Quale ente si potrebbe definire stato federale? Dai testi enciclopedici si evince che una federazione si riferisce a una struttura statale in cui diversi stati sono uniti. Fino a questo punto è facile. Però, uniti come? Ognuno di questi stati dovrebbe avere una qualche forma di autogoverno, limitato in favore di un centro che ha un potere maggiore. Fatta bene o gestita ancora meglio, una federazione funziona se c’è armonia tra le autonomie locali e i livelli decisivi centralizzati.
Vogliamo vedere qualche esempio positivo? Bisogna dire, innanzitutto, che ci sono stati, creati e poi falliti, in modo più o meno crudele, modelli non felici. Metterei le mani avanti dicendo che è accaduto per tensioni interne, ma non sono l’avvocato di nessuno … Purtroppo non stanno vivendo un momento particolarmente gioioso con l’attuale presidente, però si deve ammettere che, in linea generale, gli Stati Uniti d’America sono un serio esempio di federazione funzionante. Nessuno può obiettare che tutti noi, favorevoli o meno, li consideriamo come lo stato al livello tecnologico più avanzato e come la potenza economica più grande al mondo, se consideriamo questo come un parametro di buon funzionamento di una federazione. Naturalmente, ci sono anche parametri diversi, ma di ciò si può parlare in un altro momento.
Sebbene ciascuno dei 50 stati abbia un proprio autogoverno, elegga il governatore, porti proprie leggi nel campo della sanità, dell’educazione pubblica, della sicurezza interna, il governo federale si prende il carico della sicurezza e della difesa collettive, della politica estera, del sistema monetario. Dovrebbe, più importante, garantire i diritti umani e l’imparzialità davanti alla legge per tutti i cittadini della federazione. Su questo aspetto, il percorso è ancora in salita, certo. Un secondo esempio, molto ben operante, ce l’abbiamo al nostro confine: la Federazione Elvetica. Visto che una parte della popolazione di quella struttura di grande successo è costituita anche da cittadini italiani, magari si potrebbe pensare che qualcosa si potrebbe imparare. Vale a dire, loro si sentono squarciati alla schiena dalla madre patria oltreconfine, o no?
Altri esempi di federazioni nel mondo si potrebbero trovare nella Federazione Russa, in Messico, Australia. Anche la Bosnia ed Erzegovina si trova in una posizione sperimentale, unica al mondo. È il modello, l’unico che ha nella sua struttura una repubblica e una federazione (ciascuna con la propria amministrazione separata), ma anche un governo a livello statale. Sarebbe quello che si intendeva storicamente definire come una confederazione.
Prima di aprire il discorso se per la Comunità Europea uno dei modelli di sopra sarebbe utile e fattibile, bisogna chiarire che una federazione qualsiasi non può essere vista come un perpetuum mobile, una macchina che, una volta messa in moto, va da sola e non si ferma mai. È un processo democratico, costruito, curato e corretto passo per passo, seguendo i principi democratici. A quell’ente che oggi si chiama la Comunità Europea manca il passo necessario verso una federazione equilibrata ed efficace, altrimenti i segnali sempre più minacciosi indicano che in futuro potrebbe perdere il suo peso specifico nella scacchiera mondiale, economica e politica. Che cosa ci impedisce di avvicinarci a quello status? Solamente l’avidità e il desiderio sfrenato dei politici locali di mantenere i propri intimi privilegi, ottenuti in un campo diviso in piccoli feudi etnici o economici. Riescono a vendere al proprio elettorato il loro ruolo protettivo in nome della patria, della nazione e a presentarsi come i difensori della purezza razziale o etnica, minacciata dagli altri “tanto diversi” … Superando quell’ostacolo in maniera graduale e saggia, le nuove generazioni di politici emergenti avranno la possibilità di aprire le porte della casa “Federazione Europea”. Al fianco dei forti USA un giorno vedremo forti anche la USE, o no?
Per concludere, che cosa abbiamo imparato dal fallimento delle federazioni che si sono perse nella storia, l’Unione Sovietica e l’ex-Iugoslavia? Sono crollate, implose dopo il tentativo di dominio squilibrato di una delle costituenti (la Russia in primis, la Serbia nel secondo caso). Esempi da evitare in partenza e che dovrebbero insegnarci a stare attenti quando un giorno si aprirà l’inevitabile processo federativo tra i paesi europei. Siamo noi, elettori che non si astengono dal voto per pura pigrizia ed egoismo, a dover fare la guardia a quel processo che, a parere dello scrivente, non può che concludersi con il successo.

IL BORGO DEGLI ORTOLANI

di Giorgio Righetti
… due te ste de cà? in via cucumer, la porta sensa numer in fund a la ringhiera, tra el ces e la ruera …. Questa filastrocca si addice benissimo al numero 72 di via Canonica dove ho vissutot parte della mia vita.
EL “BORGH DEI SCIGULAT” si estendeva lungo le attuali via Canonica e via Piero della Francesca, via Paolo Sarpi e Porta Tenaglia (attuale Lega Lombarda), sino all’Arco della Pace. Porta Tenaglia era una delle quattro porte succursali di Milano, si apriva lungo la strada che dava sul Borgo degli Ortolani.
Le molte risorse idriche della zona favorirono lo sviluppo di cascine i cui prodotti (ortaggi}, venivano coltivati e venduti. Per questo la zona prese il nome di “borgh di scigulatt”, “borgo dei cipollai”, una strada di campagna era diventata la via Paolo Sarpi, poi arricchita con qualche negozio e qualche caseggiato. Nel 1920 il Borgo degli ortolani era un quartiere povero i tanti trani e osterie che stazionavano lungo le vie erano prese d’assalto da decine di avventori, in via Canonica (la via dei lader), assumeva particolare rilievo il cinema Aquila d’Oro, all’entrata un grande cartello raccomandava: “Attenti ai borsaioli”. Nel primo dopoguerra l’osteria del ‘72 era punto di incontro per ladri e derubati, i ladri di allora in certi casi lasciavano la possibilità al derubato se avesse avuto qualche conoscenza di negoziare con loro e di recuperare la refurtiva. Tra la clientela abituale dell’osteria il più noto era il Fiore una figura di spicco conosciuta in tutto il quartiere: “Se sa mai… Te pòrten via la bicicleta, un quaj sacoccia che te frega el borsin… Va all’osteria del settantado e te dumandet del Fiore”. Per la verità erano due le osterie ai lati del portone che portava il numero “72”. L’osteria di sinistra era un tantino più su, dove si giocavano focose partite a morra e di tresette che provocavano liti anche violente, risolte poi dall’oste con il rosso sfuso, paragonabile al rosolio che veniva degustato lentamente, poi una cantatina: “Chi che dis che el vin el fa mal, l’è tutta gente de l’ospedal”, e poi manate sulle spalle e strizzatine d’occhio di cari vecchi amici. L’altra osteria una bettola, ritrovo di gratta, di finti ciechi. La simulazione del fingersi cieco e farsi condurre intorno a chiedere l’elemosina oggi non esiste più, ma un tempo quando i ciechi potevano accedere liberamente nel centro storico e girare di negozio in negozio la truffa del finto cieco era frequente. (L’osteria negli Anni Ottanta divenne un apprezzato ristorante francese, frequentato da personaggi della vicina RAI, oggi è una cartoleria). Al “72” negli Anni Cinquanta erano di casa personaggi come “la Stria”, (la strega), una vecchia malmessa che “fiutava continuamente tabacco”, entrava amichevolmente nelle case di ringhiera e con una voce cavernosa associata a lamentele o pianto prediceva avvenimenti catastrofici. Il più strampalato di tutti era “el Matt” (il matto), alle prese tutto l’anno con la costruzione di un mega presepe, che distruggeva puntualmente urlando durante crisi di nervi, per poi cercare di ricostruirlo subito dopo. Non mancava “El Draghett casciafett” un mitomane che raccontava continuamente storie distorte e fantastiche, che un giorno però per lui si concretizzarono. Un mattino infatti si videro parecchie guardie di pubblica sicurezza uscire dalla sua abitazione, portavano via “El Draghett”, e con lui mezzo vitello rubato nella notte e nascosto in casa. La figura del “gainna”, era sempre presente, burlesca con la faccia rossa come un tacchino, il naso granata e le labbra blu per il gran bere, tanto divertente nel vederlo camminare zigzagando come una gallina, sempre inseguito da gruppi di ragazzini divertiti. Le vecchie osterie oggi si chiamerebbero “relax”, e sarebbero il centro di una serie di rapporti sociali poi operanti in tutta Milano. Il poeta dialettale Luigi Medici nel suo libro sulle “Vecchie osterie milanesi”, pubblicato nel 1932, ne elencava più di cento, ma oggi quante ne esistono ancora? Si contano si e no sulle dita di una mano. Nella Milano di una volta ad ogni via vi erano mescite e sbornie, era l’osteria lo scacciapensieri di una giornata andata male, il problema era poi rincasare indenni, ma non era sempre impresa facile bisognava affidarsi alla protezione di San Giovanni Nepomuceno, chiamato dai milanesi per semplificare il nome “San Giuàn né pü né men”, (San Giovanni né più né meno), che pur non essendo il protettore degli amici di Bacco, la sua statua un tempo era sul ponte dei Navigli protettore delle acque e degli amanti del bere che causa sbornia potevano finire nel Naviglio e annegare.
DAL BORGO DEGLI ORTOLANI A CHINATOWN. Prima di diventare Chinatown, la zona era conosciuta come “Borgh di scigulatt”. Questa area, situata tra Porta Tenaglia e l’Arco della Pace, era caratterizzata dalla presenza di numerosi ortolani e fruttivendoli che vendevano i loro prodotti nelle corti interne e lungo le vie, specialmente via Canonica. L’arrivo della comunità cinese a Milano, a partire dagli anni ’20, ha gradualmente trasformato questa zona, dando vita all’attuale Chinatown. I primi cinesi giunsero nel 1924, poi fecero arrivare amici e parenti, e il gruppo crebbe. Un po’ alla volta passarono dalla vendita di bigiotteria alle cravatte. “Due lile, tre lile, una clavatta”. E poi in giro a venderle di via in via, di quartiere in quartiere, una vita durissima, quella dei cinesi di quel tempo, dormivano a decine nelle camere o negli scantinati. Sempre uniti e solidali tra loro, i cinesi col tempo assunsero operai, ma continuarono a lavorare senza sosta anche nei giorni festivi. Nessuno al “Borg dei Scigolatt” ricorda di una sola malvagità commessa da qualche cinese, tutta brava gente. Poi arrivò il fascismo e nel 1938 le leggi razziali, con l’obiettivo di perseguire persone di razza ebraica, anche i cinesi ne furono coinvolti pur non essendo ebrei, tutti gli ambulanti cinesi furono perseguiti e molti finirono in campo di concentramento. Finita la guerra si dedicarono alle pelletterie, e negli Anni Settanta ai ristoranti. Nel 1987, tra balli, maschere, dragoni di cartapesta, festeggiarono il primo Capodanno cinese.

DELLA MANCATA INCLUSIONE

di Antonella Rizzo
“Ogni scuola tende a insegnare solo ai più ricchi, a meno che non sia costretta a fare diversamente. La trasmissione del sapere ha quasi sempre cercato di censurare i pensieri devianti. L’aula scolastica è sempre stata organizzata in termini di spazio e di arredamento a immagine del luogo di lavoro più importante dell’epoca. I paesi in cui gli educatori hanno maggiori risorse e libertà per trasmettere ciò che è utile allo scambio intellettuale e materiale, nonché al progresso scientifico, sono quelli dominanti. La battaglia ideologica, economica e politica tra i diversi sistemi di gestione del potere si gioca da sempre sul terreno educativo, nel quale ognuno cerca di attrarre i migliori ricercatori, professori e studenti. […]”. Questo leggo nel primo capitolo del libro di Jacques Attali, ‘Conoscenza o barbarie. Storia e futuro dell’educazione’, appena uscito in traduzione italiana per Fazi. Attali parla chiaramente di emergenza educativa nel senso di una urgente necessità di rivoluzionare la visione delle istituzioni educative, quindi della Scuola. L’ autore ricorda qualcosa che non ci ripetiamo abbastanza e cioè che essa, l’ istituzione scolastica in particolare, è strumento diretto del potere dominante in ogni società e che, in quanto tale, è la rappresentazione più fedele della sua idea di Mondo. Se si declina questa presa d’atto a proposito delle pratiche e delle modalità di attuazione della normativa sull’inclusione a scuola, si ottiene un quadro chiaro del disegno non inclusivo che negli ultimi decenni ha reso l’ insegnante di sostegno una figura che, più che includere, appunto esclude. Dopo dieci anni di esperienza a scuola posso dire, è un mio parere, che il sostegno non dovrebbe essere una figura ma un’ area di competenze di ogni insegnante di materia. Come fa l’ autore del saggio di apertura dichiaro le mie proposte di riforma. Toglierei l’insegnante di sostegno per i percorsi personalizzati ma che restano allineati con i contenuti dell’ intera classe, quelli che erano detti “per obiettivi minimi”; e invece per i percorsi che prevedono attività più legate alle autonomie specifiche e ad abilità speciali prevederei un’ equipe specializzata a scuola, composta da psicomotricisti, educatori specializzati, neuropsichiatri che lavorino con il CDC per intrecciare percorsi ad hoc tra abilità scolastiche e non. Di conseguenza tutti gli insegnanti di materia dovranno essere specializzati in percorsi per obiettivi minimi, cioè per tutti i bisogni specifici che prevedono però un percorso allineato ai programmi di classe o equipollente: didattica universale, strumenti per dsa, competenze di gestione della classe, competenze di gestione dell’ affettività, strumenti interculturali, antropologici, ecc. Il percorso formativo dovrebbe essere integrato in quello universitario come un indirizzo specifico: Insegnamento. Quindi ogni laureando che desideri insegnare la propria materia dovrebbe avere ad un certo punto del percorso la possibilità di scegliere l’ indirizzo per la docenza nelle scuole. Questo farei. Ma ovviamente è un’ utopia che in molti criticherebbero. Eppure lo stesso Attali legittima questa riabilitazione del ruolo dell’ insegnante. Il degrado è in atto da molto tempo. Ammettiamolo. Se ammettessimo che arrivano a scuola insegnanti freschi freschi di laurea e con TFA, i cosiddetti specializzati, che non hanno mai fatto un giorno di scuola o che si sono formati malissimo nei TFA; se ammettessimo che ormai il sostegno è diventato per moltissimi un canale per “entrare” di ruolo; se ammettessimo che la maggior parte dei docenti di materia non ha strumenti per gestire i bisogni speciali dei propri alunni, che in molti casi li discriminano apertamente o subdolamente attraverso l’ indifferenza o, peggio, la pietà, e delegano totalmente ai colleghi di sostegno il mandato inclusivo, beh potremmo comprendere che esiste un problema molto serio di decadenza e fallimento di una normativa che sulla carta poteva avere un senso, ma che in pratica si è dimostrata inefficace. In questi dieci anni ho accompagnato storie di studenti e studentesse “non visti” dalla scuola, ho raccolto bisogni educativi non compresi, ho assistito a ferite educative gravissime causate da docenti che non hanno compreso il progetto di vita delle persone che ritenevano “non abbastanza capaci”. Ho agito con gli strumenti dell’ istituzione educativa che servivo e con quelli del mio mestiere, l’ insegnante, ma il più delle volte è stato inutile. Il declino è storico, si è creata dal 1992 in poi una divaricazione tra categorie di docenti, quelli disciplinari e quelli di sostegno, che nel tempo ha ridotto in pratica i secondi in docenti subalterni. Spesso questo paradosso è stato nutrito dagli stessi docenti di sostegno che hanno agito pratiche didattiche di margine, generando esclusione e deresponsabilizzazione dei docenti disciplinari. Concludo questa mia riflessione con un ulteriore interrogativo che problematizza ancora di più il discorso: come si può pensare che ogni insegnante di sostegno sia specializzato in tutte le aree del bisogno speciale diagnosticato, soprattutto se parliamo di bisogni molto particolari? È come chiedere a un medico di essere specializzato in tutte le aree della medicina.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 12

di Fabio Fumagalli
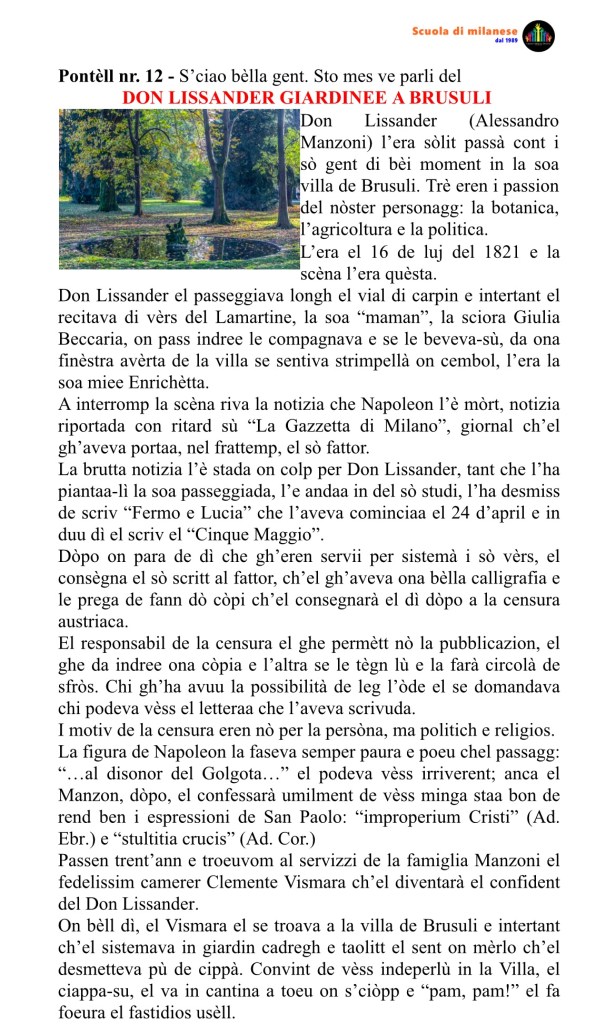
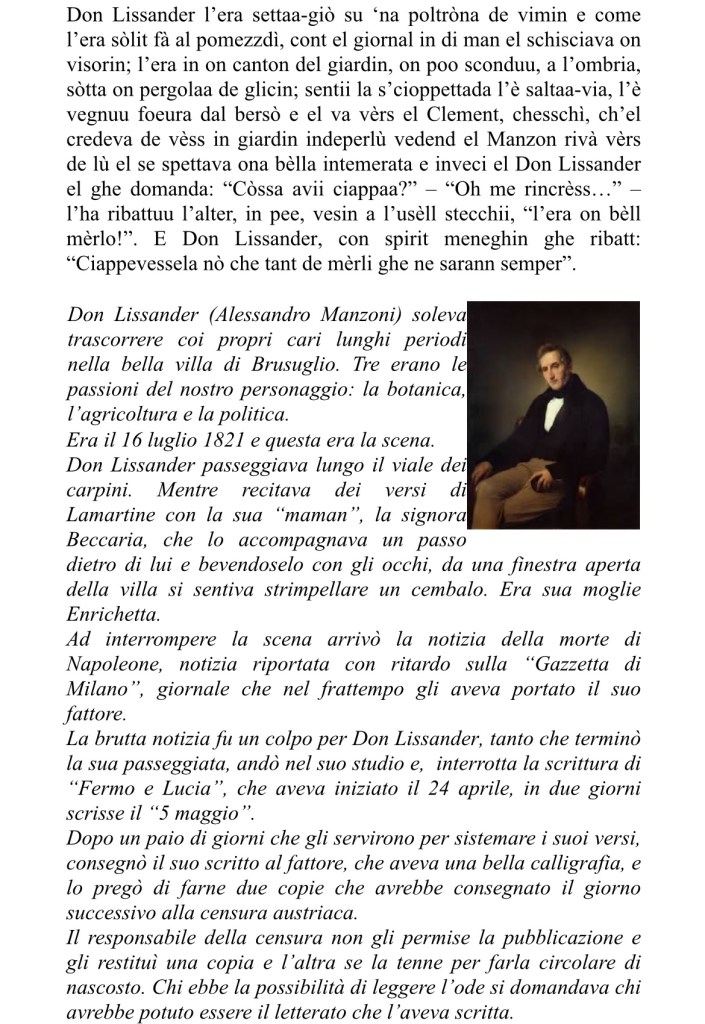
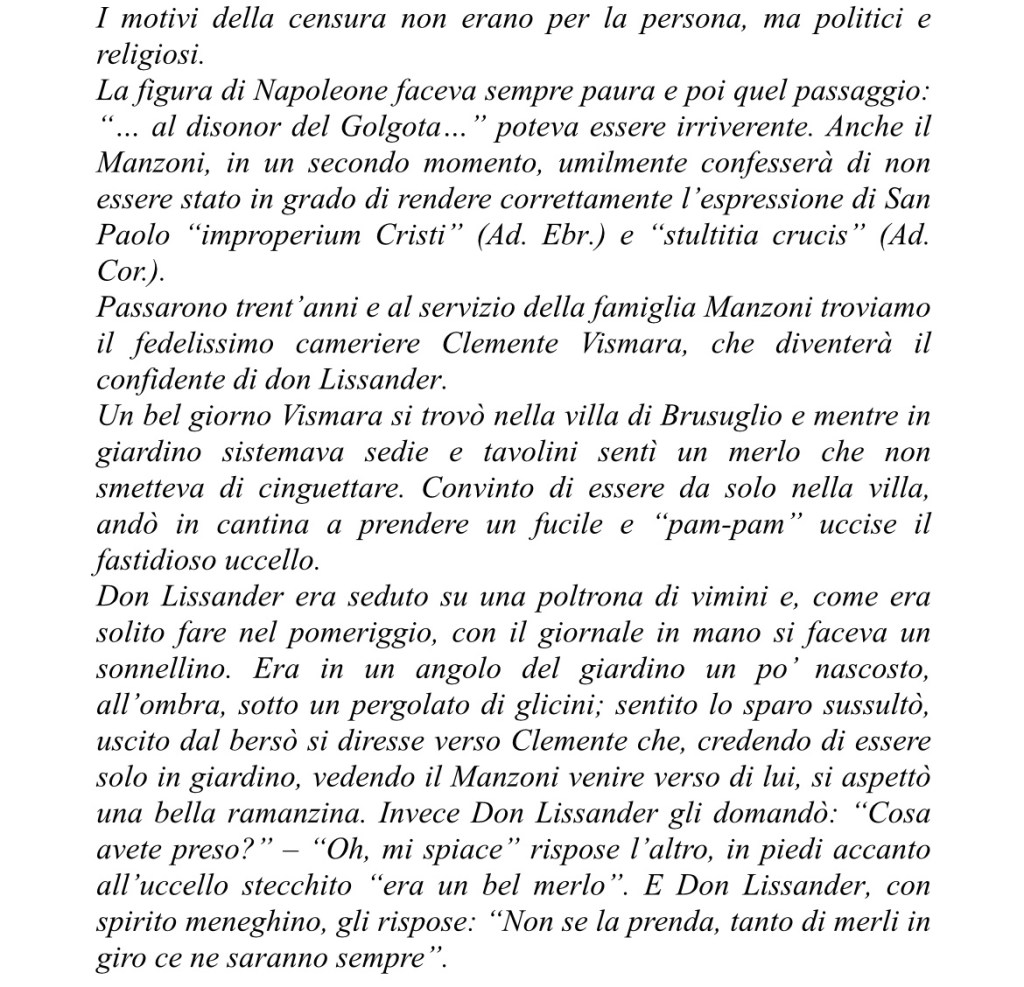

SOLA

di Maria Teresa Zumbo
La luce sottile, flebile mi accarezza.
Le ombre giocano formando una nuova visione
che verrà dimenticata.
Sola,
cammino lungo un tappeto di cemento.
Dalle finestre
risuonano i sogni spezzati dentro sussurate preghiere che squarciano il cielo.

LA PIÙ UNIVERSALE DELLE DOMANDE

di Giacomo Pio Augello
Da quando Bruce Lee ha esordito sul grande schermo con il lungometraggio “Il furore della Cina colpisce ancora”, l’interesse per le arti marziali si è espanso nel mondo principalmente grazie al cinema.
I film e le serie TV di genere, per soddisfare le esigenze di intrattenimento del pubblico, hanno, tuttavia, rappresentato i praticanti marziali come soggetti problematici: uomini e donne segnati da un grande dolore che apprendevano tecniche di attacco e di difesa, spesso attraverso allenamenti autolesionistici, per vendicarsi di un torto subito.
L’effetto collaterale di questa propaganda è stato creare nella mente degli spettatori un legame indissolubile tra le discipline di combattimento e la violenza o il dolore, più in generale.
La mia esperienza in una scuola di arti marziali tradizionale mi ha permesso, invece, di sfatare molti dei falsi miti creati dallafinzione cinematografica.
Il primo di questi riguarda proprio ragione che spinge una persona a imparare le arti marziali.
Quando mi presentai alla prima lezione, il maestro mi chiese: “Perché sei qui?”, intuendo che mi trovavo lì perché stavo cercando qualcosa che non avevo ancora trovato.
Ora io sono figlio degli anni ’80 e ho subito degli atti di bullismo durante l’infanzia.
E’ facile, allora, pensare che abbia deciso di imparare le arti marziali per avere una rivincita contro chi mi aveva vessato quando ero indifeso, come un novello Daniel San.
Ma la realtà non è così semplice e scontata.
Io ho scelto di studiare le arti marziali perché ho sempre pensato che i maestri di queste antiche tecniche di combattimento, grazie ad una disciplina pressoché assente in tutti gli altri sport, avessero acquisito una saggezza ancestrale che li rendeva capaci di affrontare le avversità della vita in maniera sana.
Mi sono detto allora: “Perché ti devi limitare ad ammirarli? Perché non provi a diventare come loro?”
Questa è stata la ragione che mi ha spinto a intraprendere questo percorso: la volontà di diventare una versione migliore di me stesso.
Andando poi avanti con la frequentazione delle lezioni, ho appreso che lo studio e la pratica del Kung Fu hanno come fine ultimo il proprio benessere.
Che è ciò a cui tutte le attività che svolgiamo dovrebbero tendere.
Perché?
Perché l’unica persona con cui saremo costretti a convivere fino all’ultimo giorno della nostra vita è il nostro stesso io.
Vale allora la pena cercare di vivere al meglio non solo la disciplina marziale, ma tutti gli aspetti della propria vita.
Questa riflessione mi ha convinto ad utilizzare la tecnica dell’introspezione psicologica attraverso il perché nella quotidianità: nel lavoro (perché ho commesso questo errore?), nelle relazioni sociali (perché ho reagito così?), nei progetti (perché sto facendo questa cosa?) e, naturalmente, negli allenamenti (perché non ci riesco?).
Quella semplice domanda, “Perché?”, si è rivelata, dunque, l’innesco di una continua e profonda ricerca interiore che mi ha portato a pormi una domanda ancora più importante:
“Che cosa vuoi?”
Ora, interrogarsi su ciò che si vuole non è un esercizio mentale ozioso.
Al contrario, è una pratica fondamentale, soprattutto adesso che l’Intelligenza Artificiale sta diventando parte integrante della nostra quotidianità.
Perché?
Perché i modelli di intelligenza artificiale fanno ciò che gli diciamo noi di fare.
Le risposte che leggiamo sulle chatbots non sono altro che la traduzione, in un linguaggio il più vicino possibile a quello umano, di ciò che noi vogliamo, o che pensiamo di volere.
E ‘chiaro, allora, quanto possa influire la chiarezza di intenti sul risultato della ricerca.
Concludo la mia riflessione con un invito rivolto a chi ha avuto la pazienza di leggermi fino a questo punto: se volete migliorare la vostra vita, indagate dentro di voi sul perché di tutte quelle cose per le quali non trovate la risposta su Internet: “Perché questo evento mi ha fatto arrabbiare?” “Perché questa notizia mi rattrista?” “Perché questa previsione mi spaventa?” “Perché non riesco a fare questo?”
Del resto, come insegnava il grande Dottor Emmeth Brown (Doc per gli amici): “Perché?” è la più universale delle domande.
Ciao.
Al prossimo numero.

CRISTIANI PER IL SOCIALISMO. UNA VAMPATA

di Luigi Filipetto
Negli anni Settanta una specie di comunità di base, con elementi di cristiani per il socialismo, si era costituita a Milano in piazza Wagner, con un prete che diceva la messa fuori in piazza. La storia di questa comunità aveva elementi diciamo positivi, altri un po’ così, difficili da definire.
Alcuni parrocchiani avevano cominciato a interloquire con il vice parroco, fatto sta che durante la messa delle dieci si cominciò a dare voce anche a chi aveva qualche riflessione da proporre. Parlo di riflessione, infatti la cosa si poteva prestare a qualche riflessione un po’ troppo fuori dalle righe canoniche diciamo. Ci provai anch’io. Ma, sentite le premesse, il vice parroco che celebrava la messa non mi fece continuare. Poi ci si mise di mezzo anche il parroco che proprio non digeriva quel parlare in chiesa. Fatto sta che decidemmo di uscire dalla chiesa e di fare la messa fuori in piazza. Dove, tra l’altro, prendeva la parola anche qualche senza tetto.
Il la alla nascita di cristiani per il socialismo venne dal Concilio Vaticano II convocato da papa Giovanni XXIII nel 1962. Sorsero movimenti per la pace, per i diritti degli afroamericani, dei lavoratori, dei popoli oppressi, per la fine della guerra in Vietnam. La denominazione Cristiani per il Socialismo nacque in Cile all’inizio degli anni Settanta come aggregazione di cattolici e protestanti progressisti. Erano gli anni del presidente cileno Salvador Allende, che tra l’altro aveva dato origine alla “via cilena al socialismo”. Poi però ci pensò Pinochet a riportare ordine nel suo paese con un colpo di Stato. Intanto il movimento si era diffuso nelle Americhe e nel 1973 raggiunse l’Europa e l’Italia.
Il centro che fece parlare molto di sé in Italia in quegli anni fu la comunità fiorentina dell’Isolotto. Il clima di apertura alla società era già stato creato nel 1954 dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira che aveva consegnato al quartiere fiorentino le chiavi di mille appartamenti per i bisogni di prima necessità. In un’altra occasione La Pira fu criticato dal Vaticano e anche dalla Democrazia Cristiana per aver requisito degli appartamenti sfitti a favore dei senza tetto. Era parroco dell’Isolotto don Enzo Mazzi, noto per le sue spinte innovative. Altri nomi di spicco di quegli anni sono padre Balducci, don Milani, don Borghi.
La fine degli anni Sessanta dovette registrare un periodo di fuoco per l’avvento a Firenze del cardinale Ermenegildo Florit, conservatore a oltranza. Tanto che, quando la comunità dell’Isolotto cominciò a rivendicare l’autonomia dei cattolici in politica, diede l’ultimatum a don Mazzi con lo storico aut aut: o ritratti o ti dimetti. Infatti nel ’68 notificò a don Mazzi la sua rimozione da parroco dell’Isolotto.
Un incidente intercorso fra la comunità e un monsignore, aveva indotto il nostro cardinale a citare in tribunale otto persone della comunità, cinque preti e tre laici. Il monsignore aveva detto che gli avevano impedito di dire la messa. Così il cardinale li denunciò per istigazione a delinquere e turbativa di funzione religiosa. Dicono le cronache che un migliaio di persone si era autodenunciato in quell’occasione. Avvocati di livello si erano offerti per difendere gratuitamente gli imputati. Tra questi anche Marcello Gentili della comunità milanese di Piazza Wagner. Conclusione, assoluzione per tutti.
Merita ricordare alla fine un tempestoso confronto a Barbiana fra il cardinale Florit e don Lorenzo Milani. Così il cardinale ricordava l’incontro nel suo diario: «È stata una conversazione concitata di oltre un’ora. Momenti angosciosi. È un dialettico affetto da mania di persecuzione. Egocentrismo pazzo; tipo orgoglioso e squilibrato». Alla fine di quel confronto don Milani aveva detto chiaro al cardinale: «Sa quale è la differenza, eminenza, tra me e lei? Io sono avanti di cinquant’anni…».
Come è finito il movimento Cristiani per il socialismo? Il fuoco che aveva tutte le carte per riscaldare gli animi si è pian piano esaurito. Il terreno fertile per dare frutti si è inaridito.

IL DONO – UNA LETTERA DA MAESTRO A MAESTRO

di Angelo e Gloriana De Cristofaro
Abbiamo scritto queste righe con il cuore colmo di gratitudine per un mestiere che, più che una professione, è una vocazione. Negli anni trascorsi tra i banchi di scuola, abbiamo imparato che educare non è solo trasmissione di saperi, ma un viaggio condiviso, un cammino silenzioso che lega anime, fragilità, sogni.
Abbiamo sentito il bisogno di dare forma a questo pensiero in parole semplici, sincere. Così è nato “Il Dono”, un messaggio scritto pensando a tutti i maestri, a tutte le maestre, a chi ogni giorno sceglie di esserci davvero, con presenza e dedizione.
IL DONO
INDICA AI TUOI ALLIEVI LA GIUSTA ROTTA E COME NUOTANDO IMMERGITI CON LORO
IN ACQUE LIMPIDE PER POI PROSEGUIRE IN QUELLE SEMPRE PIÙ PROFONDE.
PROSEGUI A LENTE BRACCIATE PERCHÉ ANCHE I PIÙ FRAGILI POSSANO SEGUIRTI,
INFINE LI VEDRAI ALLONTANARSI SEGUENDO LE LORO PASSIONI.
SPESSO TORNANO IN QUELLA CHE É STATA LA LORO CASA SPERANDO DI RITROVARTI,
PORTANDO CON SÈ UN GRANDE DONO:
NEI LORO OCCHI L’EMOZIONE NEL VOLER CONDIVIDERE I LORO SUCCESSI,
NEI TUOI OCCHI L’EMOZIONE DI CHI SPERAVA DI POTERLI ASCOLTARE.
Angelo e Gloriana De Cristofaro
Commento a cura di Nurgul Cokgezici
Questo testo è più di una poesia: è un manifesto dell’educare come relazione. L’immagine dell’insegnante che si immerge con i propri allievi, accompagnandoli passo dopo passo – o bracciata dopo bracciata – è la metafora di un’educazione viva, partecipata, capace di rallentare il ritmo per non lasciare indietro nessuno.
L’educatore, in questa visione, non si pone sopra, ma accanto. Scende in acqua con i suoi studenti, si sporca le mani, ascolta, osserva, guida. E quando i ragazzi, finalmente, trovano la loro direzione e prendono il largo, non è una perdita. È compimento.
Il Dono sta proprio lì: nel ritorno. Nel riconoscimento silenzioso ma profondo che chi educa lascia un’impronta duratura. Quando gli ex allievi tornano, con gli occhi pieni di gioia e il desiderio di condividere i traguardi raggiunti, ciò che portano con sé è molto più di un ricordo: è gratitudine. E in chi li ha accompagnati resta la gioia discreta ma intensa di chi ha saputo aspettare, senza mai smettere di sperare.
In un mondo che spesso misura il valore dell’insegnamento in risultati immediati, Il Dono ci ricorda che l’impatto educativo si misura nel tempo, nei legami che durano, nella casa interiore che ogni buon insegnante sa costruire nei propri allievi.
Questo messaggio andrebbe letto nelle scuole, affisso nei corridoi, condiviso nei collegi docenti. Perché ci parla di ciò che davvero conta. E ci invita a non dimenticarlo.

LEGGENDE DEL DESERTO AMERICANO

di Giorgio Righetti
GLI APACHE: la loro origine è leggendaria. Si racconta che secoli fa, uscendo dalla desolazione dalle terre dell’Artico, un popolo iniziò la sua lunga marcia verso Sud. Era un popolo, cresciuto nelle avversità della natura, abituato alla fame, alla furia degli elementi naturali, alla lotta continua per la sopravvivenza. Anche se poverissimo aveva coraggio e orgoglio che si manifestava anche nel nome che si era dato: Tinde (Il Popolo). Spostandosi continuamente verso Sud alla fine arrivò alle Grandi Pianure. Qui per la prima volta trovò abbondanza di risorse per l’esistenza e ciò che serviva per costruire un rifugio. Poi nuove forze si fecero sentire e negli ultimi tre secoli i Tinde furono costretti a spingersi sempre più a Sud, nell’interno di un deserto spoglio, aggravato da un caldo soffocante, (il Sud-Ovest) dove la vita non procedeva nella concordia e nella tolleranza, ogni essere era in guerra con il suo vicino e il conflitto era incessante, ogni cosa era predatrice o preda. E qui accadde un fatto straordinario, l’ambiente ostile del deserto trasfuse il suo carattere nei Tinde. Il calore del sole che aveva ammansito altre tribù non riuscì a fare altrettanto con i Tinde. I loro guerrieri divennero magri, cotti dal sole, astuti e feroci, pervasi da uno spirito crudele e pieno di vitalità, ispirati a sentimenti di morte e di malvagità superiori a quelli di ogni altra tribù. Ciò valse loro il nome di “Apache”, (Nemici). Gli uomini bianchi incontrarono gli Apache quando la marea dell’espansione si addentrò nell’Arizona scoprendo grandi campi auriferi che provocarono una vera e propria corsa all’oro. Benchè questo volesse dire l’invasione della terra che era stata da sempre degli Apache, non si fece scrupolo di scacciare i proprietari rossi per far posto agli invasori bianchi. Per due decenni nell’ambiente ostile del deserto americano, fu un susseguirsi di battaglie, vendette, repressioni, massacri, anche altre tribù parteciparono alla lotta contro gli aggressori, ma gli Apache con le loro tattiche di guerriglia, aggressive e insidiose furono il vero grande avversario.
GERONIMO. Gli Apache Chiricahua del Sud-Oves americano era l’ultima delle grandi tribù a sfidare il governo degli Stati Uniti e il suo tentativo di imporre il sistema delle riserve. All’esercito sotto il comando del generale George Crook, fu affidato il compito di stroncare la loro resistenza con qualsiasi mezzo. Così ebbe inizio una bieca caccia all’uomo, sempre con lo stesso ordine: “Ogni Apache ovunque si trovasse, venisse ucciso a vista, mentre le donne e i bambini dovevano essere venduti come schiavi”. La campagna di Crook, contro le roccaforti degli Apache, a Sud del confine Messicano pose fine al conflitto, che per circa due decenni aveva insanguinato il Sud Ovest. C’era solo un guerriero Chiricahua, con la sua banda di ribelli che resisteva ancora, poi persino lui fece sapere che si sarebbe arreso, lo chiamavano Goyahkla, ma anni prima i messicani gli avevano dato un altro nome Geronimo. Il 5 settembre 1886 una notizia proveniente da Fort Bowie, (Arizona) attraversò come un lampo tutto il Sud Ovest. Il giorno precedente presso il confine messicano Geronimo e il capo Naiche, figlio di Cochise si erano arresi al generale Nelson Miles, con loro diciotto uomini, quattordici donne, sei bambini. Dal momento in cui questi indiani erano fuggiti, per la loro cattura erano stati necessari cinquemila uomini dell’esercito regolare con una rete di postazioni che diffondevano messaggi per mezzo di specchi da una montagna all’altra. Nemmeno una forza militare di cinquemila uomini riuscì ad avere la meglio sulla banda Apache che rappresentava l’ultima resistenza contro un sopruso diretto a privare gli indiani dalle loro terre e dalla loro libertà. “Era un feroce assassino che bisognava impiccare”; scrivevano i giornali dell’Ovest. “Era infido e crudele”, dissero gli uomini dell’esercito e gli agenti indiani che non riuscirono a tenergli testa. “Era uno stregone odiato da tutti e che doveva la propria fama alla sensazionale pubblicità”, dissero gli storici. Niente di tutto questo, solo con accordi promessi e mai mantenuti, fu possibile sconfiggere Geronimo. Catturato con l’inganno, fu deportato in Florida, con tutta la popolazione Apache dell’Arizona. Venne rinchiuso in campi di prigionia per più di vent’anni. Geronimo pur non avendo mai ricoperto la carica di capo, era un leader incontrastato, abile guerriero, spietato e implacabile in battaglia, fu un uomo fondamentalmente religioso. Anche durante la sua prigionia dimostrò lodevoli qualità e intelligenza senza venir meno alla propria determinazione.

LORENA ASANAVICIUTE

di Alessandro Bocci
Nel libro Anime baltiche, lo scrittore e giornalista olandese Jan Brokken afferma che Loreta Asanaviciute, con i suoi capelli neri non troppo lunghi, il collo sottile e le labbra piene, era una ragazza che faceva innamorare.
Nei paesi baltici, oltre che per gli scacchi, vi è una forte passione per le canzoni tradizionali, le dainas, e Loreta faceva parte di un coro sindacale di Vilnius, dove cantava con un abito fucsia e il colletto di pizzo. Di carattere tranquillo, nessuno poteva immaginare che quella ragazza all’età di ventitré anni sarebbe passata alla storia come una patriota.
Lavorava, siamo alla fine degli anni ‘80, in una fabbrica di vestiti, in un reparto dove si applicavano decorazioni sulle maglie. Durante il proprio turno, le operaie, metà lituane e metà russe, ascoltavano, alternandole, canzoni popolari lituane e russe. Fino a quando una donna russa si chiese come mai, in Unione sovietica, si dovesse ascoltare “quella lingua da cani”. Da allora, Loreta iniziò ad interessarsi di politica e prese parte, nell’agosto ‘89, alla grande catena umana lunga 600 km che congiunse Tallinn con Riga e Vilnius. Quella manifestazione, che sarebbe stata ricordata come la “Rivoluzione Cantata”, a cinquant’anni esatti dal patto nazi-sovietico tra Molotov e Ribbentropp, ebbe la stessa forza e coraggio della Primavera di Praga e dell’insurrezione di Budapest.
Nel febbraio del ‘90 si tennero le prime elezioni democratiche, vinte dal movimento Sajudis, guidato da Vytautas Landsbergis, che proclamò l’indipendenza. Gorbaciov, allora Segretario generale del Pcus e Presidente dell’Urss, rispose con il blocco economico della Lituania e con l’invio di reparti militari.
Nel gennaio ‘91, Landsbergis chiese ai cittadini di difendere il parlamento e la sede della televisione. Tra la folla che urlava “fascisti, fascisti, assassini” agli invasori sovietici vi era Loreta. Un carro armato le tranciò una gamba. Trasportata all’ospedale della Croce Rossa, appena prima di morire, Loreta pronunciò la sua ultima domanda, che trasmessa in televisione fece piangere tutto il suo popolo. “Potrò ancora sposarmi? Potrò ballare alle mie nozze?”
Anni dopo, Landsbergis venne eletto al parlamento europeo e propose, prendendo spunto da una legge che vietava i simboli nazisti, di proibire tutti i simboli del comunismo sovietico. Nel settembre 2019, in una risoluzione approvata a stragrande maggioranza, il Parlamento europeo condannava “con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l’umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi totalitari”. Sempre il Parlamento europeo, ancora a stragrande maggioranza, nel gennaio 2025, in una risoluzione deplorava “il continuo utilizzo negli spazi pubblici di simboli dei regimi totalitari e chiedeva di vietare, all’interno dell’Unione, l’uso dei simboli nazisti e comunisti sovietici, così come dei simboli dell’attuale aggressione russa contro l’Ucraina”.

UN VIAGGIO NELLA MILANO DI IERI: LA LIGERA

di Giorgio Righetti
Quando a Milano si iniziò a riconoscere una certa categoria di scansafatiche, di individui incostanti, volubili, oziosi, vagabondi, senza essere veri delinquenti si cominciò a classificarli popolarmente come Ligera. Molto si è detto, e si è scritto su questi personaggi, quasi sempre a sproposito con scarsa competenza. Quando intorno a un argomento come la “Ligera”, modificato nella sua forma originale, il meglio che resti da fare a chi scrive dopo, se non vuole ripetere gli errori dei predecessori è quello di evidenziare i loro strafalcioni, di correggere i fatti se ve ne sono di sbagliati e criticare gli errori più grossolani. In tal modo si evita di ripetere per proprio conto ciò che già detto da altri. Il Ligera non è mai stato un delinquente di professione, ma la sua vita non era normale, spesso si accompagnava a mestieranti, girovaghi, giocolieri e simili in ogni caso non va confuso con il “locch”, vero cardine della mala milanese, personaggio aggressivo, minaccioso, in grado di compiere anche delitti. Il “ligera” non avrebbe mai dato una coltellata, per nessun motivo, neanche per un offesa, non era sua abitudine portare il coltello. La Questura lo teneva d’occhio, ma raramente aveva a che fare con la giustizia e quando succedeva era sempre per reati minori. Il ligera (leggero), lo dice la parola stessa era un personaggio insofferente a ogni disciplina, non costante nel conservare un lavoro, in caso di bisogno pronto a qualsiasi servizio, che gli permettesse di avere “quaj ghell in saccoccia” (qualche soldo in tasca), per smettere poi subito dopo perché non si abituava a dover faticare per guadagnare poco. Sicuramente per male che andava un “piatt de minestra” lo trovava sempre a casa, magari con un “das de fa fanigutun”, (datti da fare lazzarone), era un personaggio dell’ultimo Ottocento e si esaurì nei primi tre o quattro decenni del Novecento. A volte il “ligera” era implicato in piccoli furti, borseggi, piccole truffe, era il tipico “lader de pulaster” (ladro di polli), viveva sempre di piccoli espedienti di ogni genere, sempre attento a non cadere tra le grinfie della polizia, ma non aveva niente a che vedere con il truffatore specializzato o col borsaiolo di professione. Il regno dei “ligera” era la Darsena di Porta Ticinese vero bassofondo della società, ritrovo di tutti gli spostati, ma questo personaggio era di casa anche nelle bettole mal frequentate tipiche dei rioni popolari, non lo si trovava quasi mai seduto al tavolo davanti alla bottiglia di vino, preferiva generalmente il biliardo o stava volentieri a vedere gli altri disputarsi con foga una partita. Tutti i “ligera” erano schedati in Questura perché vivevano ai margini della malavita, e volentieri diventavano confidenti dei poliziotti. I ligera si conoscevano tutti, ma non si chiamavano mai per nome, avevano un soprannome, quasi un etichetta della loro persona. Furono disorientati dalla metamorfosi riscontrata nella vita cittadina negli anni trenta e quaranta e trovarono tutto più difficile, scoppiata la guerra si trasformarono in aspiranti borsaneristi, terminata poi la seconda Guerra Mondiale si trovarono sempre più spaesati e si lasciarono assorbire da altre correnti criminali molto più pericolose, fu così che la ligera scomparve per lasciare il posto a una delinquenza sempre più dilagante e non facile da arginare.
La dicitura della foto non è direi molto corretta, non i malviventi di oggi i cosiddetti “ligera”, ma persone che pur vivendo ai margini della società e della legge erano capaci anche di umanità.
P.S. Chi ha capito le vere caratteristiche del Ligera, e ne ha studiato lo spirito e le abitudini, è stato Mario Bonfadini, che sul “Corriere della Sera”, delineava gli associati alla Ligera in modo efficace e veritiero: “Un ladro casalingo, per così dire, come il gatto, pigro e bonario…; un ‘bravo ragazzo’ che a un certo punto ha voltato male, ha smesso di lavorare, perchè non riusciva ad adattarsi agli orari, e non lo persuadeva dover faticare tanto per guadagnar così poco; o perché era diventato troppo bravo alle boccette e al bigliardo e si era lasciato vincere dalla tentazione di mettere in mezzo qualche tipo dal portafoglio troppo gonfio; o perchè si era trovato disoccupato e si era messo a rivendere certa merce di dubbia provenienza.
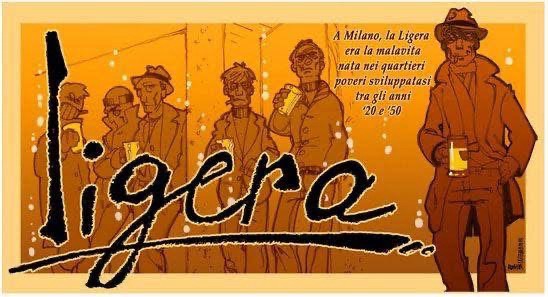
IL VUOTO DELL’UMANO: TRA DESIDERIO, SICUREZZA E SPERANZA
L’ESSERE UMANO NASCE MANCANTE. E IN QUELLA MANCANZA COSTRUISCE IL SENSO DELLA PROPRIA VITA

di Nurgul Cokgezici
L’essere umano nasce impotente, incompiuto, mancante. Non è solo una condizione fisica o psicologica, ma una verità esistenziale profonda. Alla nascita, ci troviamo immersi in un vuoto un vuoto originario, eterno che diventa la spinta fondamentale di ogni nostra azione. È questo vuoto che ci costringe a cercare senso, appartenenza, riconoscimento. È questo vuoto che ci fa muovere nel mondo, desiderare, costruire, amare.
Crediamo, illudendoci, che la realizzazione di determinati obiettivi come la scuola, gli studi, la laurea, una carriera o una casa possa colmare quella sensazione di incompletezza. Ma, una volta raggiunti, ne sorgono subito altri. La corsa non finisce mai. E forse, perché quel vuoto non si può riempire veramente. È incolmabile.
Il desiderio dell’altro
Come sosteneva Jacques Lacan, il desiderio umano è sempre desiderio dell’Altro. Non desideriamo solo l’oggetto, ma desideriamo essere desiderati. Vogliamo essere visti, riconosciuti, apprezzati. E proprio per questo, l’essere umano da solo non esiste pienamente. Ogni gesto, ogni ambizione, ogni creazione è, in fondo, una risposta al bisogno dell’altro. Un tentativo di essere validati.
Ma ciò che ci spinge ad agire è anche il bisogno di dare un significato alla nostra vita. E quel significato non lo scegliamo liberamente. I valori su cui costruiamo il nostro senso di esistenza ci vengono trasmessi dalla famiglia, dalla cultura, dalla società. Siamo abitati da idee che non sempre ci appartengono, ma che ci guidano. Possono essere religioni, ideologie, ideali, la famiglia, i figli, gli animali. Tutti modi diversi di tenere vivo quel senso, di costruire una narrazione che giustifichi il nostro stare al mondo.
Quando il senso manca
Tutti abbiamo bisogno di una storia da vivere. Di un valore da incarnare. Di un orizzonte verso cui tendere. Quando ci manca una narrazione, quando non abbiamo più obiettivi, cadiamo nella depressione. E quando gli obiettivi si esauriscono, quando il senso ci sfugge, ci spegniamo. In senso simbolico, ma talvolta anche reale.
Per me, ad esempio, la famiglia è un valore fondante. Fare figli non è soltanto dare vita, è anche dare continuità, lasciare un segno. È un’eredità che va oltre il materiale. Anche scrivere, creare, disegnare, sono atti profondamente esistenziali. Sono tracce che lasciamo al mondo. Messaggi per chi verrà dopo di noi. Tentativi di affermare che siamo esistiti.
Speranza e paura
Ogni giorno ci svegliamo nella speranza di qualcosa. Ogni anno, quando celebriamo l’arrivo del nuovo anno, portiamo con noi il desiderio di migliorare. Ogni nuovo amore porta con sé la speranza di rinascere. Ma la speranza cammina sempre a fianco della paura. Paura di non riuscire, di non realizzare, di non essere all’altezza.
Anche nel flirt viviamo questa tensione: desideriamo qualcosa, ma abbiamo paura di non ottenerla. È il gioco tra sicurezza e insicurezza che tiene vivo il desiderio. Quando quella tensione si spegne ad esempio quando un amore si stabilizza, diventa relazione, matrimonio si entra in una zona di sicurezza. Ma quella stessa sicurezza può diventare una forma di stasi, di morte simbolica. Per questo, a volte, cerchiamo nuove avventure, nuove sfide, nuovi desideri.
Un equilibrio instabile
La vita non è altro che un continuo movimento tra sicurezza e insicurezza. Abbiamo bisogno di stabilità, certo. Ma abbiamo anche bisogno di desiderare, di rischiare, di rinascere. È in questa oscillazione che si gioca la nostra umanità.
Forse non colmeremo mai il vuoto con cui siamo nati. Ma possiamo abitarlo. Possiamo attraversarlo costruendo senso, creando legami, lasciando tracce. In fondo, è proprio in quel vuoto che si apre lo spazio per la libertà, per la creazione, per la speranza.
E forse, proprio lì, si nasconde la bellezza fragile e potente dell’essere umani.

QUESTA È UNA STORIA DI CANTIERE E DI MARE

di Angelo De Cristofaro
Questa è una storia di cantiere e di mare.
La raccontavano tutti, tranne uno, Vittorio detto Roma.
Carlo Cuneo, compagno di lavoro di Vittorio per venticinque anni, Il signor Bianchi, proprietario delle Officine GMG che firmava le paghe e Zio Gino, il sindacalista pescatore testimone anche dell’epilogo avvenuto venti anni più tardi,
si passavano il racconto come un testimone: l’impresa della “Bislunga”, la rievocavano a cene, in porto, gonfiando sempre più i particolari come fossero vele.
Vittorio ascoltava, annuiva, a volte sorrideva. Ma non aggiungeva una parola, lasciava che fossero gli altri a riempire gli spazi tra i fatti.
Questa, dunque, non è la sua versione, forse non è neanche la verità .
È il riflesso di una storia vera, spezzettato in voci altrui: orgogli, omissioni, dettagli che solo il tempo ha cucito insieme. Un puzzle in cui il centro vuoto, il suo silenzio, è la forma più eloquente. È ciò che rimane quando un uomo sceglie di abitare con discrezione anche le sue pause.
Genova, anni ‘70.
L’odore di mare si mescolava al fumo delle saldatrici nell’officina GMG. Un luogo di uomini pratici, con le mani segnate dalla fatica, dove ogni sfida era un’occasione per dimostrare che con l’ingegno si può fare qualunque cosa
Quando il proprietario, il signor Bianchi , portò quella richiesta impossibile , allungare uno scafo d’acciaio già costruito, tutti pensarono a una follia. “Tagliare una barca come un salame senza un bacino di carenaggio? Siete matti!” borbottava l’ingegnere che stava andando in pensione. Ma Vittorio chiamato Roma per la sua provenienza e Carlo chiamato Cuneo perché era il suo reale cognome si scambiarono uno sguardo che diceva tutto: “Perché no?”.
Niente bacino? Nessun problema. Sul piazzale dell’officina, tra bidoni d’olio e reti da pesca abbandonate, costruirono uno scheletro d’acciaio sospeso che sembrava la colonna vertebrale di un drago marino. Un’ossatura lunga quasi il doppio dello scafo originale, progettata per reggere le due metà della barca come braccia “Pareva un dinosauro meccanico”, i passanti si fermavano a fissare quel mostro d’ingegneria: operai del porto, marinai, perfino qualche ragazzino come me.
Tagliare lo scafo e assemblare e saldare la parte centrale fu un lavoro durato settimane. Roma e Cuneo, con le tute macchiate d’olio, si alternavano alle seghe a nastro . Il laser per allineare il taglio era un aggeggio nuovo, preso in prestito con in mano una bottiglia di Amaro in cambio, da un cantiere navale vicino : lo regolavano come si fa con un binocolo, millimetro per millimetro discutendo sul corretto uso.
Quando inserirono la sezione centrale , perfetta come l’incastro di un puzzle ,aggiunsero longheroni diagonali che sembravano costole di una balena.
Di sera , quando l’officina era vuota, passavano alle saldatrici a gas. Le fiamme blu illuminavano il piazzale a giorno. Per controllare la temperatura, avevano un termometro a infrarossi “preso in prestito” anch’esso dall’officina vicina: “Lo ridiamo quando finiamo, promesso!” aveva detto papà al caporeparto, che si era limitato a dire “ voglio proprio vedere cosa combinerete“.
Il lavoro a cottimo li costringeva a tirare fino alla chiusura del porto. Gli ultimi minuti per controllare per la decima volta i punti di saldatura.
Il momento della verità arrivò con il sollevamento dallo scheletro: lo scafo allungato penzolava sulla gru, sferragliante ma compatto. “Tiene! Porca miseria, tiene!” urlò Carlo, mentre il signor Bianchi, per la prima volta abbozzava un sorriso.
Fu un lavoro duro e ordinario: mani bruciate dalle scintille, occhi arrossati dal fumo, e quella soddisfazione muta quando dopo poco più di 45 giorni lo scafo allungato superò il test di tenuta. Vittorio, appendeva al muro il termometro da restituire , ormai segnato da un cerchio nero di bruciature, cercando il modo migliore per giustificare il danno arrecato.
Quel lavoro oggi dimenticato era una leggenda nei cantieri genovesi. “Lo hanno fatto sul piazzale, come si spellano le acciughe!” diceva qualcuno. La barca navigò per anni, soprannominata “La Bislunga”, testimone che anche senza bacini milionari, il genio operaio può vincere.
Anni 2000.
Nel porticciolo dei Giardini di Govi zona del demanio di Genova, c’è la polisportiva dei lavoratori e dei pensionati del porto. Qui, tra gli scogli e la spiaggia di ciottoli levigati dalle mareggiate, Vittorio aiutava zio Gino a montare lo scivolo per il suo gozzo da pesca a 2 motori. Un lavoro semplice: due travi d’acciaio, un argano riciclato da un vecchio rimorchiatore, una cassa per gli attrezzi rivettata a mano quando arrivo il portuale pescatore di circa 40 anni col cappello di paglia “Scusi… lei è il cognato di Gigi?”. Vittorio annuì.
“Allora, visto che é stato un collega…” iniziò l’uomo, indicando l’argano: “Quel verricello, se lo inclina di tre gradi, non si inceppa con le alghe”. “Grazie del consiglio” disse. Per giorni, quell’ombra col cappello tornò: suggeriva nodi marinari, la vernice antivegetativa, persino come allineare le assi dello scivolo “per non spaventare i saraghi”.
Quando tutto fu finito , lo scivolo lucido come un gioiello e l’argano che srotolava il cavo con un ronzio perfetto, l’uomo riapparve. Aveva in mano due lattine di birra calda. “Ormai so che non serve… ma te le offro lo stesso”. E poi la domanda : “Tu sei Roma, vero?”. Vittorio non sentiva quell’appellativo dai tempi del piazzale GMG. “Sì” ammise, l’uomo si scoprì il capo, gesto antico. “Io… c’ero nel ‘78, quando alzaste lo scafo con quello scheletro da fantascienza. Mio padre diceva: ‘Guarda, quelli lì sanno parlare col ferro’”.
“Scusami se ho ciarlato prima ma non sapevo chi fossi”.
“Quel giorno, quando la gru sollevò la Bislunga… io avevo 16 anni, e decisi che sarei diventato come voi”. Vittorio rispose con un sorriso.Ma quella sera come raccontava zio Gino, mentre sistemava gli scalpelli nella cassa, sorrideva ancora pieno di orgoglio, quello vero, che non ha bisogno di monumenti. Perché a Genova, i ricordi grandi navigano sempre sottocosta, nascosti tra le onde e il fumo delle officine.
La vera grandezza di Genova non sta solo nei porticati dorati ma sta anche nelle mani che sanno piegare il metallo e il volere del mare, e anche negli sconosciuti che ne custodiscono la memoria, onda dopo onda.
Ad Antonio , Vittorio , Umberto, Speranza, Silvio, Eligio e Bruno, Figli di Enrico , Maestro di discrezione e di parole spesso solo sussurrate.
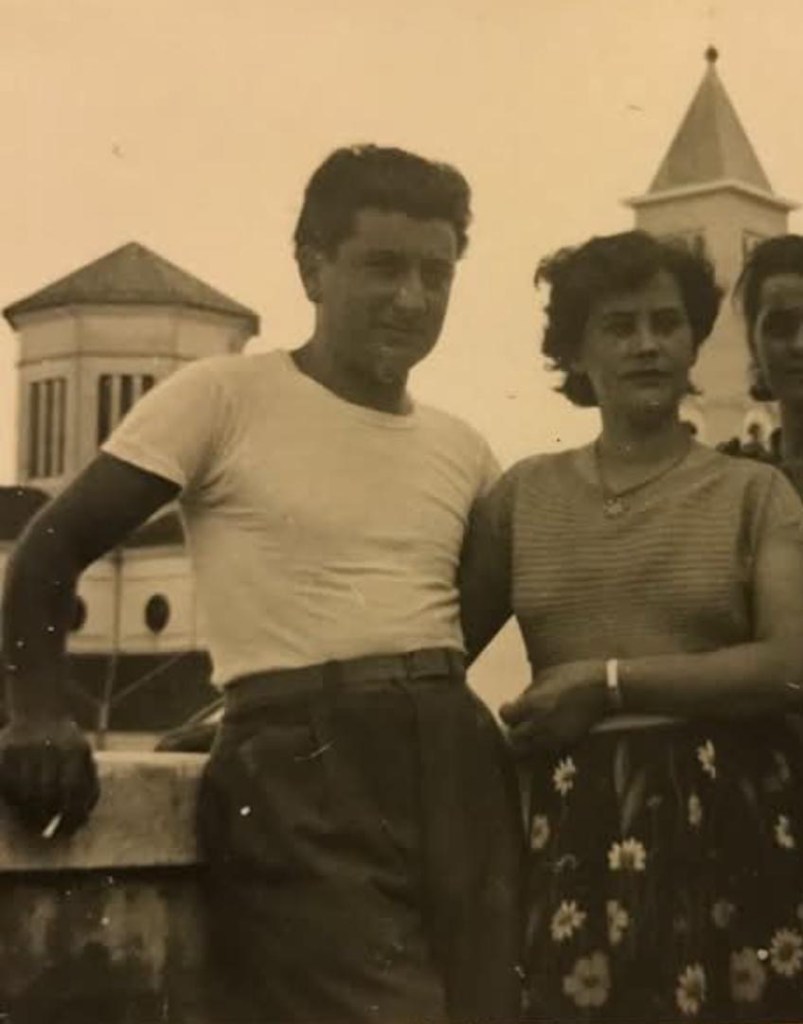
RIVALUTAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ

di Giacomo Pio Augello
Fin da bambini, ci hanno insegnato che le difficoltà che incontriamo lungo il nostro cammino siano segnali che scarsa propensione allo svolgimento di una certa attività e un invito, più o meno velato, ad abbandonarla per qualcosa di più accessibili alle nostre capacità naturali.
La cultura poi del “facile” propagandata a furor di followers sulle piattaforme social, ha fatto percepire le difficoltà come un qualcosa di estremamente negativo, davanti a cui il nostro desiderio di scoperta e di crescita deve fermarsi perché non “si sta andando nella direzione giusta (laddove giusta, significa “agevole”).
La mia esperienza nello studio del kung fu Choy Li Fut, uno degli stili di combattimento più completi al mondo, però, mi ha permesso di scoprire una verità controintuitiva che ribalta del tutto questa tesi.
Ho iniziato il mio percorso marziale che avevo gia’ 25 anni.
Dico già perché, sebbene fossi ancora anagraficamente giovane, nel contesto marziale mi sentivo già avanti con l’età.
Questo perché, ne ero consapevole, il mio corpo aveva perso parecchia dell’elasticità propria dell’età dello sviluppo mentre la mia mente si apprestava ad abbandonare i banchi dell’università per accedere al mondo del lavoro.
A ciò si aggiunga il fatto che, fino a quel momento, io avevo frequentato solo sale pesi, praticando senza risultati né prospettive un po’ di fitness.
Non erano proprio le premesse ideali per iniziare una disciplina che, si intuisce già dal nome, richiedeva tanto tempo per essere appresa.
La prima lezione che feci, confermò le mie intuizioni.
Oltre ad essere del tutto fuori forma, non avevo nessuna concezione di cosa fossero le basi di una pratica marziale: coordinazione, equilibrio, senso del proprio corpo, resistenza agli impatti.
Anche gli altri ragazzi che si allenavano con me, dopo avermi visto, commentarono: “Non durerà una settimana”.
Io, però, avevo dalla mia un’arma che poi si rivelò decisiva: una volontà indomabile, sorretta da due pilastri: 1) la profonda consapevolezza che niente nella vita è facile, perché niente è mai stato facile per me, nemmeno le cose ordinarie e 2) la percezione che quella scuola aveva qualcosa di diverso, di più di quello che gli altri sport mi avevano offerto fino ad allora.
Sono passati più di 15 anni da quella prima lezione.
Tutti i ragazzi che avevo conosciuto, molto più dotati di me, hanno abbandonato il percorso uno dopo l’altro di fronte alle prime difficoltà.
E io? Io continuo a studiare e, al momento, mi sto preparando per conquistare il grado nero e sogno di avere un corso tutto mio.
Vi chiederete: perché un brocco così è arrivato fino a qui? Forse perché il corso era semplice?
No. Tutto il contrario.
Ci sono arrivato proprio perché il percorso è stato ed è difficile.
Perché?
Perché ogni cosa che io ho imparato a fare, l’ho dovuta conquistare superando le difficoltà.
E ogni difficoltà che io ho superato in questo viaggio ha dato valore a ciò che ho conquistato.
Un valore che altri che non avevano queste difficoltà non hanno saputo vedere.
Non solo.
Ogni difficoltà superata mi ha reso consapevole della possibilità che avevo di superare la difficoltà successiva.
Tutto questo per dire, quindi, che, nel percorso della vita, le difficoltà non sono muri.
Sono scalinate che vanno affrontate perché danno valore a tutto ciò che troviamo lungo il percorso e perché ci rendono sempre più consapevoli di quello che possiamo ottenere.
Ora che vi ho rivelato la verita’ che io ho appreso, immaginate quale potere possa darvi questa intuizione se la portate nella vita di tutti i giorni.
Pensateci.

CULTURA, IDEE E CORAGGIO A PRATO

di Teresa Tardia
In tempi di incertezza e complessità come quelli attuali puntare sulla cultura, sulla diffusione di idee e sull’apprendimento appare un paradigma da condividere e da mettere in campo per creare nuove prospettive positive per lo sviluppo delle persone e della società in termini di responsabilità e sostenibilità.
In questa direzione va una bellissima iniziativa avviata dalla Città di Prato con un festival dal titolo “Seminare Idee” per immaginare un futuro migliore e più “sano”. Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato, con il sostegno della Regione Toscana. Il festival si terrà nei giorni dal 6 al 8 giugno 2025 nella favolosa città di Prato!
Tutte le iniziative si concentrano in tre giornate intense con conferenze, dialoghi, spettacoli, letture e laboratori per tutto il centro storico di Prato dal Teatro Politeama, al Chiostro San Domenico, dal Museo del Tessuto a Palazzo Pretorio fino a piazza San Domenico. La partecipazione è libera e gratuita e sul sito www.seminareideefestival.it si possono trovare tutto le informazioni e il programma completo. Numerose sono le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo tema, vengono riportati alcuni commenti dai principali esponenti coinvolti.
«Prato, da sempre città della contemporaneità – dichiara il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – conferma la sua vocazione con il festival Seminare Idee che è l’emblema del contemporaneo. A partire dal titolo che invoca il bisogno, oggi più urgente che mai, di tornare a condividere idee, per proseguire col tema del coraggio, ingrediente fondamentale per affrontare ogni cambiamento. La città di Prato, con la lucidità che spesso distingue le sue scelte, propone un laboratorio di tre giorni, in cui saranno toccati temi trasversali, tutti cruciali per tenere testa a quella grande sfida che è la complessità in cui siamo immersi. Un grande messaggio e un invito che sosteniamo e a cui non possiamo mancare».
«Di fronte a un presente che ci inquieta e che sembra incomprensibile alla luce dei vecchi paradigmi è diventato estremamente necessario superare l’afasia e lo stordimento che ci fa sentire impotenti, trovare il coraggio di guardare negli occhi la realtà e dirla con parole adeguate, accuratamente pensate, rispettose della verità. Questo festival vuol essere un modo di ritrovare insieme il significato profondo delle parole, e quindi la loro forza di cambiamento. È un messaggio diretto a tutti coloro che sentono l’urgenza di trovare nuovi percorsi di senso e di consapevolezza per affrontare il presente restando umani, in particolare ai giovani» afferma Diana Toccafondi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
«Il filo conduttore della rassegna toccherà ogni ambito: il coraggio di restare umani, di difendere i diritti, di costruire la pace, di vedere la diversità come ricchezza, di confrontarsi ogni giorno per migliorare noi stessi e gli spazi dove viviamo. Seminiamo l’idea del coraggio per vedere crescere una città europea, laboratorio di contemporaneità, operosa e aperta al mondo, una città che non ha paura del cambiamento, ma anzi, è pronta a cavalcarlo. Saranno tre giornate dense di appuntamenti culturali e letterari che permetteranno a chi parteciperà di scoprire il nostro centro storico ricco di bellezze e di angoli suggestivi» commenta Ilaria Bugetti, Sindaca di Prato.
«Il festival sarà uno spazio dove si incrociano pensieri diversi, trasversali a tutte le discipline. L’obiettivo è quello di far nascere una comunità di persone unite dal rito della condivisione e della cultura, facendo leva sulle più importanti fonti della conoscenza: curiosità, meraviglia e partecipazione – spiegano Annalisa Fattori e Paola Nobile, ideatrici e direttrici del festival. A guidarci, in questa prima edizione, è la parola Coraggio. Esiste il coraggio del noi, quello di agire per il bene comune, il coraggio della denuncia e della difesa della libertà di tutti, il coraggio che attraversa la storia facendosi pensiero e letteratura. Ma c’è anche il coraggio dell’io, quello che giorno dopo giorno ci sprona a progredire, che unisce e crea relazioni. Il coraggio si nutre della speranza per un futuro migliore».
Intervengono al festival personalità di spicco che hanno una grande capacità di divulgare e far sapere:
Il festival si apre con “Nessuna bilancia pesa il coraggio”, un dialogo tra Roberto Saviano, che ha riportato la Camorra all’attenzione della società civile, e Sandro Veronesi (scrittore due volte premio Strega): viviamo in tempi che ci obbligano a maneggiare con cura le parole, tempi in cui le domande sono più delle risposte, dove avere coraggio significa soprattutto scegliere. Sono scelte quelle del giudice Giovanni Falcone, protagonista del romanzo di Roberto Saviano “Solo è il coraggio”, e di Salvatore Todaro, al centro del “Comandante”, libro di Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis, che decise di salvare i naufraghi nemici.
Altra storia di coraggio è quella che a ottant’anni dalla Liberazione vede, Giorgio van Straten e Walter Veltroni – autori rispettivamente de “La ribelle” e di “Iris. La libertà” – nell’incontro intitolato Capitane Coraggiose, soffermarsi su due luminosi esempi di eroismo, quelli di due donne, Iris Versari morta a vent’anni e Nada Parri diventata sindaca alla fine della guerra e vissuta fino al 2017.
Non mancano le altre storie di coraggio dei giorni nostri con le ragazze di Teheran che sfidano ogni giorno lo Stato teocratico, chiuse in prigione, punite e uccise. Ne “Il coraggio della disobbedienza” Sadaf Baghbani, attrice e attivista iraniana colpita da 147 pallini di piombo, dialoga con la giornalista Cristina Giudici, raccontando come un’intera generazione è disposta a tutto per affermare il proprio diritto a emanciparsi, contro la fine dell’apartheid di genere e la violazione dei più elementari diritti umani.
Con uno sguardo femminile Francesca Mannocchi (giornalista e reporter) , con “Guardare la guerra negli occhi” ci porta, oltre la cronaca, dentro i dilemmi, ci fa comprendere che la guerra contro gli altri è anche una guerra contro se stessi. racconta non solo le conquiste, i confini, le battaglie, ma il coraggio di chi, senza averla dichiarata, è costretto a vivere la guerra: donne, bambini, sfollati e profughi.
Certamente di coraggio è il lavoro della giornalista Milena Gabanelli, con un focus sul libro “Codice Rosso”, scritto con Simona Ravizza, dove svelano che il nostro sistema sanitario sta per collassare: medici pagati a gettone, liste d’attesa infinite, pronto soccorso in tilt, macchinari obsoleti e personale sanitario ridotto all’osso. Affrontano tutto questo nell’incontro “Ospedali: né pronto, né soccorso”, in dialogo con la giornalista Simona Sala, dove Milena Gabanelli denuncia la situazione sanitaria attuale: dallo svilimento della medicina di base ai tagli alla sanità pubblica, dalle speculazioni del settore privato al grande giro d’affari delle assicurazioni.
Altre personalità di spicco di spicco della cultura, della scienza e delle arti saranno protagoniste del festival, chiamate a riflettere intorno alla parola Coraggio. una virtù che alimenta tanto la mente quanto il cuore ed è la forza motrice capace di nutrire ogni cambiamento, dal più piccolo al più grande.
Nel corso di 31 appuntamenti, tutti gratuiti, il pubblico incontrerà relatrici e relatori di discipline diverse – letteratura, scienza, economia, filosofia, poesia, storia e giornalismo – per condividere riflessioni e domande e aprire nuovi sguardi sul mondo. Il festival sarà arricchito anche da una sezione dedicata ai libri e all’editoria, “Seminare Idee Books”, a cura della Biblioteca Comunale Lazzerini, del Circolo di lettura Bardamu e della Libreria Gori, nonchè da una sezione dedicata ai più piccoli, dai 3 ai 14 anni, Seminare Idee Kids.
Un ruolo di primo piano durante il festival lo avranno i giovani: ragazzi e ragazze coinvolti nel progetto Prato Comunità Educante, una rete che unisce scuole e terzo settore nata per fronteggiare la povertà educativa e la dispersione scolastica.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 11

di Fabio Fumagalli

IL TIVOLI UNA VERA CUCCAGNA PER I TAGLIABORSE

di Giorgio Righetti
Dove sbucava da corso Garibaldi la via del Guast (attuale via Tivoli), a ridosso dell’Arena esisteva negli ultimi decenni dell’Ottocento, il più grande centro di malavita mai esistito prima a Milano. Il Tivoli attraeva moltissimi visitatori che non avrebbero mai immaginato che in un solo momento sarebbero stati derubati del portafoglio e dell’orologio, era un ambiente di ladri, di megere, sfruttatori e prostitute, la malavita al Tivoli si estendeva dappertutto, erano numerosissime le baracche da fiera presenti, vi dominavano i venditori ambulanti, sempre alla ricerca di qualche losco affare. Il Tivoli era la vera specialità di Milano, con pochi soldi si poteva assistere a spettacoli, salire su giostre, vedere mostri o altre varietà del genere. Nei baracconi si poteva trovare il terribile selvaggio catturato nelle foreste, “tenc come un magnan”, tanto sporco da sembrar nero, (in verità un poveraccio malmesso, con una gran parrucca vecchia di cappelli scarmigliati in capo che dietro le quinte parlava il meneghino), la sirena pescata nel Mar dei Caraibi, (una donna ormai avanti negli anni, che esibiva una grottesca coda di pesce finta). Faceva spettacolo una domatrice di tigri di nome Aissa un enorme donnone, tutta coperta di lustrini che finì sbranata dalle sue tigri mentre usciva dalla gabbia per andare ad annunciare al pubblico lo spettacolo. A fine Ottocento, intorno all’Arena era ancora campagna incolta, dove in permanenza alzavano le tende modesti circhi equestri, giostre, bersagli, baracche di fattucchiere, fachiri e mangiatori di fuoco. I prestigiatori facevano i loro giochi, fidando nella generosità di un pubblico di fortuna. Ovunque gruppi di gente, donne e soldati, le donnette di casa e quelle di fuori, le ragazze che cercavano marito e quelle che cercavano un cliente, operai col vestito della domenica e locch (specializzati in rapine e borseggi), sempre aitanti, vestiti con insolita eleganza. Il Tivoli era il campo di azione di questi lestofanti, brutti figuri “de man ladina” (di mano lesta), che favoriti dalla ressa sottraevano l’orologio e la catena d’oro dal gilè degli sprovveduti e ghermivano il borsellino a rete in uso a quei tempi, con una destrezza da non dirsi, allontanandosi poi con disinvoltura dai malcapitati che non si erano accorti di nulla. I “locch”, arrivavano dai loro quartier generale a Porta Tenaglia, da via Paolo Sarpi e soprattutto dalla via Canonica (la via dei lader), tutti avevano le loro donne (donne corrotte esse pure, si intende) che amavano e che sfruttavano. Questi personaggi che portavano cucito addosso l’etichetta di “lenocinio” si improvvisavano protettori, era con un cenno del capo che invitavano i potenziali clienti a seguirli per chiedere se volevano passare un po’ di tempo con una delle loro ragazze. Concluso l’affare cliente e peripatetica si incamminavano verso uno dei bordelli della zona, il ricavato andava in gran parte nelle tasche del locch. Tra il brulichio della gente e le grida degli imbonitori si diffondeva sempre il puzzo di frittelle cotte in olio riciclato maleodorante o di zucchero filato impastato senza la minima igiene dalle manacce sporche dei venditori. Questo era il vecchio Tivoli di Milano, un mondo caratteristico caro a scrittori e commediografi della fine Ottocento. Nel 1895 i baracconi del Tivoli vennero smantellati e i “locch”, passarono dal Tivoli a Porta Genova. dove da allora ebbe luogo la tradizionale fiera di Porta Genova.

IPAZIA

di Aurora Marella
355 d.C., 415 d.C. Due date. Nascita e morte.
Una storia antica che vorrei narrare brevemente qui. Ho scelto di raccontare la vita di una donna che, pur essendo un emblema delle fatiche femminili per una pari considerazione sociale, rimane poco conosciuta da tante persone. Queste date segnano l’inizio e la fine della vita di Ipazia. Ella è stata una pensatrice e studiosa vissuta ed uccisa ad Alessandria d’Egitto. La sua vicenda è antica ma naviga ancora nella corrente attuale. Studiava, Ipazia. Insegnava e osservava i fenomeni celesti. Era filosofa. Non era sposata. Figlia di Teone, geometra e filosofo, studioso di astronomia e osservatore del cielo. Insieme, scrissero un commento al “Sistema matematico” di Tolomeo. Allora, nel V secolo d.C., la teoria tolemaica era appunto considerata una teoria, non una certezza come sarebbe avvenuto nel periodo medievale. Nel 393 Ipazia era professoressa e rettrice dell’accademia alessandrina. Si dice che considerasse le aule troppo strette, che per studiare la natura delle cose occorresse viverle. Così Ipazia appare descritta all’aperto, al mare, sulle coste, in barca, sulla spiaggia, attorniata da discepoli attenti. Spiegava, svelava le leggi della Natura. Intuiva che il nostro astro, il sole, non fosse in moto ma immoto rispetto alla Terra. Cercava di dimostrarlo osservando i raggi del sole, le stagioni, i punti cardinali toccati dal suo arco. La scienza di Ipazia era creata dai suoi occhi che calcolavano, dalle ombre misurate, palmo a palmo, cubito dopo cubito. Dal mistero di numeri e forme di cui era innamorata. Ipazia era libera e a quei tempi era molto strano. Finché il padre Teone fu in vita, Ipazia restò ammirata e protetta. Alla morte del padre, Ipazia fu sola in un mondo retorico di giudizi verso le donne non sposate. Immaginarsi verso una donna non sposata, scienziata e docente. Studiava musica, filosofia e tanta matematica e discuteva e insegnava a classi maschili. Ma ora sarebbe rimasta sola. Sola con le proposte di matrimonio rifiutate, sola con le dicerie, sola con la propria scienza e il proprio ateismo. In quella società, una donna come Ipazia non poteva trovare una collocazione. Troppo libera, troppo audace, troppo indipendente, troppo svincolata dalle convenzioni e dai ruoli prestabiliti. Ma in quel mondo era comunque sola, fragile. Quello di Ipazia era un mondo dove tutto era intriso di religione. Siamo nel 412 d.C.: il vescovo Cirillo sale sul trono episcopale di Alessandria d’Egitto e inizia a governare in modo molto autoritario contrastando comunità di altre religioni anche in maniera violenta e repressiva. Lo sostengono dei monaci, i monaci parabolani. In precedenza, volontari che si dedicavano agli ammalati, ora corpo speciale di guardia dediti alla protezione dei vescovi alessandrini.
Ipazia era già conosciuta tra le fila delle personalità di Alessandria, ritenuta strega e donna arrogante. I vescovi la temono, la sprezzano, la tacciano di stregoneria. I monaci-guardie del corpo la osservano, cresce il fanatismo. Arriva il giorno stabilito. La seguono, la braccano, la trascinano nella chiesa del Cesareo, un tempio di Augusto riadattato ad essere chiesa cristiana. Porte chiuse. Il finale è immaginabile, tragico, straziante. Si parla ancora, nella difficile traccia di questo passato, del senso di questo evento e di altri appartenenti alla stessa natura. Un evento e tanti eventi contro un genere ritenuto debole, sottomittibile. Quello di Ipazia, anche contro la conoscenza e la scienza, perché poste tra tempie femminili e non nei templi strutturati solo al maschile. E oggi, noi ci sentiamo così emancipati da questi preconcetti, da queste infrastrutture decadenti eppure così caparbie, che si riflettono, malgrado tutto, ancora in tante piccole pieghe della società, della famiglia, dell’ufficio, della giornata, del pensiero. Questa storia è poco conosciuta ancora, forse. Ora è anche qui, a disposizione dei Lettori. E a disposizione mia, che l’ho studiata, imparata, anche giudicata, lo ammetto. Una storia che è emblema e che a distanza di millecinquecento anni resta trasparente come vetro. E altrettanto tagliente.

LA PICCOLA PARTIGIANA

di Luigi Filipetto
Era mia sorella, si chiamava Pierina, aveva 12 anni.
Nei primi mesi del 1945 correva un clima di trattenuta impazienza. Gli Alleati si stavano avvicinando. Pierina aveva vivo il ricordo dei racconti di chi andava di notte a vedere i paracaduti degli alleati che scendevano dal cielo sui prati illuminati a giorno. Ricordo anch’io i contadini che tornavano dai campi con un paracadute sopra il carro di fieno.
Fino alle ore tarde di sera Pierina controllava i movimenti sulla strada nascosta dietro la siepe dell’orto. Passavano i camion dei tedeschi, passavano i camerati delle ronde. Se si fermavano davanti a casa, correva di sopra a svegliare i fratelli che saltavano giù dalla finestra e sparivano tra i campi. A volte dormivano nell’orto sotto il pero. Anche quella sera, quando un camion di tedeschi prese male la curva e sfondò la siepe dell’orto. Voci agitate, ordini, risate non riuscirono a svegliare i fratelli che continuarono beati a dormire. Non furono scoperti. Miracolati!
Capitava che all’ora di pranzo entravano in cucina le camicie nere, naturalmente senza chiedere permesso. Erano informati della militanza fra i partigiani del fratello Oneglio, ma erano anche a caccia di ragazzi da reclutare fra le formazioni fasciste. Entravano quindi e, di fronte alla tavola già preparata con sei piatti, due dei genitori e quattro dei fratelli più piccoli a partire da lei giù giù fino ai quattro anni, volevano sapere chi sedeva di fronte a quei piatti. Pierina, che era già allertata per queste incursioni, rispondeva semplicemente che erano per i suoi fratelli piccoli.
Pierina incontrava i partigiani nel campo dei nonni. Si muovevano isolati, mai in gruppo. Dormivano nei casolari. Un giorno sbucò dalle piante di mais un ragazzo che teneva legata sulla spalla una civetta. Scambiò qualche parola con Pierina, poi però disse che doveva andare perché la civetta si agitava. Era segno che nelle vicinanze dovevano esserci movimenti sospetti. Passavano anche le ronde fasciste, chiedevano a Pierina se per caso aveva visto qualcuno in giro e lei pronta diceva no, non ho visto nessuno.
Fuori dal paese c’era una zona boscosa. Là si nascondevano i partigiani scesi dai monti. Spesso correvano voci di retate fatte dai tedeschi nel bosco. Vicino al bosco viveva la famiglia Lot, dove i partigiani lasciavano messaggi a voce. A Pierina il comitato di liberazione aveva affidato l’incarico non privo di pericoli di recarsi dai Lot e poi riferire. Una bambina suscitava meno sospetti. Succedeva che per strada si trovasse davanti un mitra spianato e che le venisse chiesto dove andava o da dove veniva. In questi casi era pronta a scoppiare a piangere e dire fra le lacrime che andava o che veniva dai Lot per prendere un po’ di farina. I lacrimoni erano la sua tattica abituale. Più tardi Pierina sposerà uno dei figli Lot.
Il 6 di aprile ci fu in paese un vero massacro. La notte precedente una ronda di fascisti fu intercettata da un gruppo di partigiani vicino a casa nostra. Nel corso della sparatoria un camerata era rimasto ucciso. Pochi minuti dopo la sparatoria, Pierina da dietro la siepe aveva visto un’ombra scappare. Interrogata dal comitato di liberazione non aveva potuto descrivere la persona che scappava. Stava ancora dietro la siepe, quando passò un camion di SS, che alla vista del morto avevano proceduto sghignazzando. Dalla finestra di fronte a noi si era affacciata la “Checa Bero”, una vecchietta con la candela in mano. I tedeschi le gridarono di ritirarsi e di spegnere la candela.
Viveva con “Nane Repeton” nella miseria. La mamma dava in mano a Pierina un piatto di pasta o una scodella di brodo che lei portava ai due vecchietti. Il giorno dopo ci fu la vendetta dei fascisti. Furono sequestrati in dodici. Alla fine decisero di dimezzare. Furono messi al muro in sei e fucilati. Nonostante le suppliche del parroco. Rimasero stesi sulla strada per un giorno intero come ammonimento al paese. Spinto dalla curiosità, mi avvicinavo ai morti e poi correvo a casa prima che la mamma si accorgesse della mia assenza. Il paese era nella disperazione. Lo strazio dei famigliari era aggravato dal fatto che era proibito sostare presso i morti. I parenti accorrevano per poi scappare alle voci che stavano arrivando le ronde. Era proibito anche piangere i propri morti. Fra i morti era giunta a casa la voce che c’era Onelio. Le donne vicine erano accorse a consolare la mamma angosciata. Che a un certo punto mise in mano a Pierina il secchiello del latte e le disse di fingere di andare alla latteria. Pur sapendo che a quell’ora era chiusa. L’importante era che Pierina vedesse se tra i morti c’era anche nostro fratello Onelio. Anche quel giorno Pierina si trovò il mitra spianato davanti. Scoppiò a piangere e disse che andava a prendere il latte. Appena fuori dalla vista del camerata, tornò sui suoi passi. No, non c’era Onelio. Le donne della contrada chiedevano a mia mamma di mandare Pierina a fare le commissioni che interessavano a loro. Era meglio non farsi vedere in giro per il paese. Sapevano che la piccola Pierina se la sbrogliava bene. Nel tardo pomeriggio stavo sulla strada, appoggiato al muro di casa. Passò un carro trainato da un cavallo a passo lento e la testa bassa che portava nel paese confinante tre dei sei cadaveri. Erano distesi sulla paglia, coperti in qualche modo e con i piedi fuori. Conduceva il carro un cugino di uno dei tre morti, di appena 18 anni.

FRANCESCO

di Alessandro Bocci
La scomparsa di Papa Francesco ci rattrista e ci addolora. La sua capacità di non arretrare di fronte agli ostacoli ha segnato un’epoca. Francesco ha denunciato ogni forma di sfruttamento, in primis quella dell’uomo sull’uomo, ponendosi dalla parte degli ultimi, dei diseredati della terra. La sua voce si è sempre levata forte e chiara contro le disuguaglianze e la cultura dello scarto e non ha mai smesso di evidenziare i limiti di un’economia basata solo sulla logica del profitto.
Un Papa che, come i suoi predecessori, ha sempre parlato di pace, anche sapendo che le sue parole avrebbero potuto essere strumentalizzate. Un Papa che, incurante dell’impopolarità che ne sarebbe derivata, ha condannato la pratica dell’aborto e che ha difeso il diritto dei bambini di avere una mamma ed un papà. Un Papa che nessun uomo politico può permettersi di iscrivere alla propria parte.
“Wojtyla l’anima, Ratzinger la mente, Bergoglio il cuore”, ha scritto Ezio Mauro su Repubblica, rappresentando la terna, voluta dallo Spirito Santo, dei tre Papi della contemporaneita’. Tre grandi Papi, ognuno caratterizzato dal proprio carisma, con in comune la preoccupazione della scristianizzazione del mondo.
Il gesuita Francesco è stato un uomo di Dio che si è sempre riconosciuto nell’insegnamento di Sant’Ignazio di Loyola e che attraverso le opere e l’esempio personale ha parlato ai non credenti. “La Chiesa… è la Casa del Padre dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”, ha scritto il Papa “venuto quasi dalla fine del mondo” nell’Evangelii gaudium,l’esortazione apostolica del 2013.
Francesco lascia a tutti gli uomini l’eredità preziosa di una Chiesa accogliente che affronta il futuro con fede e speranza. Tocca a noi non lasciare cadere la grandezza del suo messaggio.
“ORA E SEMPRE RESISTENZA”

di Giorgio Righetti
L’epigrafe di PIERO CALAMANDREI ad Albert Kesserling, comandante delle forze di occupazione naziste in Italia e responsabile della STRAGE DELLE FOSSE ARDEATINE.
Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d’ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ORA E SEMPRE RESISTENZA.
Piero Calamandrei
LA PRIMAVERA DELLA LIBERTÀ. 25 APRILE 1945.
IL VENTO DEL NORD. In quel tardo pomeriggio di 80 anni fa si stava alzando il vento a Milano, un VENTO FREDDO PROVENIENTE DA NORD, un vento impetuoso e liberatore, che non si sarebbe calmato finchè tutte le forze ostili alla democrazia non sarebbero state spazzate via, soffiava con tutta la sua forza tra enormi quantità di macerie e devastazioni, che testimoniavano cinque anni terribili di miserie, lutti e sofferenze. Cominciata con una disfatta, l’ITALIA CON IL 25 APRILE FINIVA NELLA RESURREZIONE.
G.R.
29 APRILE 1945. PIAZZA LORETO. Corde strette alle caviglie e legate ai tralicci di un distributore di benzina, due corpi più vicini a loro rispetto agli altri Benito Mussolini e Claretta Petacci, intorno una moltitudine di gente inviperita, era il 29 aprile 1945, un epoca di terrore si concludeva quel giorno con un ORRENDO SPETTACOLO DI MORTE, un capitolo oscuro della nostra storia, una brutta pagina, che per il suo disumano rituale aveva sdegnato anche i partigiani. Cosa era successo? Prima dell’alba un autocarro proveniente dal lago di Como che trasportava i corpi di 16 gerarchi fascisti giustiziati a Dongo il 28 aprile, più le salme di Benito Mussolini e Claretta Petacci fucilati a Giulino di Mezzegra si fermava (non a caso) in piazzale Loreto nel posto dove un anno prima il 10 agosto del 1944 erano stati fucilati quindici partigiani, oltraggiati e esposti al pubblico per due giorni, l’autocarro deponeva il suo lugubre carico davanti a un distributore di benzina, subito si spargeva la voce, accorreva la folla per vedere, e in poco tempo la ressa era tale che per mostrare a tutti i cadaveri, sei di loro venivano appesi a testa in giù ai tralicci del tetto di un distributore di benzina e, esposti per diverse ore a insulti, sputi, lanci di oggetti di ogni genere, a colpi di arma da fuoco e calpestati da una folla inferocita. La gente che si era accalcata per guardare il terribile spettacolo assisteva anche a una esecuzione, quella di Achille Starace, che arrestato a Porta Ticinese, quella stessa mattina veniva trascinato in piazzale Loreto davanti alle salme dei suoi ex camerati e fucilato. Starace sarà la settima salma appesa a testa in giù. Sandro Pertini commenterà: “L’insurrezione si è disonorata. Io, il nemico, lo combatto quando è vivo e non quando è morto. Lo combatto quando è in piedi e non quando giace per terra”.
Il poeta Salvatore Quasimodo che in quel giorno lontano del 1945 si trovò a passare da piazzale Loreto, vide quello che stava succedendo andò a casa e compose la poesia lirica: “LAUDE”, dove il poeta immagina un colloquio tra il figlio morto e la madre, ritratta mentre insieme alla folla infuriata lancia sputi e parole di disprezzo sul cadavere di Mussolini legato per i piedi e appeso a testa in giù alle travi della tettoia del distributore di benzina. “LAUDE”, esprime emozioni e riflessioni, in sintesi dice:
FIGLIO: E perché, madre, sputi su un cadavere?
a testa in giù, legato per i piedi
alla trave? E non hai schifo degli altri
che gli pendono a fianco?
No madre, fermati: grida alla folla
di andare via.
MADRE: Sempre abbiamo sputato sui cadaveri,
figlio: e fosse solitudine o tumulato,
occhio per occhio, dente per dente,
Il nostro cuore ha voluto aperto
l’altro cuore che aveva aperto il tuo, figlio.
La poesia si conclude con la frase:
Da secoli la pietà è l’urlo dell’assassinato.
Infatti guardando un filmato di repertorio Combat Film dell’Archivio Storico Istituto Luce, si vede una donna non più giovane, vestita di nero, che impreca e sputa sul cadavere di Mussolini. Solo i morti (è detto per assurdo) sono capaci di perdono e pietà anche per i loro assassini (perché sono morti), mentre i vivi non possono dimenticare.
Lo spettacolo di quei cadaveri appesi a testa in giù mi ha sempre suscitato una severa riprovazione, ma forse ogni giudizio va riportato nel contesto storico di quegli anni e da tutte le sofferenze e i lutti patiti dalla popolazione durante il fascismo.

IL FISCO ITALIANO AD APRILE 2025: NOVITÀ E IMPATTI DELLA LEGGE DI BILANCIO

di Emanuela Maritato
Ad aprile 2025, il sistema fiscale italiano sta attraversando una fase di riforma significativa, con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha introdotto numerose modifiche destinate a influenzare cittadini, imprese e professionisti. Ecco una panoramica delle principali novità fiscali.
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato e reso strutturale la revisione delle aliquote IRPEF, articolate in tre scaglioni:
23% fino a €28.000
35% da €28.001 a €50.000
43% oltre €50.000
Inoltre, è stato confermato il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40.000:
Fino a €20.000: riduzione contributiva
Da €20.001 a €32.000: detrazione fissa di €1.000
Da €32.001 a €40.000: detrazione decrescente fino a zero.
Queste misure mirano a sostenere i redditi medio-bassi, con benefici estesi a circa 3 milioni di contribuenti.
Per stimolare la crescita economica, sono stati introdotti incentivi per le imprese:
Credito d’imposta Transizione 4.0: eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali e introduzione di un tetto di spesa di €2,2 miliardi per gli investimenti in beni materiali.
Credito d’imposta Transizione 5.0: incremento dell’aliquota al 35% per investimenti superiori a €10 milioni e per impianti fotovoltaici.
IRES Premiale: riduzione dell’aliquota dal 24% al 20% per le imprese che destinano almeno l’80% degli utili a riserva e il 30% di questi a investimenti in beni strumentali nuovi.
Per i cittadini, sono previste modifiche significative:
Detrazioni IRPEF: per i redditi superiori a €75.000, le detrazioni sono limitate in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico.
Bonus Casa: detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 per interventi di recupero edilizio su abitazioni principali, con un limite massimo di spesa di €96.000.
Superbonus: detrazione del 65% solo per interventi per i quali al 15 ottobre 2024 risulta presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare.
In materia di fatturazione elettronica, obbligo per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali dal 31 marzo 2025.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riflettono l’impegno del governo nel sostenere la crescita economica, semplificare il sistema fiscale e incentivare gli investimenti.

L’OMBRA CHE CI ABITA. UNA RIFLESSIONE SULLA NATURA UMANA, IL NARCISISMO È L’URGENZA DI RICONOSCERE IL MALE IN NOI

di Nurgül Çokgezici
Siamo esseri umani profondamente limitati. È una verità che facciamo fatica ad accettare, forse perché sin da piccoli ci viene raccontato il contrario. Ci illudiamo di essere unici, centrali, necessari. E spesso, aggrappati a questa convinzione, ci sentiamo minacciati dall’altro, dalla sua esistenza, dalla sua differenza.
Ma se guardiamo bene dentro di noi, forse possiamo ammettere che è una fatica enorme accettare l’altro per ciò che è. Una fatica che ha radici profonde: nasciamo soli, anche se contenuti nel corpo di un’altra. Per nove mesi viviamo un’esperienza di simbiosi assoluta, e poi, per almeno due anni, la nostra sopravvivenza dipende totalmente da una figura accudente. Il nostro corpo lo sa: se nessuno si prende cura di noi, moriamo.
Questa memoria arcaica genera un bisogno viscerale di amore, attenzione, centralità. È da qui che nasce quel che la psicoanalisi ha chiamato narcisismo primario. Un’esigenza di essere visti, riconosciuti, amati incondizionatamente.
Negli ultimi anni, però, il termine “narcisismo” è stato associato quasi esclusivamente a disturbi, deviazioni, patologie. Il “narcisismo maligno” è diventato uno spauracchio della contemporaneità, una diagnosi comoda per spiegare i comportamenti tossici. Ma chi può dire di esserne del tutto immune? Chi non ha mai desiderato essere al centro, essere speciale, essere il prescelto?
Il problema, forse, non è il narcisismo in sé, ma la mancanza di un’educazione emotiva capace di guidarci nel riconoscerlo, contenerlo, trasformarlo. Cresciamo senza strumenti per confrontarci con le nostre ombre. Senza parole per dare forma a quella parte di noi che non è pura, né buona, né facile da mostrare.
Per secoli, religioni, mitologie, ideologie e letteratura ci hanno parlato del bene e del male come due entità separate, contrapposte. Il male, quasi sempre, era l’altro. Noi eravamo i buoni, i forti, i giusti, le vittime. In questo modo siamo stati manipolati da una narrazione unilaterale, che ci ha impedito di fare i conti con il male dentro di noi. Nessuno ci ha insegnato che anche noi possiamo distruggere, odiare, mentire. Che anche noi possiamo ferire. Così abbiamo nascosto queste parti, le abbiamo rimosse, fino a non riconoscerle più.
Anche i grandi personaggi della storia – Gesù, Maometto, Gandhi, Rumi, Platone, Socrate – ci sono sempre stati raccontati come figure perfette, illuminate, pure. Ma cosa sarebbe successo se ci avessero mostrato anche le loro fragilità, i loro conflitti interiori, le loro cadute? Forse ci saremmo sentiti autorizzati ad accogliere anche le nostre. A non vergognarcene. A viverle come parte della nostra umanità.
Ecco perché, personalmente, trovo così prezioso il pensiero yezida. Una spiritualità che invita ad amare non solo il Dio buono, ma anche quello “cattivo”. Perché il bene è già accolto, già onorato. Ma è l’ombra che ci insegna a vedere davvero, a difenderci, a comprendere il mondo e noi stessi. È attraverso l’ombra che impariamo a essere completi.
Solo abbracciando la nostra oscurità possiamo veramente evolvere. Non per diventare perfetti, ma per diventare interi.

NUOVO SPETTACOLO 2025 !!!!

di Fabio Fumagalli
Bentrovaa gent al nòster pontèll n. 10!
L’è el mes indoe ve parli d’ona manera de dì milanesa che la dael titol al nòster spettacol (vedi locandina). Spettacol de minga pèrd.
Va’ a ziffolà l’Aida (pron.: sifulà)
Bellissima e colorida espression (letteralment la voeur dì: “Vai a fischiare l’Aida!”) la se disquand se voeur tirass via on quaivun dai pee. La reson de ’sta manera de dì la sta in la popolarità che la musica de l’Aida la gh’ha avuu in Italia appèna dòpo la soa prima rappresentazion a la Scala de Milan, el 8 de febrar del 1872.
Giuseppe Verdi l’hann ciamaa per ben 33 vòlt sul palchscènich e la gent, subit finii el spettacol, giamò foeura del teater la ziffolavai ari pussee facil. Da allora, quand ona persòna la saveva nò ’se fà, l’era sora penser ò la spettava on quaivun ò on quaicòss, ghevegniva natural ziffolà l’Aida, come incoeu se fa cont i canzonèttpussee famos. Sicur che el Giuseppe Verdi a la Hit Parade l’avaria strasciaa tutti, anca come botteghin. Pensee che a la prima assoluta de l’Aida al Cairo (24 dicember 1871) el Kedivè d’Egitto el gh’hadistaccaa on assègn de 150.000 lira de allora. Disèmm on 500mila euro d’incoeu!
Ve spettom el 25 de magg. La sarà l’occasion per passà dò or in allegria cont i nòster scenètt e tanta musica meneghina. Podarii trovà anca i nòster famosissim tazz de collezionà (vann ben anca come pòrtapenn, come pòrtafior ò per fà on penser a on amis/a) con sù stampaa i provèrbi e i maner de dì milanes.
Naturalment andii avanti a scriom a l’indirizz sòtta riportaa e chi el gh’ha i sòcial el pò trovamm su Facebook, Instagram e Youtube: “Scuola di milanese”. Bon Magg a tucc e….. s’ciao.


SE MIO FRATELLO DEVE MORIRE MORIRÒ CON LUI
QUEI GIORNI NEL CUORE DELLA MORTE

di Luigi Filipetto
Così i due fratelli ebbero salva la vita e quelli che imbracciavano i mitra fecero cadaveri gli altri sei. I più
grandi chiamavano sten quelle armi di morte. Sono nato in momenti di paura e anche di terrore.
Inginocchiato a terra nell’orto fuori di casa, la testa abbassata in avanti, le mani sopra la testa, muovevo
nervosamente la schiena come mi avevano detto di fare nel caso in cui mi cadessero addosso le schegge e piangevo forte. Intanto cadevano le bombe di Pippo, un fracasso e una puzza da morire. Dicevano che
l’aereo veniva dalla Jugoslavia, altri da Aviano. Fatto sta che appena di sera sentivi il suo rumore si
spegnevano tutte le candele perché quello non scherzava. Il pericolo sempre. Per andare a casa dei nonni attraversavo gli orti dei vicini perché era pericoloso andarci per la piazza. Finito l’orario delle lezioni ci mandavano a casa a gruppetti di tre o quattro con la consegna di camminare, di non correre.
C’erano quelli e c’erano quegli altri che combattevano quelli, si chiamavano i partigiani. Scendevano
di nascosto dal monte Cansiglio. Mio fratello posava il mitra sul davanzale mentre si lavava. Mia madre a
dirgli sbrigati, scappa che se ti prendono sai quello che ti fanno. E lui scappava insieme a un amico che si
portava con sé. Si chiamava Tigre l’amico. Io fissavo i suoi occhi grigi mentre controllava la strada fuori con la tendina appena spostata. Sì era tigre. Il suo mitra era sul tavolo, anche a letto lo teneva sul comodino.
C’era anche chi sbucava dal campo di mais dopo aver dormito lì in mezzo. Portava una civetta legata sulla spalla, serviva da allarme in caso di movimenti sospetti.
Guardavo con gli occhi sbarrati quei sei cadaveri. Il padre di Rosario stringeva a sé il corpo del
figlio, il sangue si era incollato sulla sua camicia e sulle mani. Anche la sorella abbracciava il fratello morto.
Poi il grido: arrivano. Tutti a correre a casa. Non si poteva stare lì. La sorella li sfidò e rimase con suo
fratello, non le importava di morire anche lei. A casa, poche porte più in là, il fratello voleva ammazzare
tutti, li ammazzo gridava. La mamma non farlo gli diceva con le lacrime, anche le altre donne facevano di
tutto per fermarlo. Il padre, trascinato a casa e seduto su una sedia, si guardava le mani insanguinate. Se il fratello fosse uscito di casa con la pistola gli sarei andato dietro perché se lo meritavano.
Un altro fu ammazzato sotto gli occhi di sua moglie. Le era stato impedito di uscire di casa. Dalla
finestra guardava giù il cadavere di suo marito e continuò a gridare assassini per tutto il giorno. Pochi giorni dopo morì per il dolore. Nel cimitero ora stanno uniti insieme e quando mi capita di indugiare davanti alle due foto mi sento come il ragazzino di allora. Sopra di loro un po’ più su c’è la foto di Rosario. Un silenzio glaciale si era sparso nelle case. Passò un giorno e finalmente fu concessa l’autorizzazione di portare nel paese confinante i tre corpi dei suoi cari. Stesi sul carro, coperti in qualche modo con la paglia, fissavo i piedi nudi che venivano fuori. Il cavallo procedeva a passo lento con la testa bassa.
Il 25 Aprile fu riempito dal grido di un ragazzo. Era un urlo più che un grido. Siamo liberi, urlava.
Le corde del collo grosse come le dita, la camicia aperta davanti, la bandiera dell’Italia sulla destra, la
sinistra sul manubrio della bici. La sua voce squillante non la smetteva di dire a tutti che eravamo liberi,
come per farsi sentire anche dai morti. Correva di qua e di là per il paese. Io stavo come d’abitudine sulla
strada appoggiato al muro di casa. Mi passò davanti, gli sarei corso dietro. Capivo solo che ero libero
anch’io. La sua voce era così potente che mi penetrò dentro, liberò i pesi delle paure e mi sentii come
sollevato da terra. Basta paura! La mamma mi portò di sopra, aprì il comò, da sotto le lenzuola tirò fuori la
bandiera italiana. La legammo insieme alla finestra. Era la seconda bandiera che vedevo in pochi minuti, la nostra. Tutto era precipitato a distanza di pochi giorni da quei sei morti ammazzati innocenti il sei di aprile 1945. Pochi giorni dopo il vicino di casa mi aveva chiamato allungandomi un cioccolatino. È degli
americani, disse.

UNA GUERRA PER LA PROTEZIONE DELL’ESISTENZA. RIFLESSIONE SULLA LOTTA CURDA, SUL SUO LEADER, SU QUANTO CIRCOLA.

di Aurora Marella
Con accesa umiltà mi accingo a leggere di un uomo e volerne raccontare la storia, in
modo semplice, lineare, che possa io stessa comprendere, in un dedalo di sfaccettati
avvenimenti incastrati tra governi potenti, paure ancestrali e vita quotidiana.
Io per prima non ne so molto e non ne ho mai saputo finora: è una storia che si perde tra
le pietre dei deserti del Medio Oriente, le sue città e un’isola prigione e che qui,
nell’occidente rumoroso dei centri commerciali, purtroppo ha ancora poca voce. E poche
orecchie.
Per questo mi appresto a proporre l’argomento, con remissione e ascolto, cercando di
riportare, senza troppi errori – spero – questa vicenda che parla di guerra e persecuzione
ma anche di libertà e lavoro.
Vorrei narrare di Abdullah Öcalan. Un uomo curdo. Un uomo. Uno. Il suo popolo.
Riconosciuto da esso e dal mondo, il suo leader.
Alla fine degli anni ‘80 fondò il partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK. Era convinto che
la formazione politica dovesse essere la sua base, più importante dell’addestramento
militare. Era un partito che non era solo politico e ideologico ma, nel mondo in cui nacque,
era anche un gruppo militare che doveva anche agire per il popolo che rappresentava.
Doveva agire contro un governo che non riconosceva il popolo curdo.
Una guerra per la protezione dell’esistenza è la definizione che questo attivista
rivoluzionario ha conferito alla lotta armata che guidò in quegli anni, quasi un ventennio. Si
tratta di una definizione incisiva e forte: proteggere la propria esistenza combattendo,
come un partigiano, come chi lotta per se stesso e per coloro a cui si sente di appartenere,
la cui esistenza viene minacciata da forze più invasive e occludenti, controllanti. La Storia
che si ripete, nella Storia dell’umanità, ancora una volta, per un altro popolo ancora.
Nel suo lavoro di lotta e politica, Öcalan mantenne sempre i contatti con i curdi distribuiti
tra Iran, Iraq, Siria e Turchia, il Libano, il Medio Oriente e collaborò con l’organizzazione
per la liberazione della Palestina. E scrisse tanti, tanti libri e i suoi discorsi vennero
trascritti per combattere le ideologie della repressione e della disuguaglianza.
Raccontò della persecuzione subita dal popolo curdo per cui i governi hanno
disconosciuto la lingua, la religione e la cultura di questo popolo togliendo la legittimità
della sua esistenza. Teorizzava e agiva per la libertà del suo popolo, delle sue donne e dei
suoi lavoratori.
Cercò dialogo tra lo stato turco e il PKK ma rischiò di essere ucciso. Venne esiliato dal
Medio Oriente e nel 1998 fu costretto a lasciare la sua Terra. Viaggiò in Europa sempre
cercando di portare avanti la propria lotta politica per la libertà e per la pace nei territori
curdi. Decise di proseguire il proprio lavoro nel Sudafrica ma non vi arrivò mai. Venne
sequestrato e riportato in Turchia. Era il 1999. Febbraio.
Un processo fittizio, la condanna a morte. L’abolizione di questa pena nel 2002 quando la
Turchia negoziava per affacciarsi all’UE. La condanna all’ergastolo. La Camera Europea
per i Diritti dell’Uomo (CEDU) che riconobbe disumane queste vicende.
Ad oggi nessun adeguamento di rotta.
E ora?
Ora quell’uomo attende. Attende la vita. Che la vita vada avanti. Con le sue idee. Con le
sue lotte. Con il potere catalizzatore che ha trasmesso per questi 25 anni. Con le parole
che ha usato sempre: libertà, popolo, donne, pace, dignità.
Ora quell’uomo continua a scrivere, sebbene in isolamento su un’isola militare turca nel
Mar di Marmara per cui riportarne qui il nome mi risulta impossibile per mancanza dei
caratteri giusti sulla tastiera.
E ci sono stati tentativi di negoziati per la pace turca e per il popolo curdo ma, tra picchi e
punti morti, tutto è tornato in mano ai militari.
E ancora quell’uomo resta rinchiuso.
Molti i movimenti politici e popolari che ne chiedono il rilascio, ovunque.
Una riflessione, la mia. Breve. Semplice. Uno sguardo appoggiato su un disastro sociale.
Su scontri titanici tra guerra e libertà, tra identità e disgregazione, tra dominio e
convivenza. Questione curda come altre questioni nel mondo, detenzione oltre ai limiti
dell’umano come altre tuttora in atto.
Esprimere idee e lottare per la pace e per il riconoscimento diventa una guerra in questo
mondo al contrario.
Arrivo a questa frase finale. Un po’ triste, un po’ rammaricata, un po’ incredula, un po’
sbigottita perché non se ne parla ad alta voce. E schiacciata tra la mia condizione e quella
di altri uomini e donne nel mondo sotto la patina occidentale.
Mi misuro il cuore.

IL RISORGIMENTO ITALIANO AL FEMMINILE

di Giorgio Righetti
CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO è stata una nobildonna italiana, una importante patriota che contribuì attivamente al Risorgimento Italiano con la sua attività di scrittrice e giornalista. Nata a Milano in una famiglia benestante il 28 giugno 1808, nel palazzo Trivulzio piazza Sant’Alessandro 1. Cristina non conobbe mai il padre Gerolamo Trivulzio che morì nel 1812, quattro anni dopo la sua nascita. La madre Vittoria rimasta vedova si rifugiò nella residenza materna di campagna Villa Litta di Affori. La villa era già sede di un salotto intellettuale frequentato tra gli altri da Alessandro Manzoni e dal pittore Francesco Hayez. Nei due secoli precedenti era stata ritrovo della nobiltà milanese e sede di feste fastose. La madre Vittoria Gherardini aveva educato Cristina agli ideali di libertà, indipendenza, unità e, in seconde nozze aveva fatto di un carbonaro il marchese Alessandro Visconti d’Aragona, il padrigno di Cristina. Cristina era una bellissima ragazza di soli sedici anni quando decise di sposare Emilio Barbiano principe di Belgioioso (24 settembre 1824), grande e perverso libertino, il matrimonio durò solo “qualche notte” tanto da farle capire che il marito aveva abitudini sessuali non conformi ai suoi gusti, in effetti le lasciarono un dono inaspettato, la sifilide. Cristina dopo la separazione si ritrovò giovane, bella, molto ricca, amava circondarsi da una parte dei giovanotti più stravaganti e dall’atra dagli intellettuali più distinti. Esile di costituzione l’unica cosa che le mancava era la salute, oltre la sifilide e l’asma, soffriva di frequenti attacchi epilettici, un male che la tormenterà a fasi alterne per tutta l’esistenza. Con l’appoggio del Patrigno la principessa di Belgioioso cominciò a frequentare il mondo della carboneria, divenne amica e a volte l’amante dei più importanti rivoluzionari del suo tempo. Il suo peggior nemico il Conte Harting, capo della polizia austriaca, inseguì la principessa per tutto il regno senza riuscire a impedirle di consegnare i messaggi che i rivoluzionari si scambiavano. L’unica cosa che gli austriaci fecero per fermarla fu quella di sequestrarle tutti i beni. Ma Cristina non se la prese più di tanto, si mise a girare l’Europa raccogliendo fondi per la rivoluzione. Solo nel 1840 riuscì a rientrare in possesso di tutti i sui beni, giusto in tempo per conoscere quello che sarebbe diventato il grande amore della sua vita Gaetano Stelzi, il suo fedele segretario, bello colto e malaticcio, molto più giovane di lei. Mentre Cristina si trovava a Napoli per reclutare volontari, a Milano con le Cinque giornate, iniziava l’insurrezione armata contro il dominio austriaco. Cristina partì subito da Napoli portandosi dietro la “divisione Belgioioso”, un gruppo di volontari pronti a combattere. Il 15 giugno in una Milano libera dagli austriaci e sotto il Governo Provvisorio, Gaetano moriva di tubercolosi. Cristina non si volle rassegnare a quella perdita, sul suo conto correvano strane voci, si diceva che il corpo di Gaetano era stato imbalsamato e messo in una stanza attigua alla camera da letto di Cristina nel castello di famiglia a Locate. Le vicende del cadavere “imbalsamato” di Gaetano Stelzi, alimenteranno la leggenda sulla sua necrofilia. Si sparsero presto voci di pratiche occulte, (forse nate dalla passione di Cristina per l’esoterismo e per le sedute spiritiche), nelle mura del castello e di presunte apparizioni del fantasma di Gaetano (1). Durante l’assenza della nobildonna, rifugiata in terra lontana in seguito al fallimento dei moti insurrezionali contro il dominio austriaco, il maniero venne perquisito e, una volta scoperto, il cadavere di Gaetano sepolto nel cimitero locale. Nel mentre Cristina attraversando mezza Europa arrivava in Cappadocia dove acquistava una piccola valle per fondare una colonia agricola aperta ai profughi italiani. Il progetto fallì perché il nuovo segretario si innamorò di lei e durante una lite sentendosi rifiutato la colpì con cinque coltellate, la principessa si salvò ma rimase con un difetto di postura. Amareggiata ma non vinta dopo la brutta esperienza riprese a viaggiare per quasi tutto il Medio Oriente, scrivendo articoli interessanti dove venivano svelate senza riguardi con un motivo di repulsione le miserie di una società senza affetti famigliari, dove la sporcizia regnava ovunque e le donne abbandonate alla ottusità e all’ignoranza. Ritornata in Italia visse i suoi ultimi anni nel castello di Triulzio, partì per il suo ultimo viaggio verso una destinazione sconosciuta la sera del 5 luglio 1871, sicura che l’Italia era finalmente libera. La principessa venne sepolta nel monumentale sarcofago tuttora presente nel cimitero di Locate. Le storie della presenza di spettri in paese ripresero comunque con insistenza. Mezzo secolo dopo la morte di Cristina la tomba venne aperta e trovata vuota! In base alle indicazioni del guardiano del cimitero, il corpo della donna fu poi ritrovato in un’anonima tomba vicino a quella dell’amatissimo Gaetano. Secondo la leggenda una volta aperta la bara, il cadavere di Cristina, ancora incredibilmente intatto, si polverizzò letteralmente alla luce del giorno. Per quella che si potrebbe definire come una forma di giustizia, a Milano è stata eretta la prima statua dedicata a una donna, una scultura in bronzo posta in piazza Belgioioso a memoria della famosa patriota Cristina Trivulzio di Belgioioso. Qualsiasi evento ammantato di leggenda si lascia dietro una scia che tramanda la memoria dei fatti in buona parte di orgine alquanto dubbie, come spesso accade le leggende prendono vita da un piccolo frammento di verità, per poi crescere formando una catena di distorsioni di notevole inventiva.

PIAZZA EUROPA

di Alessandro Bocci
Grazie ad una mobilitazione lanciata alla fine di febbraio, il 15 marzo la romana Piazza del Popolo si è colorata con le bandiere blu stellate dell’Europa. Oltre cinquantamila persone hanno ascoltato l’Inno alla gioia di Beethoven, la sigla di apertura. Cittadini che chiedono all’Europa di dimostrare di esistere e di difendere i valori che da secoli caratterizzano la nostra civiltà. Con loro, uomini politici, amministratori, intellettuali, scrittori, giornalisti. Una piazza inclusiva, che si è mobilitata per qualcosa e non contro qualcuno.
Una lunga storia, quella dell’Unione. Nata con il Trattato di Roma del 57, sei i paesi aderenti, si è progressivamente allargata prima ai paesi dell’Europa occidentale e poi a quelli orientali, finalmente ritornati alla democrazia grazie al superamento degli accordi e soprattutto dello spirito di Yalta. Altri importanti trattati furono quelli di Schengen, di Maastricht e di Lisbona. Da un’alleanza di natura prevalentemente economica si è arrivati, pur con evidenti limiti, ad un’Unione di carattere politico.
E tuttavia, si ha l’impressione che all’Europa manchi qualcosa. Le competenze del parlamento europeo rimangono limitate e i poteri degli esecutivi dei singoli Stati sono troppo spesso vincolanti e decisivi.
L’eurodeputato ed intellettuale francese Glucksmann ha notato che difendere ciò che è stato costruito negli ultimi settant’anni non è più sufficiente e che occorre ridare un nuovo slancio ai nostri ideali fondati sulla libertà e sulla solidarietà. Tutto ciò passa anche attraverso la difesa dell’Ucraina dall’invasione russa e dal contrasto alle reti di propaganda putiniana, particolarmente attive in Italia.
In epoca trumpiana, l’adesione alla Nato rischia di essere poco significativa se non è accompagnata dalla creazione di una difesa comune europea, che garantisca sicurezza, e per la quale si era già speso Alcide De Gasperi.
Nel 1923, già allora, Giacomo Matteotti scriveva che si doveva favorire la formazione “degli Stati Uniti d’Europa che si sostituiscano alla frammentazione nazionalista in infiniti piccoli Stati turbolenti e rivali”.
Serve dunque un’Europa autenticamente federale in un’ottica di democrazia sovranazionale.

di Alessandro Bocci
Grazie ad una mobilitazione lanciata alla fine di febbraio, il 15 marzo la romana Piazza del Popolo si è colorata con le bandiere blu stellate dell’Europa. Oltre cinquantamila persone hanno ascoltato l’Inno alla gioia di Beethoven, la sigla di apertura. Cittadini che chiedono all’Europa di dimostrare di esistere e di difendere i valori che da secoli caratterizzano la nostra civiltà. Con loro, uomini politici, amministratori, intellettuali, scrittori, giornalisti. Una piazza inclusiva, che si è mobilitata per qualcosa e non contro qualcuno.
Una lunga storia, quella dell’Unione. Nata con il Trattato di Roma del 57, sei i paesi aderenti, si è progressivamente allargata prima ai paesi dell’Europa occidentale e poi a quelli orientali, finalmente ritornati alla democrazia grazie al superamento degli accordi e soprattutto dello spirito di Yalta. Altri importanti trattati furono quelli di Schengen, di Maastricht e di Lisbona. Da un’alleanza di natura prevalentemente economica si è arrivati, pur con evidenti limiti, ad un’Unione di carattere politico.
E tuttavia, si ha l’impressione che all’Europa manchi qualcosa. Le competenze del parlamento europeo rimangono limitate e i poteri degli esecutivi dei singoli Stati sono troppo spesso vincolanti e decisivi.
L’eurodeputato ed intellettuale francese Glucksmann ha notato che difendere ciò che è stato costruito negli ultimi settant’anni non è più sufficiente e che occorre ridare un nuovo slancio ai nostri ideali fondati sulla libertà e sulla solidarietà. Tutto ciò passa anche attraverso la difesa dell’Ucraina dall’invasione russa e dal contrasto alle reti di propaganda putiniana, particolarmente attive in Italia.
In epoca trumpiana, l’adesione alla Nato rischia di essere poco significativa se non è accompagnata dalla creazione di una difesa comune europea, che garantisca sicurezza, e per la quale si era già speso Alcide De Gasperi.
Nel 1923, già allora, Giacomo Matteotti scriveva che si doveva favorire la formazione “degli Stati Uniti d’Europa che si sostituiscano alla frammentazione nazionalista in infiniti piccoli Stati turbolenti e rivali”.
Serve dunque un’Europa autenticamente federale in un’ottica di democrazia sovranazionale.
In questo senso, l’ampio consenso riscosso dalla manifestazione di Piazza del Popolo lascia ben sperare.

LE RELAZIONI OGGI: UN PROGETTO, NON UN VINCOLO ETERNO

di Nurgul Cokgezici
Viviamo in un’epoca in cui le relazioni non sono più eterne, e questa è una realtà con cui dobbiamo imparare a convivere. Eppure, molte persone si chiedono: Come dobbiamo fare? La verità è che dovremmo smettere di temere la fine di una relazione e accettare che, così come nasce, può anche concludersi. Non significa che dobbiamo disperarci o sentirci falliti, ma piuttosto riconoscere che ogni relazione è un progetto, con una durata incerta: può durare pochi mesi, anni, o anche tutta la vita, ma nulla è garantito.
La Ricerca di Affetto e Conferme: Cosa Dobbiamo Imparare?
Nella nostra società, siamo costantemente alla ricerca di affetto e conferme dall’altro, come se senza un partner non potessimo sentirci completi. Ma in questa continua ricerca, ci siamo mai chiesti cosa dobbiamo davvero imparare?
Un aspetto interessante emerge osservando le ragazze di seconda generazione, cresciute tra due culture. Per molte di loro, il matrimonio rappresenta ancora un obiettivo fondamentale, quasi un traguardo da raggiungere per sentirsi realizzate. Questo perché l’idea dell’unione stabile e duratura è profondamente radicata nell’inconscio collettivo della loro comunità di origine. Tuttavia, i ragazzi della stessa generazione spesso vedono il matrimonio con paura e diffidenza, come se fosse un vincolo insopportabile. Questa differenza di visione crea un forte squilibrio, che porta inevitabilmente a incomprensioni, frustrazione e, in molti casi, rotture.
L’Equilibrio nelle Relazioni: Un Nuovo Modo di Viverle
Forse il vero equilibrio sta nel comprendere che le relazioni possono finire senza che questo debba essere visto come un fallimento. Invece di entrare in un rapporto con la pretesa di un “per sempre” garantito, dovremmo viverlo con consapevolezza, rispetto e maturità.
Uno dei problemi principali nelle relazioni moderne nasce quando si entra in un rapporto con l’idea di approfittarsi dell’altro: spesso gli uomini cercano un vantaggio sessuale, mentre alcune donne vedono nella relazione una forma di stabilità economica. Questo tipo di dinamica crea inevitabilmente squilibri e tensioni, rendendo la relazione insostenibile nel lungo periodo.
Il Cambiamento dei Ruoli e le Nuove Difficoltà
Un tempo, molte donne riuscivano a conciliare famiglia e lavoro grazie a un impiego part-time. Oggi, però, questa non è più una soluzione praticabile: il costo della vita impone che entrambi i partner lavorino a tempo pieno. Tuttavia, la gestione della casa e della famiglia ricade ancora prevalentemente sulle donne, creando una situazione di sovraccarico che spesso porta a una sensazione di soffocamento all’interno del matrimonio. Così, molte donne si trovano a vivere una realtà molto diversa da quella che avevano sognato: un’unione che sembrava una promessa di felicità si trasforma in una gabbia. Ed è a quel punto che si chiedono: Perché restare?
Verso Relazioni Più Equilibrate e Consapevoli
Se vogliamo costruire relazioni più sane, dobbiamo liberarci dall’idea che il partner esista per soddisfare i nostri bisogni – che siano economici, emotivi o sessuali. Il vero obiettivo dovrebbe essere creare un rapporto basato sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza che nulla è immutabile.
Le relazioni non devono essere un vincolo imposto dalla società o dalla cultura, ma un progetto condiviso, in cui entrambi i partner si sentano liberi e rispettati. Forse, se riuscissimo ad accettare questa nuova prospettiva, potremmo vivere le relazioni in modo più sereno e autentico. Anche se non saranno eterne, potranno comunque essere vere.

IN GIRO PER LA VECCHIA AFFORI

di Giorgio Righetti
Camminare per il quartiere di Affori accompagnati dalla voce della memoria si può percepire ancora l’atmosfera bella di paese, eppure le linee secolari della sua struttura sono state smantellate dall’espandersi della nuova Affori che insofferente dei limiti tradizionali propaga il fervore del suo benessere e così si diffonde la deprecata mania del mastodontico e si vede inesorabilmente il bello trasformarsi in brutto e il brutto resistere e moltiplicarsi. La dove solo qualche anno fa si poteva vedere abbondanza di vegetazione si stanno costruendo alti palazzi di grigio squallore, blocchi di cemento e di cristallo, allineati senza intermezzi di sosta. Oggi che non si conoscono nemmeno i vicini di casa, sembra passata da secoli la Affori delle cooperative, delle lunghe ringhiere, dei grandi cortili rallegrati dalle grida e dai giochi dei bambini, dove si viveva in comune e il cortile era un ritrovo per tutti, dove la solidarietà correva di casa in casa di piano in piano favorita dalle strutture urbane e dalle care e pittoresche tradizioni chiesastiche. Ma torniamo adesso col pensiero anche in quei vecchi negozi afforesi per ritrovarvi un’atmosfera di reciproca cordialità quasi un clima di affetto. Con gli esercenti si aveva la massima confidenza, non si diceva ai figli vai dal prestinaio “bensì va dal sciur Giuvann”. Affori vanterebbe anche il primo negoziante di trippa che era solito prendere le parti meno nobili dell’animale, le frattaglie, per poi trasformarle in piatti ricercati. Oltre che per “la banda dei 550 pifferi” Affori era famosa per i dolcissimi asparagi incredibilmente buoni, grazie al terreno ghiaioso, sabbioso e ben drenato. Ma continuiamo il nostro itinerario: L’Annunciazione in via Vittorio Scialoia è la prima Chiesa in Italia che ospita un’opera di arte naïf, la gigantesca pala dell’Annunciazione di metri 5,70 x 3,40, concepita in un paesaggio contemporaneo (1980), è il risultato di un anno di lavoro del parrocchiano Giovanni Galli. Molto bella la chiesa arricchita anche dalla presenza del parroco don Tommaso, prima della Santa Messa, accoglie con amicizia i presenti sul sagrato e questo non è poco, “parrocchia” significa letteralmente “vicino a casa, casa tra le case”, ciò che rende bello abitare in una casa è proprio la “capacità reciproca di accogliere”. Il quartiere conserva tuttora l’aspetto di un paese con strade strette di origine campestre, il tratto dell’antica strada Comasina che attraversava il Comune è stata dedicata al sacerdote Alessandro Astesani archeologo e parroco di Affori che si prodigò in opere di carità per i compaesani poveri. Poco oltre la località “la Pianta”, (un platano enorme di quasi 300 anni, probabilmente l’albero più vecchio di Milano), ecco la bella chiesa di Santa Giustina, e qui siamo di fronte al tesoro di Affori, una piccola elaboratissima misteriosa “Vergine delle rocce”, attribuita a Bernardino Luini, una bellissima opera d’arte ancor poco conosciuta al di fuori dal quartiere. Proseguendo il nostro itinerario la stupenda Villa Litta Modignani, una curiosità il suo parco era chiamato dagli afforesi: “El giardin dei matt”, infatti dal 1905 quando la storica dimora fu donata alla Provincia di Milano, poco dopo la scomparsa del conte Litta Modignani Sindaco di Affori, era usanza affidare la manutenzione del parco a dei ricoverati del Paolo Pini. Molti nonni ricorderanno quei pomeriggi lontani d’estate il triciclo del gelato dello zio Arturo davanti ai cancelli di Villa Litta circondato dai bambini festanti in attesa del loro gelato. Quasi sempre lo zio Arturo lo si incontrava anche nei mesi invernali all’uscita delle scuole a vendere le castagne o la “gnaccia”, i ragazzi gli si affollavano intorno, i più fortunati quelli che potevano disporre di qualche soldino si facevano avanti e acquistavano una bella fetta di quel dolce saporito. Anche lo zio Arturo è scomparso con i suoi gelati e la sua “gnaccia”. Poco più in la, il parco dell’ex ospedale Paolo Pini dove animali selvatici e uccelli di passo, hanno trovato un rifugio sicuro. Il parco è molto grande una volta ospitava un manicomio. Oggi in alcune palazzine ci sono ancora ambulatori pubblici, mentre in altre sono ospitati un museo e diverse associazioni. Il parco è ottimo per correre o passeggiare e godere del fresco offerto dai numerosi tigli. Siamo nell’epoca in cui “el Milanin” ormai è diventato “el Milanon”, come cambia tutto senza che ce ne accorgiamo, improvvisamente ci troviamo in un’altra città tra altra gente, purtroppo non si fa più esperienza dei luoghi, non si fa più esperienza degli altri. L’assurdo è che l’uomo non è mai stato così solo come nell’affollamento urbano di oggi. Vita beata di quel piccolo mondo che niente possedeva e niente chiedeva. E tuttavia ha una sua suggestione rivisitare i luoghi, rimane sempre nel nostro cuore un angolo immutabile nel tempo dove a volte amiamo rifugiarci forse per ritrovare noi stessi. Si chiama nostalgia.
Sotto via Zanoli in una vecchia foto. Affori conserva tuttora l’aspetto di un paese e, nella sua memoria storica gli aspetti inediti e poco conosciuti del tempo che fu.

O MIA BELA MADUNINA
… E LA VECCHIA MILANO SE NE VA

a cura di Luigi Filipetto
Dicono le statistiche che negli ultimi cinque anni hanno chiuso a Milano circa 1300 negozi. Si chiude e si apre. Una girandola, una giostra. Spesso è solo un giro di soldi. Cominciano a girare notizie di finti negozi che chiudono.
Ma in questi giorni sulla porta del negozio di gioielleria Labadini, in Corso XXII Marzo, è affissa la scritta “1909 CHIUSO 2024”. Chiuso per sempre. Questa è un’altra storia, una storia vera. Si tratta di un negozio nato nel 1909, quindi centoquindici anni di vita. In questi ultimi anni ha ricevuto importanti riconoscimenti come “Negozio storico”, per ultimo un riconoscimento dal Comune di Milano nel febbraio 2024. Il palazzo in cui ha operato in tutti questi anni il negozio fu costruito agli inizi del 1900. Fu bombardato nel corso della seconda guerra mondiale e fu ristrutturato, rispettando la sua struttura originale. Oggi si preferisce abbattere e costruire ex novo, ma anche questo è un segno dei tempi.
Abbiamo incontrato la signora Laura, ultima discendente di una famiglia di orafi, che continua a essere presente nel suo negozio. Si potrebbe leggere come un rimpianto per questo abbandono. Ha accettato volentieri di ripercorre la storia non solo di questi anni ma anche quella dei suoi nonni e della sua famiglia.
Quanti ricordi signora Laura?
Io sono qui da quarantacinque anni. Avevo otto anni quando ho iniziato a mettere in ordine le varie cose e a pulire le argenterie. Ho ereditato il negozio dopo la morte di mia mamma. Sono l’ultima della discendenza e purtroppo ora mi sono decisa a chiudere. Mio nonno, nato a Piacenza nel 1886, dopo aver preso il diploma di orafo, si era trasferito a Milano, dove aveva perfezionato la sua arte di orafo presso la famosa Gioielleria Cusi. Aveva iniziato la sua attività di orafo in via Torino e nel 1923 aveva aperto il suo negozio proprio qui in corso XXII Marzo. Aveva preso dimora insieme a sua moglie sopra il negozio. Così in questo negozio il nonno Giuseppe, coadiuvato da sua moglie, produce, vende e ripara gioielli e orologi. Purtroppo, a causa del bombardamento del ʼ43, si era sviluppato allora anche un incendio che aveva danneggiato i solai in cui erano custoditi i disegni di gioielli da lui progettati e anche tutta una serie di documenti dell’epoca. La nostra attività è andata sempre bene e anche la clientela non è mai mancata.
In occasione del riconoscimento come negozio storico da parte del Comune di Milano
dell’anno scorso eravamo oltre cento esercizi commerciali, ma io rappresentavo la gioielleria più
antica.
Ora mi vedo costretta a chiudere, un po’ per la mia età, un po’ anche perché l’attività non è
così fiorente come negli anni precedenti. Ora purtroppo ci sono tante possibilità nuove di acquisti
che non aiutano i piccoli commercianti. Centri commerciali, organizzazioni nuove che forniscono di tutto, gioiellerie che si spacciano come tali, che spacciano gioielli color oro, ma solo color oro. Mio nonno di certo questi non li avrebbe chiamati gioielli. Io posseggo ancora qualche gioiello fatto da mio nonno. Uno di questi molto bello, tanto che andrò alla gioielleria Cusi per farlo vedere, perché so che cerca reperti originali di un certo valore.
Cosa prova ora che si vede costretta a chiudere la sua attività?
Tutto quello che di peggio si può immaginare. Sono nata qua. Ho iniziato a lavorare qua all’età di
otto anni. Andavo a scuola all’istituto Maria Ausiliatrice, uscivo da scuola e venivo qua dove mi
facevano fare tutti i lavoretti che potevo fare a quell’età. Adesso che devo chiudere mi vengono tutti i ricordi e sono tanti. Purtroppo non c’è nessuno dopo di me che possa continuare l’attività.

LA FORZA DELL’OTTIMISMO

di Teresa Tardia
L’ottimismo è un valore molto forte che influenza la nostra vita e ha un impatto sul modo in cui vediamo le cose. Va esercitato e coltivato giorno dopo giorno con costanza ed energia: ci permette di vivere con maggiore serenità e ci dà maggiori prospettive.
Chi è l’ottimista? È una persona dotata di varie caratteristica forti e trascinanti verso mete e obiettivi che sembrano impossibili da raggiungere a molte persone, ma chi ha la ha persegue obiettivi innovativi e rivoluzionari; tutti i grandi scienziati e innovatori sono stati dei grandi ottimisti che hanno affiancato a tale dote anche la resilienza per superare gli ostacoli e indirizzarsi verso le soluzioni ricercate.
L’ottimista non è un buonista, è una persona che di fronte alle difficoltà trova il modo per superarle in modo costruttivo.
Il padre delle teorie sull’ottimismo è stato Martin E.P. Seligman e una delle sue citazioni più famose è la seguente: “Gli ottimisti tendono a interpretare i propri problemi come transitori, controllabili e circoscritti a un’unica situazione. I pessimisti, invece, ritengono che i loro problemi siano permanenti, incontrollabili e inficino tutta la loro vita.” Da questa citazione comprendiamo l’impatto dell’ottimismo sulla nostra vita, ogni ostacolo va visto come una opportunità di apprendimento e di crescita, una opportunità trasformativa.
L’ottimismo attiva cariche di buon umore e di sorriso che fanno bene in famiglia, ma anche negli ambienti di lavoro dove le competitività fra le aziende è sempre più intensa.
L’entusiasmo verso cose nuove e diverse sono due elementi importanti che alimentano l’ottimismo, infatti, il cambiamento viene affrontato con maggiore facilità se si è ottimismi o con una visione più costruttiva.
L’ottimista propone e di fonte alle difficoltà ricerca nuove soluzioni e nuovi approcci, esclude tutto quello che non funziona. Il pessimista in queste circostanze è un demolitore, una persona che non trova soluzioni tanto qualsiasi miglioramento sarebbe vano e produrrebbe solo energie spese male. Il pessimista si ritira e l’ottimista si lancia verso nuove sfide e traguardi. Come dire il pessimista batte in ritirata dove l’ottimista si lancia verso il cambiamento.
Bisogna prestare attenzione alle dinamiche di gruppo dove sono presenti i pessimisti. Un pessimista può essere supportato a ridurre questa manifestazione e indole. Infatti, in un cesto di mele se una mela si ammacca e diventa marcia, bisogna intervenire perché il contagio potrebbe propagarsi e generare dinamiche controproducenti.
L’ottimista in genere ha un buon umore ed è solare, curioso e creativo nelle sue manifestazioni. Per un ottimista “esiste un’isola di opportunità all’interno di ogni difficoltà” (cit. Anonimo), sono proprio le opportunità che si generano che fanno la differenza per poter creare e cambiare. Gli ottimisti sono volti al cambiamento, sono flessibili, ma non si piegano difronte alle difficoltà. In genere anche gli ottimisti dicono no quando vedono nelle proposte dei limiti, ma operano per ricercare soluzioni alternative.
Infine, come hanno dimostrato le ricerche e gli studi di Martin E.P. Seligman “Gli ottimisti vivono più a lungo e realizzano più cose.” Infatti, non si tirano indietro, ma ricercano sempre strade percorribili o alternative per raggiungere gli obiettivi; questa condizione permette di avere una vita più proficua, con interessi multipli e ricca nelle differenti forme.
L’ottimista è colui che nella parola “impossible” legge esattamente l’opposto “I’m possible”, infatti darsi delle possibilità dipende da ognuno di noi, così come ricercarle. Rendere le cose possibile e realizzabili è un esercizio di forza e pazienza, ma anche si perseveranza e di resilienza che deve manifestarsi con flessibilità ed elasticità.
L’ottimista è colui che vede il bicchiere mezzo pieno dove altri possono vederlo mezzo vuoto. E’ un problema di prospettiva, l’ottimista capisce come colmare le mancanze, il pessimista vede solo questo. Come possiamo migliorare? Con un esercizio semplice, allenarci a vedere come colmare i divari e a non essere catastrofici anche d fronte alle piccole cose, Possiamo iniziare a gestire le nostre azioni e reazioni in modo costruttivo con piccoli cambiamenti che sono dei passi importanti per invertire o perlomeno cambiare prospettiva chiedendoci “con quali lenti vogliamo vedere la situazione? Duqnue alleniamoci per raggiungere i nostri obiettivi in modo possibile e con ottimismo e dare fiducia a noi stessi e agli altri.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 9

S’ciao bèlla gent. Nel mes de april contenti tuccquèi che m’hann domandaa i mè vignètt. E allora ve pubblichi i ultim dò che hoo faa.

Notizzi dal mond:

In d’on negòzzi pien de client, ona sciora la ghe dis al titolar: “M’hann dii che sii adree ad assumm di commèss…”.
Ma nanca per sògn! – el ghe rispond l’òmm – Gh’hoo pussee commess de quèi che me servissen”.
“E allora – la conclud la sciora – che ‘l ved de mandamen subit voeuna: l’è pussee de on quart d’ora che spètti!”.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese

UNIONE EUROPEA: L’INCOMPIUTA DA COMPIERE
di Giovanni Polliani
Parlare di Europa in un momento così difficile è una bella impresa. Ma dobbiamo parlarne per ricordarci da dove veniamo per sapere dove vogliamo andare. In questo periodo siamo di fronte alla peggiore crisi dell’Unione Europea, indotta dal pesante tentativo delle “super potenze” mondiali di sconvolgere gli assetti tracciati con grande fatica nella conferenza di JALTA. Le quattro potenze implicate nella seconda guerra mondiale, Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra e Francia in aggiunta, uscite vincitrici della seconda guerra mondiale definirono in quella sede, i nuovi confini dell’Europa e stabilirono le sfere di influenza politica di occupazione. Oggi, dopo 80 anni da quegli avvenimenti, siamo di fronte ad un pericoloso tentativo di modificare con la forza i confini di parecchi stati, provocando confusione, paura e smarrimento tra la gente .
Parlo delle guerre in atto e dei proclami di acquisizione di terre altrui, risonanti spesso in questi ultimi tempi, mentre l’Europa si trova coinvolta con la guerra in Ucraina, dopo 80 anni di pace.
Mi sembra doveroso allora ricordare qui perché fu dato vita all’Europa e quale importante eredità abbiamo ricevuto. NON E’ VERO CHE L’EUROPA NON HA FATTO NULLA. Per questo occorre riandare ai momenti importanti segnati dalla crescita dell’Unione dopo i patti di Roma del marzo 1957, stipulati alla luce del Manifesto di Ventotene “PER UNA EUROPA LIBERA E UNITA” .
Lo farò ripercorrendo la mia lunga e vissuta esperienza, riportando qui fatti e non giudizi perché vorrei solo parlare di storia, lasciando al lettore i personali giudizi. Dobbiamo tutti essere coscienti che, se non teniamo conto delle radici da cui veniamo, risulta difficile delineare conseguenti prospettive su dove dobbiamo andare. Si rischia di uscire male dalla grande confusione che sta sconvolgendo oggi gli europei e gli stati membri dell’Unione.
Ricordo allora qui alcuni avvenimenti significativi che smentiscono le molteplici negazioni della inutilità della Unione Europea.
I principi forti, messi quali pietre angolari della costruzione dell’Europa da parte dei 6 Stati Fondatori sono stati: No alla guerra. SI’ alla pace, alla democrazia alla Cooperazione. Per attuare questi principi, i padri fondatori decisero la messa in comune delle risorse per ricostruire il vecchio continente totalmente distrutto dalla seconda guerra mondiale. Chi va a vedere le immagini dell’Europa uscita dalla guerra resta sconvolto. La nuova Istituzione nasce sotto l’ombrello degli USA, secondo la spartizione delle influenze politiche concordate a JALTA. Prendo vita così la CECA, la CEE e l’EURATOM, strumenti della rinascita, della cooperazione e della pace tra le nazioni europee. Si parlò anche di difesa, ma questo progetto non fu mai affrontato direttamente perché molti paesi europei facevano già parte della NATO, costituita ufficialmente il 4 aprile 1949, ancor prima che nascesse la CEE.
Sulla base del tacito silenzio della CEE sui problemi della difesa, a causa della Nato e dei contrasti interni posti in ordine alla supremazia per la gestione della difesa, la CEE, diventata poi Unione Europea, ha messo in atto i propri sforzi nella costruzione dell’Europa dei cittadini: ha sviluppato il mercato comune, ed ha operato per mettere assieme gli Europei sulla base del principio che le diversità sono ricchezza per la democrazia. Anche per l’Unione è valsa l’affermazione di Massimo d’Azeglio in versione europea: L’Europa è “fatta”, ora bisogna fare gli europei.
Dalla costituzione del Consiglio e della Commissione Europea (anno 1965) si sono succeduti avvenimenti che hanno veramente entusiasmato me e la stragrande maggioranza degli europei.
Bruxelles e Strasburgo erano diventati i luoghi privilegiati per incontrare le strutture Europee ed anche io ho iniziato a viaggiare verso Strasburgo per i contatti con il Parlamento europeo e verso Bruxelles, città simbolo di democrazia e pila della sviluppo europeo, per i contatti con gli uffici della Commissione, con particolare riferimento alla DG Educazione e Cultura. Tale Direzione lanciava e gestiva progetti riguardanti l’Educazione e la Scuola di cui ero dirigente scolastico .
Il viaggio in automobile o in aereo richiedeva il passaggio delle frontiere, con file di attesa alle barriere per il controllo dei passaporti. Se eri in macchina dovevi passare parecchi paesi tutti con le dogane e posti di polizia che facevano controlli lunghi e quasi sempre accurati .
Ma con un grande impegno, la Cee arrivò a liberalizzare il movimento delle merci e quello ancora più importante delle persone. In quei momenti vissi una grande gioia allorchè, andando in macchina dall’ Italia a Bruxelles, passai senza fermarmi i caselli vuoti delle frontiere Francesi, Lussemburghesi e Belghe. Per la prima volta mi sentivo cittadino d’Europa. Oggi chi passa tranquillamente le ex frontiere, non può vivere i sentimenti che ci hanno animato in quei momenti di acquisizione di importanti nuovi diritti: si dà per scontato che le cose debbano essere così.
E quando sono andato a Bruxelles in aereo, mi fu chiesta la carta di identità in Italia. Sbarcato a Bruxelles, ho percorso tutto l’aeroporto fino al treno per la città, senza che un poliziotto mi facesse controlli. Sorpresa e gioia mi hanno fatto capire che un altro grande passo verso l’Europa dei cittadini era stato fatto.
Intanto la Commissione Europea varava, tramite la DG Education end Culture i progetti per le scuole europee. Una delle competenze che gli stai membri non hanno mai voluto delegare all’Unione è stata l’Istruzione. L’Europa promosse allora la possibilità di confronto sulla didattica, sui contenuti di studio, e sulle metodologie. Lanciò gli SCAMBI TRA DIRIGENTI SCOLASTICI E TRA DOCENTI, fino ad arrivare allo scambio tra studenti con il grande progetto ERASMUS che ha fatto e fa incontrare miglia di studenti per discutere di scienza e cultura, conoscersi e comprendersi nelle diversità. Potente progetto che ha promosso la CITTADINANZA EUROPEA facendo conoscere ai giovani un continente senza confini. Ne sa qualcosa chi l’ha praticato con convinzione.
E che dire della CADUTA DEL MURO DI BERLINO (correva l’anno 1989) e DELLA UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA? L’Unione Europea in tripudio festeggiava la LIBERTA’, abbattendo un innaturale muro che costò la vita a migliaia di persone. Ancora una volta l’Unione Europea riaffermava il diritto dei popoli all’Autodeterminazione e alla Libertà.
Dieci anni dopo, l’Unione Europea celebrò un altro grandioso avvenimento: l’EURO, MONETA UFFICIALE DI 11 stati membri. In quella occasione mi affrettai ad eliminare due portafogli che fino ad allora avevo usato per i trasferimenti in altri paesi: eliminai il portafoglio dei franchi e monete francesi e quello dei franchi e monete belghe. Potevo viaggiare senza correre alle banche per scambiare i soldi, almeno nei paesi più frequentati da me, con la conseguenza di sentire rafforzata la mia appartenenza e la mia cittadinanza europea.
Mentre si compivano tutti questi significativi avvenimenti, l’Unione Europea passava da 6 a 28 stati, e dava il suffragio universale a tutti i cittadini europei per l’elezione del PARLAMENTO EUROPEO, facendo godere 80 ANNI DI PACE AL VECCHIO CONTINENTE.
Riflettiamo bene sul fatto di aver avuto LA PACE per tanto tempo, pace che ha garantito a ben quattro generazioni di crescere senza l’esperienza terrificante della guerra e della dittatura, come io l’ho vissuta da bambino. E’ un privilegio che non tutti i giovani del mondo hanno potuto godere, come ben sappiamo.
Il periodo della ricostruzione e della pace ha dato tuttavia segnali di incrinamento quando il vento del Nazionalismo ha imposto all’Inghilterra l’uscita dalla Unione Europea. Da lì il moltiplicarsi e crescere dei nazionalismi in altri paesi membri dell’Unione. Il fenomeno politico del Nazionalismo propugna di fatto il superamento della democrazia perché troppo lenta nelle decisioni e complicata nella gestione e propugna il principio del governo autocratico o oligarchico al comando dello stato. Il secondo principio letale per la vita democratica è che il governo autocratico o oligarchico eletto dal popolo propugna il predominio del governo su ogni altro potere dello stato e dell’informazione e stampa, in virtù del voto ricevuto. In questa concezione autocratica e nazionalista c’è pure la difesa dei confini, la priorità degli interessi nazionali in contrasto con i principi fondanti di democrazia e cooperazione che reggono l’Unione.
Recentemente il fenomeno Nazionalistico, strumentalmente motivato anche dalle migrazioni mondiali in atto, è esploso significativamente fino a conquistare il potere in uno stato di grande storia democratica, faro di Libertà per il mondo intero: gli USA. Si è composto così un quadro mondiale in cui emerge sempre più chiara la spinta a far saltare gli equilibri mondiali, i confini esistenti e le Istituzioni Internazionali per creare un nuovo assetto di cui non si intravvede un disegno perché ogni autocrate ha in mente il suo da imporre agli altri. In più oggi assistiamo al fatto ancora più grave del consociativismo dei governi autocratici con personaggi del mondo della finanza che dà la possibilità a grandi finanzieri privati di diventare principali attori e beneficiari, in prima persona, della politica e degli strumenti e strutture della “cosa pubblica”.
Anche la PACE diventa un fatto economico che richiede in cambio il pagamento di terre rare a popoli stremati dalla guerra, togliendo loro risorse utili per la ricostruzione del proprio paese.
In questo quadro, l’Unione Europea, incompiuta sul versante anche della difesa, si trova senza l’ombrello degli USA nella NATO e si trova a dover provvedere improvvisamente da sola alla guerra in Ucraina e alla difesa della pace.
Oggi più che mai, l’Unione Europea si trova faccia a faccia con Putin che in qualsiasi momento potrebbe compiere gesti insani anche contro paesi dell’Unione come ha fatto con l’Ucraina.
Ma l’obiettivo della DIFESA non può essere realizzato solo con la spesa di miliardi, ma deve avere a fondamento un progetto credibile, una struttura chiara ed organica che ne garantisca una gestione democratica condivisa tra gli stati membri. Deve essere chiaro a tutti che non andiamo verso il RI-ARMO, ma verso la creazione della nostra DIFESA.
Per questo, a mio modesto avviso, va recuperata la bussola della DEMOCRAZIA E PACE, cosi come è stato indicato dal manifesto di Ventotene: cogliere l’occasione per costruire l’EUROPA FEDERALE nella quale la difesa sia uno strumento per PRESERVARE LA PACE. Senza un nuovo fondamento strutturale e democratico, l’Unione si va a complicare la sopravvivenza.
Occorrerebbe dire chiaramente che vogliamo cambiare il vecchio principio “Si vis pacem para bellum“ perché la guerra non si fa più con la spada, corpo a corpo. LA GUERRA OGGI COLPISCE I POPOLi, I BAMBINI, LE DONNE, I VECCHI, I PIU’ DEBOLI. Guerra significa distruzione totale di intere regioni, migrazioni di massa, morte di migliaia e migliaia di civili. Se poi a qualche insano di mente venisse l’idea di usare il potenziale atomico nascosto negli arsenali, sarebbe la distruzione del mondo.
Ecco perché occorre cambiare il principio vecchio in uno nuovo: “SI VIS PACEM PARA PACEM”.
L’Europa INCOMPIUTA non può costruire il proprio futuro dimenticando i fondamenti per cui è stata creata: PACE E DEMOCRAZIA. Sono valori che gli Autocrati cercano di cancellare per far valere la loro prepotenza. E l’Europa tuttora è l’ostacolo principale al raggiungimento dei loro obiettivi. Se vuole salvarsi, a mio modesto avviso, deve rafforzare la democrazia puntando alla Federazione degli stati, con chi ci sta, deve consolidare la democrazia con meno burocrazia (che ha preso il posto della politica) e più diplomazia: non esiste un politica estera europea, né uno strumento efficace per farla. Occorre un commissario ad hoc.
E’ ORA CHE L’ EUROPA LANCI IL DISARMO MONDIALE CONTROLLATO PERCHE’ LA SPINTA AGLI ARMAMENTI PORTA SEMPRE PIU’ GLI STATI SULL’ ORLO DELLA GUERRA.
Invece di ricorrere SOLO alla DIFESA CON LE ARMI, occorre difendersi oggi rafforzando i canali che promuovano la PACE, cosa dimentica in questi ultimi tre anni. L’EUROPA DEVE RESTARE IL CONTINENTE DELLA PACE E DEI VALORI UMANI E CIVILI, SE VUOLE RICONOSCERE LE PROPRIE RADICI E AVERE UN RUOLO NEL MONDO .
La piazza del Popolo a Roma, il 15 marzo scorso, ha dimostrato che i cittadini, in tantissimi, credono nell’EUROPA, QUELLA DI SPINELLI E DEI TRATTATI DI ROMA. Ora tocca all’Europa credere nei cittadini facendo ogni sforzo per COMPLETARE SE STESSA NELLA PROSPETTIVA INDICATA DAL MANIFESTO DI VENTOTENE, OGGI PIU’ CHE MAI ATTUALE.

CHI È NUDO: LO ZAR O IL KING?

di Slobodan Fazlagić
L’euforia che occupa il mondo intero, almeno da parte di chi segue i media di una certa autorità, è tutta innescata dall’irruzione sulla scena, con il piede pesante, del nuovo presidente americano. Tiene tutti in un costante stato di incertezza su come sarà la sua prossima eruzione di bullismo, senza che si distinguano i potenziali bersagli: nazioni, stati stranieri, territori in giro per il mondo, immigrati, impiegati statali americani… Una porzione di dessert amaro è assicurata per ciascuno.
Il denominatore comune a tutte le reazioni e preoccupazioni al mondo sono basate sulla conclusione ormai fatale: “Siamo entrati in un’epoca nuova; il vecchio sistema è stato rottamato”. Nei dibattiti su tutte le TV del mondo ci si affretta a discutere su come adeguarsi al nuovo terrificante uragano, allo tsunami partito dalla White House. Tira l’aria della convinzione che non vedremo mai più il mondo che abbiamo creato fino ad adesso, il mondo dei diritti umani, del rispetto della legge, dell’imparzialità politica e dell’indipendenza degli stati. Tutti hanno accettato e preso come eterno il cambiamento e l’abbandono dell’ordine che faticosamente la civiltà umana ha sviluppato negli ultimi duemila anni, scordandosi le brutte scivolate e le crisi belliche cha hanno disseminato il percorso.
Permettetemi una domanda! Ci siamo scordati tanto presto che nel sistema democratico, zoppo
come è, e pure minacciato seriamente dalle ondate della destra populista, abbiamo creato anche alcuni anticorpi? Che la tradizione democratica nutrita per secoli difficilmente può essere erosa con una gomma o con una plateale firma in grassetto da soap opera nello Studio Ovale? Un tale Donald si trasforma in una mezzanotte nell’immortale King Donald The Second che rimane al potere a vita? O dopo quattro anni dovrà lasciare la scena ed essere sostituto da una persona eletta con regolari elezioni democratiche? Costei può continuare sulla stessa linea, vero. Oppure potrà rovesciarla completamente, come lui ha rovesciato il sistema precedente! Credo che ci siamo affrettati troppo con le reazioni di panico, con un catastrofismo poco ragionevole. Il suo spirito ed ossessione imperialista non sono nuovi al mondo e si sono accumulati non pochi emuli dello stesso concetto… Tutti sono finiti come dovevano: nel buco nero della storia.
Guardando il suo staff, le cariche più importanti per il funzionamento di uno stato molto solido e basato su un macchinario burocratico consolidato e ben oleato per centinaia di anni, vediamo personaggi il cui curriculum politico svela una sola qualità: che sono tifosi fedeli del capo. Basta questo per mettere le mani in un meccanismo sofisticato, ramificato in tutte le sfere della società? Sinceramente, dubito che siano in grado di vincere contro il drago ostinato, disteso nelle caverne del potere esecutivo. Il deposito dei politici scaduti è pieno di Don Chisciotte che hanno tentato di smaltire la fortezza burocratica ereditata dopo tanti anni di maturazione come quella di Washington.
Nell’ottica di questa apparizione miracolosa sta il suo rapporto con il bullo gemello: Lo Zar del Cremlino. L’amico Vladimir. Meno raffinato e tanto più letale, certo. Lo Zar Vladimir Primo. Però ugualmente ossessionato dallo schema mentale di un imperialista spudorato. In comune hanno proprio un’assenza di freni di qualsiasi tipo e l’idea di dividere il mondo in due metà. I piccoli dettagli dove passa la sutura tra le proprie rispettive zone devono discuterle da soli, senza che nessun altro possa avere voce in merito. La nostra benevola e pacifica Europa appartiene al pubblico che può solo osservare lo show ed aspettare il risultato. Loro due sanno bene su che cosa si sentono legittimi proprietari e devono solo giungere alla spartizione. Non serve neanche un notaio, riescono a fare senza…
L’ innesco attuale del dibattito è dello Zar: si è avviato a prendere il suo, come dice e come ha annunciato, sempre negli show TV, il mezzo indiscusso della comunicazione urbi et orbi. Prima l’esordio nel 2014, poi il secondo tempo nel 2022. Noi, inconsapevoli del gioco sopra il nostro livello, ci siamo ribellati, abbiamo alzato la voce, abbiamo offerto resistenza. Alcuni hanno aiutato la difesa militare della povera Ucraina, altri hanno proposto di negoziare con lo Zar. Il risultato è uno stallo sanguinoso, in cui ogni giorno si perde povera carne umana inserita nella macina bellica, ma l’idea imperialista, per questo, non viene meno nella testa dello Zar.
L’altra sponda dei benevoli europei insiste sull’idea di negoziare con lui. Un’idea nobile, anzi eccellente, certo. Pero, che cosa significa negoziare? Scambiare le merci al mercatino delle pulci, niente altro. Che cosa abbiamo noi da offrire allo zar che lui non abbia già? Direi, molto poco. È più forte, ovvio. Per quale motivo dovrebbe cambiare idea e “lasciarti qualcosa che è suo”? Per salvare la faccia? Per quello, lui è a posto. La sua gente lo approva perché la controlla severamente, gli altri non significano niente. Potrebbe cedere solo in un modo: per la paura di perdere qualcosa. Ma siamo in grado produrla? Con che cosa possiamo fare paura a lui, che ha la bomba atomica? Magari, solo con una rivolta interna, con la caduta del sistema, con la possibilità che tra i seguaci emerga un Bruto che lo faccia fuori. Infatti, siamo a ridosso delle Idi di marzo e potrebbe essere una buona coincidenza…
Altrimenti, ci rimane di tentare di subire meno danni possibili stando alla finestra, osservando come la spartizione della zona critica ucraina verrà fatta dai due lottatori nudi, The King e Lo Zar, in pieno stile Jalta, ed aspettare che passino quattro anni in cui il miracolo feudale a Washington sparisca o qualche terremoto siberiano non cancelli la corte del Cremlino.
Tanta pazienza, testa sana per salvare l’Europa dalla disaggregazione delle forze interne e/o dalle malattie populiste e presentarsi sul palcoscenico al momento giusto. Poi si vedrà se ci faranno giocare o meno… Ma decisamente non come lottatori nudi. Questo è riservato ai baciati dal destino di Washington e Mosca.

PACE NON SOTTOMISSIONE

di Alessandro Bocci
Come sempre, ha ragione il presidente Mattarella. Per analogia di contesti storici, l’Ucraina è stata invasa con modalità da Terzo Reich. L’aggressione russa ha infatti natura di conquista.
Il sostegno europeo alla resistenza ucraina, spiace sottolinearlo, è stato debole ed inefficace. Alle tante dichiarazioni di solidarietà con quel popolo martoriato e che nel periodo stalinista aveva subito l’Holodomor, un genocidio che si stima aver causato milioni di morti, sono seguiti ben pochi fatti. Da un punto di vista diplomatico l’Europa non è mai stata incisiva, mentre da quello militare il sostegno all’Ucraina è risultato inadeguato e insufficiente a respingere gli aggressori.
Per favorire la pace, che è l’esatto contrario della sottomissione e dello smembramento territoriale, l’Europa avrebbe dovuto agire diversamente, con maggiore impegno ed efficacia.
Giustamente i leader europei lamentano l’arroganza del trio Trump, Putin e Xi Jinping, uomini ideologicamente e moralmente affini. In politica, però, lo spazio viene riconosciuto solo in virtù della propria consistenza. La domanda è allora questa: perché Trump, Putin e Xi Jinping dovrebbero definire gli assetti mondiali, striscia di Gaza inclusa, tenendo conto di un’Europa frammentata in mille litigiosi staterelli?
Su Repubblica, Ezio Mauro si spinge ad affermare che la Nato rischia di divenire uno strumento del passato, chiedendosi se, come previsto dall’articolo 5 del trattato atlantico, in caso di aggressione ad uno stato membro, gli altri paesi sarebbero disposti ad intervenire. C’era una volta l’Occidente, verrebbe da dire in sintonia con Lucio Caracciolo.
Circa quarant’anni fa, Enzo Bettiza, parlando dell’Unione sovietica, sosteneva che l’homo bolscevicus viveva in una duplice necessità biologica: quella di rimanere fermo all’interno per vivere e di doversi muovere all’esterno per sopravvivere. Senza voler parafrasare lo scrittore dalmata, peraltro inarrivabile, si potrebbe notare che per l’Europa, se vorrà vivere e sopravvivere, cioè continuare ad avere significanza e operare in favore della pace, è finito il tempo delle vaghezze e delle ipocrisie.

LEGGENDO BARICCO

di Libera Iannetta
Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il personaggio più iconico e amato dello scrittore
Alessandro Baricco, è stato il protagonista, insieme a sessantacinque studenti della sezione
bilingue del Liceo “L. Saru”, dell’XI edizione del progetto “Libriamoci” 2025, per la prima volta a
Bratislava. Gli studenti, quasi tutti di madrelingua slovacca, si sono avvicinati alla storia di un
personaggio che, a trent’anni di distanza dalla consegna al grande pubblico, continua ad
emozionare generazioni di lettori. Novecento, il neonato figlio della miseria, abbandonato in una
scatola di cartone sul pianoforte del salone della prima classe. Novecento, il pianista straordinario
che cresce sul Virginian, il piroscafo che fa la spola fra l’Italia e l’America e dal quale il protagonista
non riesce mai a staccarsi. Novecento che, attraverso gli occhi dei passeggeri, ruba l’anima al
mondo, vivendo della musica più grande di tutte, in una dimensione di sogno, fino a trasformarsi
in leggenda.
Le tematiche del legame e del sogno hanno ispirato le attività proposte agli studenti con gli
obiettivi di facilitare la conoscenza e l’espressione di sé, l’inclusione e la partecipazione
democratica di tutti, potenziando, al contempo, le competenze linguistiche dei partecipanti e
accrescendone l’interesse per la lingua e la cultura italiane. La lettura ad alta voce del testo,
sconosciuto alla totalità degli allievi, è stata affiancata da attività di previsione e ipotesi di sviluppo
della storia, drammatizzazione, book talk, scrittura creativa e collaborativa, attraverso approcci
metodologici e strategici quali il circle time e la didattica laboratoriale.
“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, va ricordato, è un progetto del Ministero della
Cultura e di quello dell’Istruzione e del Merito che, attraverso il Centro per il libro e la lettura,
intende promuovere l’amore per i libri e accrescere l’abitudine alla lettura. Vede coinvolti
numerosi Istituti scolastici della penisola per un totale di circa 3500 eventi, ma anche alcuni Istituti
gestiti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, afferenti alla rete del
Sistema della Formazione Italiana nel Mondo. Le iniziative attuate presso il Liceo “L. Saru” di
Bratislava sono state volute dall’Ambasciatore Gianclemente De Felice e si sono avvalse del
supporto dell’Istituto Italiano di Cultura della città.



I-TECH INNOVATION DELL’OPIFICIO GOLINELLI: DALL’IDEA AL SUCCESSO

di Teresa Tardia
L’innovazione guida lo sviluppo della nostra società, senza i cicli di invenzione, innovazione e sperimentazione non ci sarebbero dei passi aventi nel progresso della nostra società e del benessere in generale. L’innovazione ha bisogno di idee e di creatività che devono essere supportate dalle conoscenze sviluppate in numerosi ambii e a livello multidisciplinare. Tutti i processi di innovazione possono dare numerosi benefici a livello produttivo, ma anche attraverso prodotti/servizi nuovi che vengono introdotti nel mercato. Certo non tutti acquistano subito quello che è nuovo, ma certamente i pionieri fanno da apripista. In questo ambito alcuni poli di ricerca hanno una particolare vocazione all’innovazione, tra questi si distingue l’Opificio Golinelli che ha lanciato un progetto “Dall’idea al successo, oggi e domani | Open Day I-Tech Innovation. Durante questo evento sono state presentate le novità per il prossimo triennio di I-Tech Innovation e i nuovi partner coinvolti, che si uniranno alla Fondazione Golinelli e CRIF, che sono promotori di tutte le edizioni del programma, e ai partner tecnici Bi-Rex Competence Center, Gruppo BCC Iccrea e BCC Emil Banca. La parte istituzionale, invece, è rappresentata dalla Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e ART-ER.

all’Open DayDay del 20 gennaio 2025.
Nel corso di questi anni, sono state ricevute oltre 1.000 candidature, 150 delle quali selezionate per un’intervista, e sono state accelerate più di 50 giovani imprese. Sono stati erogati complessivamente più di 3.000 ore di formazione grazie al coinvolgimento di oltre 85 mentor e più di 80 partner industriali. Dal 2019 a oggi, sono stati raccolti fondi per oltre 27 milioni di euro tramite aumenti di capitale e grant. Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore Generale di Fondazione Golinelli, e CEO di G-Factor, ha dichiarato «l’apertura a nuovi partner e le importanti novità presentate per il programma segnano una tappa fondamentale nel percorso di crescita di I-Tech Innovation. In questi anni abbiamo consolidato una rete di collaborazioni che non solo rafforza le opportunità per le giovani imprese, ma ne amplia le prospettive grazie all’ingresso di attori strategici del territorio. Il nostro impegno è offrire un contesto unico, in cui risorse, esperienze e competenze si uniscono per supportare l’ecosistema imprenditoriale, con una visione che punta al futuro e alle necessità emergenti a livello nazionale e oltre. La presentazione delle verticali per il prossimo triennio, insieme al rinnovato programma G-Force, conferma la nostra volontà di continuare a investire nei talenti e nelle idee che possono fare la differenza». Loretta Chiusoli, Group Chief HR and Organization Officer e Managing Director di BOOM, ha commentato «siamo orgogliosi di essere giunti alla presentazione di una nuova fase del nostro programma, che continua a evolversi con successo. La partecipazione di CRIF e BOOM rappresenta un motore fondamentale per l’ecosistema dell’innovazione che abbiamo creato e che vogliamo far crescere a livello territoriale, offrendo opportunità concrete a startup, giovani, aziende e professionisti. Grazie all’esperienza accumulata e alle collaborazioni strategiche inserite in questo programma, abbiamo reso l’I-Tech Innovation Program non solo un trampolino di lancio per nuove idee e progettualità, ma anche un esempio tangibile di come costruire un ecosistema territoriale forte e competente: con la convinzione che solo unendo energie e risorse si possa costruire un futuro sempre più dinamico, significativo e ricco di possibilità». L’apertura della call per la nuova edizione, quella 2025-2026, è prevista per il mese di settembre, 2025 quando saranno anche approfonditi gli ambiti di innovazione richiesti e le modalità di candidatura. In ogni caso il programma si focalizzerà nel prossimo triennio sulle seguenti aree: Ed Tech in Life Science, Fintech & Insurtech, Agritech & Foodtech, Industry 4.0, Social Impact e Travel Tech & Smart Mobility.

Fonte: ph Giovanni Bortolani.
G-Force – il programma di accelerazione di G-Factor, l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli – consentirà la crescita delle giovani imprese selezionate. Di seguito sono riportate alcune iniziative particolarmente utili e che certamente animeranno ulteriori dimensioni e vantaggi e che provengono dalle esperienze passate di innovazione. Nel settore Life Science emerge Tepy, la prima app di intelligenza biomeccanica che aiuta a gestire dolori muscolo-scheletrici con esercizi personalizzati basati su un algoritmo predittivo avanzato; un secondo progetto e stato Sbrex, una startup innovativa e società benefit che sviluppa soluzioni tecnologiche per la valutazione precoce e il potenziamento delle funzioni cognitive, oltre che delle abilità scolastiche come lettura, scrittura e calcolo. Per la Circular Economy troviamo Ecosostenibile.eu, una startup ESGtech che accelera la transizione verso una low-carbon & circular economy, e MetaCasa, piattaforma all-in-one che semplifica e accelera il processo di
decarbonizzazione del patrimonio immobiliare. Nell’ambito Industry 4.0 spiccano Virevo, che supporta le PMI manifatturiere nella trasformazione del loro business attraverso l’intelligenza artificiale, e Robotizr, che ha sviluppato un’interfaccia grafica digitale no-code per il controllo di robot e periferiche industriali. Infine, per l’area Social Impact, emerge Stakeshare, una piattaforma SaaS progettata per aiutare le aziende a premiare e riconoscere i talenti basandosi sui risultati raggiunti, e Lendit, una fintech italiana che punta a rivoluzionare il settore del credito per le PMI grazie al suo modello innovativo di Integrated
Lending Circuit (ILC).
In conclusione, tutti coloro che hanno idee nei tempi previsti possono presentare le proprie proposte che possono trasformarsi in progetti concreti e di supporto all’evoluzione delle collettività.
IL DOLORE COME STRUMENTO DI CRESCITA: UN NUOVO SGUARDO SUL BENESSERE E LA CONSAPEVOLEZZA

di Nurgul Cokgezici
La crescita avviene nei momenti di dolore. È un concetto che può sembrare difficile da accettare, soprattutto in una società che ci spinge costantemente verso il benessere immediato, verso la fuga da ogni forma di sofferenza. Certo, stare bene è piacevole e desiderabile, ma è davvero nelle difficoltà che impariamo, ci trasformiamo e maturiamo.
Nel sufismo si dice che la cura di ogni ferita si trova al suo interno. Questo significa che la soluzione non è nella fuga o nella rimozione del dolore, ma nella sua comprensione. Accogliere il dolore, senza lasciarsene sopraffare, ci permette di ascoltarlo e di coglierne il messaggio: cosa ci sta dicendo? Cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita?
Negli ultimi anni, sempre più studenti manifestano stati d’ansia e attacchi di panico. Una situazione che sembra aggravarsi di anno in anno, probabilmente anche a causa delle aspettative e delle pressioni che noi adulti esercitiamo su di loro. Quando un ragazzo si trova in preda a un attacco di ansia, il suo corpo sta lanciando un segnale: qualcosa nella sua vita non va. Ignorarlo o sopprimerlo con soluzioni rapide e superficiali non aiuta. Al contrario, è fondamentale fermarsi, ascoltarsi e comprendere quale sia il disagio profondo. A volte, semplici tecniche di respirazione possono riportare equilibrio, ma il vero lavoro è più profondo: bisogna riconoscere e affrontare le cause del malessere.
Spesso, però, la nostra reazione immediata è la fuga: scappare dal dolore, evitarlo, cercare soluzioni immediate come farmaci antidepressivi. È importante distinguere tra la depressione clinica, che è una vera e propria alterazione della chimica cerebrale e necessita di un trattamento adeguato, e il malessere temporaneo, che invece può essere affrontato attraverso l’ascolto di sé e il supporto psicologico. L’uso eccessivo di farmaci, quando non strettamente necessario, rischia di allontanarci dalla vera soluzione e di renderci dipendenti da un sollievo artificiale.
Imparare ad accogliere il dolore non significa amarlo o cercarlo, ma riconoscerne il valore trasformativo. Il dolore può essere un’opportunità di crescita, un segnale di cambiamento, un’occasione per riscoprirci e rafforzarci. Solo affrontandolo con consapevolezza possiamo davvero evolvere, invece di restare intrappolati in una continua ricerca di benessere effimero.

LEGGENDE E STORIE DI MILANO – “TIREMM INNANZ”

di Giorgio Righetti
“TIREMM INNANZ”: Così con cuore di romano antico, Antonio Sciesa milanese, all’austriaco gendarme che vita e denaro gli offriva a patto di delazione, sprezzante e sdegnoso rispondeva. Questo marmo sulla casa ch’egli abitò lungamente consacri alla riverenza dei presenti e dei venturi la memoria del cospiratore popolano fucilato il 2 agosto 1851.
QUESTA LAPIDE POCO LEGGIBILE murata sull’edificio della banca d’Italia in via Cesare Cantù manca di precisione. Si chiamava Amatore e non Antonio, Antonio è un errore dello scrivano austriaco che compilò l’atto di morte. Non disse mai “Tiremm innanz” e non passò mai sotto casa prima dell’esecuzione. Quella che segue e la vera storia di come si svolsero i fatti.
Per reprimere il tentativo deliberato anti-austriaco più che mai attivo a tre anni di distanza dalle Cinque Giornate (18-22 marzo 1848), il maresciallo Radetzky, emanò un proclama che annunciava punizioni severissime contro chi diffondeva manifesti e giornali che incitassero alla rivolta. Malgrado questa misura non cessarono gli atti di ostilità contro le autorità governative. Nella notte del 30/31 luglio 1851 la polizia austriaca scopriva alcuni manifesti, affissi in varie zone di Milano, il loro contenuto era un appello ai milanesi perché si ribellassero al governo austriaco, la stessa notte una ronda militare fermava un uomo sospetto e lo invitava a dare le proprie generalità. L’individuo veniva identificato come Amatore Sciesa, nato a Milano, di 37 anni, di professione tappezziere, abitante in piazza della Rosa 3124. Alla domanda perché fosse in giro a quell’ora di notte, rispondeva di aver passato la sera all’osteria. Il fermo era avvenuto all’angolo di via Spadari e via della Lupa (attuale via Torino), il racconto sembrava verosimile, ma perquisito le venivano trovati addosso alcuni manifestini simili a quelli affissi ai muri. Ammanettato e condotto al circondario di Polizia in contrada Santa Margherita, veniva interrogato. Alle continue domande da dove venissero i manifesti, rispondeva: “Mi soo nagott… mi parli no…quel che è faa è faa…”. “Non so niente, non parlo, quel che è stato è stato”. Il giorno 1 agosto lo Sciesa lo passava in guardina, in attesa che tornasse un messo inviate a Monza dal maresciallo Radetzky, che torno con questa risposta: “Bisogna dare un esempio. Il caso venga immediatamente liquidato e punito con la pena capitale sul luogo dell’arresto”. Al primo sorgere dell’alba del 2 agosto Amatore Sciesa veniva portato al Castello e alle dieci del mattino processato sommariamente. Condannato a morte e alle due del pomeriggio fucilato. Perché fucilato e non impiccato sul luogo dell’arresto come voleva Radetzky, perché a Milano non c’era il boia, il giorno prima era stato fatto arrivare un tirapiedi che non sapeva fare il suo mestiere, e non si poteva assicurare una cosa ben fatta. Questa è la storia, l’episodio che prima dell’esecuzione il tappezziere venisse fatto passare davanti alla sua casa di piazza della Rosa, dove al balcone erano affacciati la moglie e il figlioletto e, un gendarme sustriaco gli suggerisse di fare il nome dei complici promettendogli in cambio la libertà, lo Sciesa avesse risposto con la famosa frase: “Tiremm innanz”, non è mai avvenuto, di conseguenza niente “Tiremm innanz”. Queste imprecisioni sono giustificabili, perché solo dopo gli anni venti del secolo scorso, fu possibile consultare gli atti del processo e ricostruire in anni recenti la vera storia. Come è nata la leggenda non si sa, è certo che lo Sciesa fu trasportato al Castello prima dell’alba e non ne uscì più e che tra la sentenza e l’esecuzione non ci fu il tempo per fargli fare un giro per Milano. Va tenuto presente anche l’arresto della moglie imprigionata nelle carceri, dalla mattina successiva dell’arresto del marito, anche il figlio era assente ospitato dallo zio. Quindi tutta la scena cade nell’immaginario. Non é però necessaria la leggenda per la gloria dell’eroe. “Mi soo nagotta!… Mi parli no…”. Sono queste le parole che sottolineano un sacrificio consapevole che non ha bisogno della leggenda per risplendere di luce forte e vivida. Non c’è niente di più coerente di una leggenda essa risponde sempre ai principi di necessità e casualità, non nasce mai a casaccio per riproporre di nuovo all’attenzione e al giudizio degli altri la realtà delle cose, ma ha la capacità di condannare, giustificare, sferzare o anche nascondere la realtà, è affascinante e suggestiva, e quando è necessario ecco la funzione della storia a chiarire tutto. È giusto raccontare la storia come è realmente accaduta, ma a volte un pochino di leggenda non fa mai male. Se non fosse stata creata attorno all’eroe, probabilmente nessuno ricorderebbe Amatore Sciesa, anche se la risposta da lui data agli inquisitori austriaci era stata sicuramente gloriosa.
Sul manifesto dell’esecuzione della sentenza di Amatore Sciesa si legge Sciesa Antonio, è un errore dello scrivano austriaco che compilò l’atto di morte, inoltre fu arrestato in via Spadari in zona Duomo e non nel Corso di Porta Ticinese, come si legge sul manifesto.

UNA MOSTRA DA NON PERDERE
A distanza di 20 anni, sabato 8 marzo il Circolo Gino Giugni del Pd di Affori ripropone la mostra “Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani”.
Nella giornata di domenica 9 marzo, alle ore 11.30, interverranno Sara Bossa, Paola Bocci e Anita Pirovano.
Pubblichiamo volentieri la locandina che il Circolo Gino Giugni ci ha gentilmente inviato su questa importante iniziativa.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 8

di Fabio Fumagalli
S’ciao bèlla gent. El mes de marz el dedichi a tucc quèi che m’hann domandaa ona barzellètta e anca cont ona curiosità che ho legiuu su on liber de stòria.
Sèmm in del bèll mèzz de la giunga, duu cannibali hinn adree a cicciarà:
– Soo nò cosa fà de la mia miee – el dis vun di duu.
– Te voeuret che te prèsti el mè liber de cusina?

Notizzi dal mond:
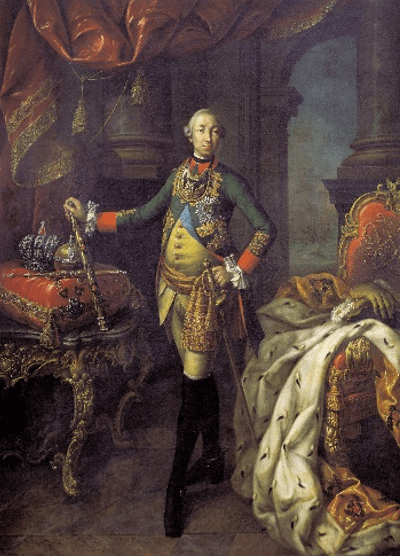
El zar de la Russia, Peder III, marì barlafus de Caterina la Granda, l’era pròppi convint de vèss on grandissim stratega.
Per mantegniss in esercizzi, l’era abituaa a studià di complicaa pian de battalia cont i soldaritt de piomb: poeu je metteva in di corridor e in di saloni del palazz imperial.
Per completà l’òpera in di sit che lù el pensava che podeven vèss strategich, el ghe metteva i camerer, i coeugh e i giardinee.
Minga soddisfaa ghe faseva anca mètt-sù l’uniforma e je armava ben ben.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese

IO NON SONO RAZZISTA, MA…

di Luigi Filipetto
Cosa letta e sentita mille volte. Ripetuta poi nelle alte sfere, naturalmente con un linguaggio più elevato:
sicurezza e difesa dei nostri confini, lotta nel globo terraqueo ai trafficanti, sostituzione etnica e amenità
simili.
Quel «ma» che risuona nelle nostre contrade la dice lunga. Se chiedi: ma?, la risposta tradisce.
Sembra una tara che colpisce l’umanità intera. Negli anni Cinquanta, con la povertà generale di cui si
soffriva, a causa soprattutto della guerra conclusasi da poco, l’Europa era la meta più facilmente
raggiungibile in cerca di un pezzo di pane, soprattutto per noi del Nord. Che cosa si incontrava di là dal
confine? Qui mi limito ad alcuni cenni famigliari. Io ero andato in Francia come turista. Alla frontiera
l’agente mi chiede di esaminare la mia disponibilità di denaro. Dal portafoglio srotolo mille lire di carta, un
piccolo lenzuolo. L’agente lo prende in mano e sorride, lo fa vedere al collega e sorridono insieme. Mia
sorella era andata in Francia per lavoro, con una vecchia valigia di cartone. Giunge in Svizzera e scende per il cambio del treno. Gli agenti di servizio la seguono con lo sguardo. Lei li guarda imbarazzata per i sorrisi di scherno che si sente addosso. Mio fratello, in Belgio anche lui per lavoro nelle miniere di carbone, cerca una stanza e su una porta si imbatte sulla scritta “Interdit aux chiens et aux italiens”. Un altro fratello parte giovane per il Sud Africa, c’era un’offerta di lavoro nelle miniere d’oro. Ci andava a piedi a lavorare. Erano i tempi dell’apartheid. E quando sul marciapiede incrociava un locale questi non doveva limitarsi a scansarsi per farlo passare, ma doveva scendere sulla strada.
Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar. La meta più ambita erano l’America e
l’Australia. Partivano anche dal mio paese, mariti e fratelli lasciavano le famiglie. Assiepavano le navi in
partenza, la documentazione fotografica è più che abbondante. Anche allora esistevano i cosiddetti
trafficanti. Laggiù non è che fossero accolti a braccia aperte. Mi limito a riportare alcuni documenti piuttosto eloquenti.
Il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, intercettato durante una conversazione nello Studio
Ovale il 13 febbraio 1973, così si esprimeva a riguardo degli Italiani: “Non sono, ecco, non sono come noi.
La differenza sta nell’odore diverso, nell’aspetto diverso, nel modo di agire diverso. Dopotutto non si
possono rimproverare. Oh, no. Non si può. Non hanno mai avuto quello che abbiamo avuto noi. Il guaio è…. e non ne riesci a trovare uno che sia onesto”.
Prima ancora, nel 1924, il presidente del Museo americano di storia naturale, Henry Fairfield
Osborn, durante una conferenza nazionale sull’immigrazione, sintetizzò efficacemente lo spirito di
accoglienza della popolazione statunitense: «Questi immigrati stanno facendo degli Stati Uniti una discarica per cittadini indesiderabili».
Ottobre 1912, relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati
italiani negli Stati Uniti (a cui siamo grati per aver voluto privilegiare i veneti e i lombardi!): “Generalmente
sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo
appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell’Italia”. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione”.
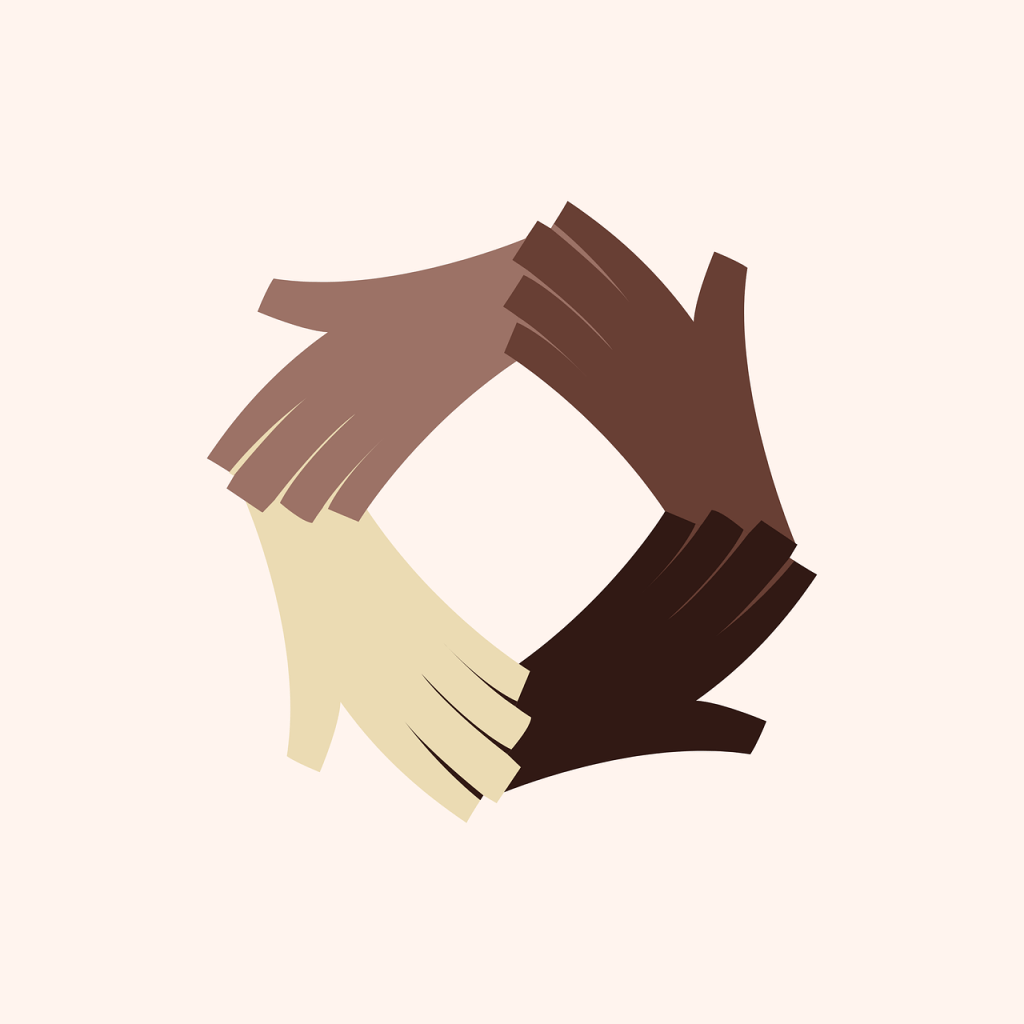
LEGGENDE E STORIE DI MILANO – EL TREDESIN DE MARZ

di Giorgio Righetti
Era il 13 di marzo ed era l’anno 51, secondo la tradizione quel giorno San Barnaba era arrivato a Milano per diffondere il cristianesimo, era partito da Antiochia con una sacca a tracolla, una scodella per attingere l’acqua alle sorgenti e un bastone nodoso su cui era allacciata di traverso una rozza croce, si fermò a riposare in una boscaglia al di fuori della Porta Argentea, in seguito porta Orientale (attuale Porta Venezia), pronto a iniziare la sua missione. Con fatica aveva infisso la croce in una grossa pietra, non prima di aver tracciato tredici piccoli solchi a raggiera che partivano dalla base della croce fino al bordo del sasso. Per passare dalla Porta Argentea, si era obbligati a sacrificare alle statue degli dei pagani posti agli ingressi di Milano. Confidando nel Signore e fatti i primi seguaci Barnaba entrò in città e, al suo passare tutte le statue delle divinità pagane caddero a terra e si frantumarono, sebbene ancora in Inverno le piante fiorirono come in un bel giorno di primavera. Non si fermò molto Barnaba a Milano, forse nemmeno un anno, ma a ricordare il suo arrivo in città si tenne per secoli una bellissima fiera di fiori detta “del Tredesin de Marz”, perché si teneva precisamente il giorno 13 di marzo, si allargava con i suoi profumati e multicolori prodotti lungo i bastioni sino a Porta Romana, era molto frequentata perché era la prima fiera di fiori dell’anno e confermava la fine dell’inverno. Oggi la fiera è ridotta ad una sparuta apparenza di quella antica, è stata spostata in via Crema e adiacenze, ha mutato il suo carattere, ha perduto poesia, ai fiori si sono aggiunte altre mercanzie, è diventata una delle fiere-mercato come tante altre. Malinconie di fine Ottocento queste parole di Emilio De Marchi: (E le giornate del tredici marzo? c’era la fiera tutta in lunga fila, giù fino al dazio, coi banchetti di viole, e di gerani, le prime rose, e tra guardare, annusare e toccare si andava via col cuor come un giardino, pensando al bel faccin di Carolina che sott’al cappellino alla Pamela e con la rosellina sopra il seno ti sembrava anche lei la primavera). Ma malgrado tutto a testimoniare del passaggio di Barnaba a Milano esiste ancora la pietra dove secondo la tradizione S. Barnaba infisse la croce fuori dalla Porta Argentea in un giorno lontano di duemila anni fa, la pietra fu trasportata nella Chiesa di Santa Maria al Paradiso a Porta Vigentina, dove la si venera tuttora e porta incisi tredici segni a ricordare il giorno in cui il santo arrivò a Milano. Un’antica usanza famigliare si ricollega a questa data; quella praticata un tempo, la quale consisteva nel tagliare i capelli ai bambini al “Tredesin de Marz”, per irrobustirli e farli crescere folti.

IL DECLINO EUROPEO

di Alessandro Bocci
Nei processi economici, il Pacifico prende il posto sempre più rapidamente dell’Atlantico, l’ormai vecchio centro del mondo.
In Europa, non esistono imprese con capitalizzazione sufficiente a competere con le corporations californiane che gestiscono le grandi piattaforme digitali. Nel campo dell’intelligenza artificiale, le società che effettuano le ricerche più avanzate sono statunitensi e cinesi. Ci preoccupiamo, anche giustamente, degli Elon Musk, senza chiederci come mai da noi non ne nascano.
Oltre a criticare il vetusto sistema dell’ unanimità degli stati membri nel processo decisionale, nel rapporto Il futuro della competitività europea, Mario Draghi puntava l’indice contro la frammentazione del mercato unico che impediva alle imprese di raggiungere dimensioni tali da poter assumere significanza globale.
In realtà, larga parte della popolazione europea ritiene che la concentrazione di risorse tecnologiche in poche mani potrebbe favorire trasformazioni in senso antidemocratico delle democrazie liberali. È una preoccupazione ovviamente fondata, ma si potrebbe obiettare che storicamente è stato il declino economico a favorire l’ascesa degli autoritarismi e che le innovazioni tecnologiche hanno sempre giovato alla lotta alle disuguaglianze.
Di fatto, l’Europa si trova a dover fronteggiare varie sfide: il passaggio da stati nazionali a multietnici, la questione della sicurezza, il problema energetico, la difesa comune, l’inverno demografico (che rischia di spazzare via nel prossimo mezzo secolo la popolazione italiana). In più, ampie fasce della società europea sembrano, per presunzioni ideologiche, non voler contrastare economicamente i mondi statunitensi e cinesi. Tanti favoleggiano di decrescita felice. Forse varrebbe la pena rileggersi il Rapporto Draghi e fare in modo di non essere emarginati. La sudditanza economica non ha mai portato fortuna.

PARROCI NEL TERZO MILLENNIO
INTERVISTA A DON MAURIZIO PEZZONI

a cura di Luigi Filipetto
Nel quartiere milanese di Piazza Santa Maria del Suffragio, quando nel 2015 apparve il primo mercato contadino a Milano, era parroco don Maurizio Pezzoni. In quella data si costituiva nel quartiere anche un gruppo social, uno dei tanti a Milano. Era un gruppo laico. Le tre componenti si allearono e condivisero valori e progetti.
Il segnale più incisivo forse fu il coinvolgimento della parrocchia. Su questo segnale e più in profondità sul ruolo delle parrocchie nei quartieri abbiamo intervistato don Maurizio, che ringraziamo per la sua disponibilità.
Che cosa ti ha spinto ad aderire, anzi a promuovere il coinvolgimento della
tua parrocchia?
Credo che la presenza di una parrocchia in un quartiere non possa ridursi all’aspetto puramente religioso (celebrazione dei sacramenti, formazione spirituale, ecc…), che pure caratterizza la sua esistenza in un territorio, ma debba essere capace di intercettare il bisogno di molti ad avere momenti, spazi, esperienze adeguate a riconoscersi anche al di fuori della più stretta comunità cristiana. La città non riesce più − e forse vi non aspira nemmeno − a essere il luogo dove l’esperienza comune viene filtrata e sedimentata. Non ne ha più né il tempo né il modo. L’ideale non è più quello di essere il luogo dove si vive, ma piuttosto diventa sempre più un sistema di opportunità, contenitore di possibilità, rinunciando a qualunque identità. Nascere in un luogo è sempre meno frequentemente l’elemento che prevede l’abitarci.
Dunque, da qui, la necessità di avere un minimo di riferimenti vicini, facili da individuare, attorno ai quali un quartiere possa ritrovare un minimo di prossimità tra le persone.
Quali sono i momenti e le iniziative in comune che maggiormente ricordi?
Avevamo fatto alcune esperienze simili anche prima di realizzare il mercato contadino ma con scarsi risultati. I momenti più importanti che hanno reso possibile la nascita del mercato del sabato (attraverso la collaborazione del Consorzio Mantovano, il gruppo social e la parrocchia) sono stati anzitutto una stima reciproca per le competenze di ciascuno, la capacità di coinvolgere in un lavoro di conoscenza delle realtà sociali già esistenti sul territorio (scuole, organizzazioni di volontariato, realtà di vario genere…). Questo ha permesso di realizzare quello che tuttora continua a essere una realtà di servizio al quartiere. Molte volte e in diverse occasioni ci si è incontrati, anche in modo pubblico, nelle sale messe a disposizione dalla parrocchia per mettere a punto l’iniziativa.
Ci sono state reazioni fra i tuoi confratelli e anche nei superiori?
La cosa ha interessato anche altre parrocchie: lo stesso mercato si svolge il giovedì in piazza Berlinguer con l’appoggio del parroco di san Vito al Giambellino, sebbene poi non abbia riscontrato altre adesioni. Su cose di questo genere un parroco può decidere autonomamente, facendo attenzione al fatto che la parrocchia non sia coinvolta in attività commerciali o direttamente compromessa con l’attività svolta.
Come vedi la funzione di una parrocchia oggi nella vita di un quartiere?
Sono convinto del fatto che se da un lato la parrocchia non è una struttura provvisoria o instabile, dall’altro, proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità, ma devo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti al fine di essere più vicine alla gente, ambiti di comunione viva e di partecipazione e si orientino completamente verso la loro missione. Alcuni tentativi di riflessione sono stati attuati, e alcune esperienze stanno prendendo piede, ma il tema dell’essere parrocchia oggi in una città non è ancora, a pieno titolo, presente nell’agenda pastorale delle chiese locali italiane. La conversione pastorale, premessa inevitabile per la pastorale in una grande città, passa attraverso il superamento di due posizioni contrapposte ma ugualmente discutibili. La prima è l’accomodarsi allo spirito del tempo, che finisce in un relativismo senza idee né cuore e che lascia le persone affidate a sé stesse e autonome rispetto alla dimensione religiosa; la seconda è la chiusura istituzionale, tipica di una sotto-cultura ecclesiastica, di taglio clericale, che punta solo sulle sicurezze e cerca di difendersi perché vede nel mondo una minaccia e in fondo ignora la realtà. Il clericalismo è una difficoltà oggettiva che condiziona molte scelte pastorali, anche quando si nutre di
parole e dichiara di voler cambiare perché … tutto resti come prima!
Quali sono i nuovi problemi che un parroco oggi si trova di fronte?
Il primo dato evidente è lo stretto legame tra il prete e la sua comunità, tra il contesto di vita e il ministero che ci troviamo a svolgere a Milano. Detto a mo’ di slogan, la comunità genera il prete, in qualche modo lo plasma, lo forma, anche se spesso abbiamo la pretesa o l’illusione che accada il contrario. Chi è dunque il prete a Milano? Cosa fa? Come vive? Quali chances e quali fatiche incontra per la sua persona e per il suo ministero? Chi diventa quel credente che esercita il ministero ordinato a Milano? A Milano un prete si santifica, nel suo ministero quotidiano, fatto di mille incombenze: richieste, incontri, catechesi, confessioni, celebrazione dei sacramenti…, ma anche sostegno a chi soffre, a chi è preoccupato per i figli e per il futuro, a chi nella grande città è rimasto solo, è anziano o malato. Mille incombenze, che spesso toccano anche la gestione e la buona amministrazione dei beni e delle strutture affidate, gestione che quasi sempre è condivisa con quei laici con cui, grazie a Dio, gli è dato di collaborare. A Milano un prete si frustra, perché molti si perdono e perdono la fede, perché a volte gli oratori si svuotano e i giovani fanno altre scelte; perché nonostante la passione e l’impegno, percepisce che chi ha davanti non si fida
ne’ di lui ne’ di Dio; perché sarebbe bello avere il tempo di incontrare tutti quelli che lo vorrebbero, sedendosi con calma per ascoltare col cuore; perché quella Parola che gli ha toccato il cuore, non trova spazio nel cuore delle gente che ha imparato ad amare. A Milano un prete si spende, e forse un po’ si logora, nel tentativo di rispondere alle tante, troppe povertà delle nostre periferie o delle famiglie di chi ha perso il lavoro; le povertà legate alla fragilità psichica e affettiva; quelle dei nostri ragazzi che ancora, nonostante tutto, finiscono nella droga; quelle di chi quotidianamente bussa alle nostre porte e tende la mano: emarginati, immigrati italiani e stranieri spesso sfruttati, oppure trattati come delinquenti; la povertà anche di chi invece ha tutto, ma ha perso il desiderio di vivere. A Milano un prete si siede, adattandosi a comunità stanche e troppo invecchiate, incapaci di aprirsi al territorio, indisponibili a camminare insieme ad altre comunità cristiane; comunità talvolta chiuse in antiche basiliche e un po’ sostenute, come vecchie matrone decadute, a volte celebrando liturgie che sanno di vecchio e poco comunicano della forza del vangelo. Così magari senza volerlo e senza accorgersi, anche il prete si ritrova seduto, invecchiato prima del tempo, senza necessariamente essere davvero anziano, però purtroppo già vecchio, vecchio “dentro”. A Milano un prete si espone, camminando sul filo e senza rete sotto, confrontandosi ogni giorno con le innumerevoli persone che sono “sul confine”: quelle che si trovano in situazioni irregolari cioè credenti che cercano di vivere come possono la loro fede; quelli che non credono, ma che chiedono sinceramente di capire; i tanti a cui in fondo non importa nulla ne’ del prete ne’ di quello che rappresenta, che in sostanza se ne fregano e pretendono soltanto, perché dicono: “la chiesa dovrebbe…, la chiesa non capisce…., la chiesa ha sbagliato….”; ma anche quelli che vorrebbero ricominciare, rimettersi in cammino e non sanno da dove partire. A Milano un prete si imborghesisce, qualche volta addirittura si imbosca, inventandosi un ministero “improbabile”, correndo dietro a gruppi e
spiritualità o devozioni strane, oppure mettendosi al servizio di desideri inutili di famiglie benestanti, servendone i figli annoiati e viziati, o rispondendo a bisogni religiosi che con la fede nel Dio di Gesù Cristo poco hanno a che vedere; così, a volte, si ritrova ad assumere ritmi e stili di vita, che con la sobrietà e la semplicità della vita cristiana non c’entrano nulla. A Milano un prete si perde o si ritrova, nel desiderio di una fraternità cercata e insieme temuta; nel bisogno di relazioni autentiche con i confratelli,
con la propria comunità e con gli uomini e le donne che nella nostra città, a volte come naufraghi, a volte come viandanti, sono alla ricerca di veri compagni di cammino. Ma come gli uomini e le donne di questo nostro tempo, nella grande città talvolta si perdono in relazioni impossibili; oppure si giocano fino in fondo, rimettendoci perfino la salute, pur di restare fedeli a tutti quei legami nati a motivo della fede e fondati sul Signore. A Milano un prete si attende qualcosa, forse molto: si attende di essere conosciuto nel proprio percorso umano e spirituale; si attende di essere ascoltato e possibilmente interpellato sulle scelte importanti, non solo di essere messo davanti a decisioni di cui prendere atto e semplicemente, o
passivamente, obbedire; si attende che gli venga offerta ancora una buona formazione, capace consegnare gli strumenti per interpretare questo nostro tempo e poter ancora annunciare il vangelo all’uomo di oggi. A Milano un prete si attende anche di non perdere la fede e magari, se possibile, di farla
crescere. A Milano (ma non solo a Milano) un prete si interroga, su questo momento di chiesa, sui passi che ci stanno davanti, per la nostra diocesi e per la Chiesa universale; si interroga su dove lo Spirito del Signore ci sta conducendo attraverso il magistero del nostro pastore; si interroga su come essere davvero in comunione col proprio vescovo, nel desiderio sincero di camminare insieme.


L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI): SFIDE ED OPPORTUNITÀ NELLA NUOVA PROFESSIONE

di Emanuela Maritato
L’intelligenza artificiale è ormai una realtà che non può essere ignorata. Ignorarla significherebbe mettere a rischio la propria competitività in un mercato sempre più esigente.
L’intelligenza artificiale (IA) è ormai fondamentale per rimanere competitivi nel mercato. Automatizzando compiti ripetitivi e analitici, consente ai professionisti di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto, come la consulenza strategica e la pianificazione, che richiedono competenze umane. Nei settori legale e contabile, l’IA, tramite Natural Language Processing (NLP) e Machine Learning (ML), può automatizzare la documentazione, analizzare dati, effettuare ricerche giuridiche, predire esiti giudiziari, gestire chatbot per assistenza clienti, e supportare decisioni strategiche. Nonostante i progressi, gli studi professionali italiani sono ancora indietro rispetto a quelli stranieri, principalmente per ragioni di dimensione. L’aggregazione di studi professionali diventa così una soluzione per affrontare la trasformazione tecnologica e condividere i costi dell’innovazione. Ottimizzare risorse e tempo, delegando i compiti ripetitivi e analitici si liberano tempo e risorse per concentrarsi su altri aspetti della professione, che richiedono un’alta competenza intellettuale e interpersonale. Questi “compiti ad alto valore aggiunto” includono, ad esempio, la consulenza strategica con i clienti, dove l’esperienza e il giudizio umano sono fondamentali per fornire soluzioni personalizzate. Allo stesso modo, la pianificazione strategica di business richiede una comprensione profonda del contesto di mercato, qualcosa che ancora non può essere completamente affidata a un algoritmo. Questi compiti sono generalmente più remunerativi e offrono un maggiore valore sia per il professionista sia per il cliente, contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo dello studio professionale.
Nello specifico non si può trascurare che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale (IA), nello specifico come la professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presenta un’ampia gamma di rischi e opportunità, sia dal punto di vista percepito che da quello reale.
Uno dei principali rischi percepiti riguardo all’IA è la possibile sostituzione delle competenze umane. La preoccupazione che i sistemi automatizzati possano rendere obsoleti i professionisti contabili è ampiamente diffusa. Tuttavia, la situazione è più sfumata. Sebbene l’IA possa automatizzare alcune attività ripetitive, il vero valore dei professionisti contabili risiede nella loro capacità di analizzare criticamente, interpretare i dati e offrire consulenza strategica.
Poiché uno dei timori più diffusi, se non il principale, riguarda la possibile sostituzione dell’uomo con l’IA, è importante sottolineare che l’IA non è stata sviluppata per sostituire l’essere umano, ma per affiancarlo. Sebbene alcune attività ripetitive possano essere automatizzate, il valore dei professionisti contabili risiede nella loro capacità di analisi critica, nell’interpretazione dei dati e nella consulenza strategica. Per questo motivo, gli esperti rimangono essenziali per interpretare i risultati generati dall’IA e per guidare i clienti nel prendere decisioni informate. L’IA, infatti, apre nuove opportunità che potrebbero rivoluzionare la professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, come altre professioni. Tra queste opportunità, l’automazione della gestione dei documenti, della verifica della conformità fiscale e della preparazione dei report finanziari può semplificare e velocizzare molte operazioni. L’adozione di algoritmi di IA consente di automatizzare attività ripetitive, liberando tempo per i professionisti, che così possono concentrarsi su compiti ad alto valore aggiunto.

IL RUOLO DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE: QUANDO LE DONNE COSTRUISCONO IL FUTURO DELL’INTEGRAZIONE

di Nurgul Cokgezici
Ci sono incontri che cambiano prospettive, esperienze che trasformano non solo chi le vive ma anche l’ambiente circostante. Ho avuto il privilegio di essere docente per un gruppo di donne straordinarie, provenienti da ogni parte del mondo, tutte accomunate da una missione: diventare mediatrici linguistico-culturali per costruire una società più giusta e accogliente.
Queste donne, laureate in psicologia, fisica, economia, lettere, scienze umane e altre discipline, incarnano il cambiamento. Con competenze accademiche e un bagaglio umano straordinario, si sono impegnate a superare barriere culturali e linguistiche per facilitare il dialogo, l’integrazione e la comprensione tra persone di origini diverse. Un compito cruciale, in un mondo che chiede sempre più ponti e sempre meno muri.
Mediatori tra mondi: il valore dell’integrazione
Il mediatore linguistico-culturale non è solo un traduttore di lingue, ma anche un traduttore di culture, emozioni e aspettative. È una figura chiave per favorire l’integrazione in contesti spesso complessi, dove la diversità può essere percepita come un ostacolo piuttosto che come una risorsa.
Queste donne lavorano nelle scuole, accogliendo studenti immigrati e le loro famiglie. Il loro compito non si limita a facilitare la comunicazione, ma consiste nel rendere il cammino dell’integrazione più umano e più semplice. Sono il punto di riferimento per madri e padri che cercano di orientarsi in un sistema scolastico nuovo, spesso lontano dalle loro abitudini culturali.
Negli ospedali, le mediatrici accompagnano medici e infermieri, creando un ponte tra chi cura e chi ha bisogno di cure. Qui, la comprensione culturale diventa fondamentale: non si tratta solo di capire una diagnosi, ma di rispettare sensibilità e tradizioni, per garantire a ogni paziente dignità e rispetto.
In istituzioni come carceri e questure, queste donne portano pace e comprensione con la loro sola presenza. Operano in contesti di forte tensione, dove l’equilibrio è precario, aiutando a superare conflitti che nascono spesso da incomprensioni culturali. Sono, a tutti gli effetti, ambasciatrici di pace.
Nei consultori, infine, curano le ferite dell’anima, supportando persone in situazioni di vulnerabilità. Grazie alla loro empatia e alla conoscenza delle sfumature culturali, offrono un aiuto che va oltre il semplice ascolto, diventando un sostegno concreto e prezioso.
Donne straordinarie: il cuore del cambiamento
Queste donne non sono solo professioniste, ma anche madri, spesso di due o tre figli, che con amore e dedizione crescono una nuova generazione pronta a costruire il futuro del nostro paese. Provengono dalla Cina, dal Perù, dall’India, dal Marocco, dalla Malesia, dall’Egitto, dal Ghana e da tanti altri Paesi del mondo. Portano con sé un livello di istruzione elevato, una determinazione incrollabile e un amore profondo per il loro paese adottivo, dove non solo si sono integrate, ma contribuiscono attivamente al suo progresso.
Sono donne che si sono spogliate dei titoli e delle gerarchie per intraprendere un cammino condiviso, con un unico obiettivo: diventare figure centrali per il dialogo e l’inclusione. Grazie a loro, l’integrazione non è solo un sogno, ma una realtà che si costruisce giorno dopo giorno.
Il cambiamento inizia qui
Il mediatore linguistico-culturale è più che un professionista: è un simbolo di speranza, una dimostrazione concreta che il cambiamento è possibile. Queste donne, con il loro lavoro silenzioso e determinato, costruiscono un paese più umano, più accogliente, più inclusivo.
Il cammino continua, ma grazie a loro il cambiamento è già iniziato. E forse è proprio questo il messaggio più importante: il futuro si costruisce non con grandi proclami, ma con gesti concreti, con l’impegno di chi, ogni giorno, tende la mano per abbattere barriere e costruire ponti.
Queste donne meritano riconoscimento, non solo per il loro ruolo professionale, ma per il bene inestimabile che fanno al nostro paese e al mondo intero. Ambasciatrici di pace, artefici di integrazione, eroine del quotidiano: sono loro a dimostrare che il cambiamento, quando guidato da anime straordinarie, è davvero possibile.

LEGGENDE E STORIE MILANESI. 3 FEBBRAIO. IL PANETTONE DI SAN BIAGIO

di Giorgio Righetti
Un tempo non esisteva meneghino che nel giorno di S. Biagio rinunciasse a un pezzetto di panettone o, per dirlo meneghinamente “panattón” tenuto da parte da Natale. Come spiegare questa usanza? Un vecchio proverbio infatti ricorda che “El dì de San Bias se benediss la gola e el nas”, anche in memoria di San Biagio di Sebaste, che aveva miracolosamente guarito un bambino, a cui si era conficcata in gola una spina di pesce. Da quel giorno la fama di Biagio corse per tutta l’Armenia, giungendo purtroppo anche all’orecchio di Agricola, prefetto di Diocleziano, il quale sapendolo un apostolo della nuova fede lo fece cercare e condurre al proprio cospetto. Il colloquio fu tragico, Biagio si rifiuto di rinnegare il vero Dio e Agricola lo condannò a esser decapitato, prima di decapitarlo i suoi aguzzini gli straziarono le carni con i pettini di ferro dei cardatori di lana. La tradizione del panettone terapeutico ai giorni nostri si è molto modificata per profondo rispetto ai dettami del consumismo, per cui abbandonata l’usanza di conservare una fetta di panettone, si è pensato di mettere in vendita in corrispondenza di S. Biagio, due panettoni al prezzo di uno. Ma cosa c’entra il panettone milanese con S. Biagio? Altro che centrarci, perché dopo il miracolo della spina di pesce non vi fu madre cristiana che nel giorno di S. Biagio non spartisse in famiglia un pezzetto di pane dopo averlo fatto benedire dal prete. Anche le madri milanesi fecero altrettanto, ma alla comparsa del panettone ritennero che questo dolce avrebbe avuto miglior risultato.
UN FRATE DI NOME DESIDERIO. Ma qui bisogna rifarsi a un fatto successo nel periodo natalizio molti secoli dopo il miracolo della spina di pesce e che racconta di una donna che avendo comperato due panettoni per Natale, – in quel tempo chiamati “pan grandi” – penso di serbarne uno per la festa di S. Biagio e di portarlo al suo confessore frate Desiderio un rubicondo francescano per farlo benedire. “Oggi è la vigiglia di Natale, ho molto da fare, e non mi sento in stato di grazia, lasciatelo qui e tornate nel giorno della festa del santo”, disse il frate che vedendo quel magnifico panettone fu invaso da uno dei sette vizi capitali, la “gola”. E avvenne quel che non doveva avvenire, il panettone fu mangiato da frate Desiderio che fu subito dispiaciuto e in preda al rimorso tanto che San Biagio ritenendo la cosa di sua competenza gli fece trovare lo stesso giorno sull’inginocchiatoio un minuscolo panettoncino. Il frate si stupì per quella comparsa e ancora di più quando il panettone aumentava di volume giorno dopo giorno, finché al 3 di febbraio festa di S. Biagio si stentava a sollevarlo. Comprese allora il buon frate il significato del prodigio. “San Biagio siate benedetto che mi offrite il la possibilità di riparare la mia mancanza”. Il giorno di S. Biagio ecco presentarsi la donna del panettone, che non voleva credere ai propri occhi. La voce del miracolo si sparse per tutta Milano, tanto che in occasione del Natale successsivo furono centinaia i panettoni che vennero portati al frate per essere benedetti con la speranza di riaverli triplicati, ma il miracolo non si ripetè. Frate Desiderio li benedisse tutti contemporaneamente consigliando i presenti di mangiarli nel giorno di Natale ma di tenerne in serbo una fetta per il giorno di S. Biagio. Per questa leggenda tutta milanese, è usanza la mattina del 3 Febbraio giorno di S. Biagio mangiare un po’ di Panettone avanzato da Natale per proteggersi dai malanni della gola.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 7

di Fabio Fumagalli
Bentrovaa gent al nòster pontèll n. 7!
L’è el mes indoe ve parli d’ona manera de dì milanesa che la da el titol al nòster spettacol (vedi locandina). Spettacol de minga pèrd.
Va’ a ziffolà l’Aida (pron.: sifulà)
Bellissima e colorida espression (letteralment la voeur dì: “Vai a fischiare l’Aida!”) la se dis quand se voeur tirass via on quaivun dai pee. La reson de ’sta manera de dì la sta in la popolarità che la musica de l’Aida la gh’ha avuu in Italia appèna dòpo la soa prima rappresentazion a la Scala de Milan, el 8 de febrar del 1872. Giuseppe Verdi l’hann ciamaa per ben 33 vòlt sul palchscènich e la gent, subit finii el spettacol, giamò foeura del teater la ziffolava i ari pussee facil. Da allora, quand ona persòna la saveva nò ’se fà, l’era sora penser ò la spettava on quaivun ò on quaicòss, ghe vegniva natural ziffolà l’Aida, come incoeu se fa cont i canzonètt pussee famos. Sicur che el Giuseppe Verdi a la Hit Parade l’avaria strasciaa tutti, anca come botteghin. Pensee che a la prima assoluta de l’Aida al Cairo (24 dicember 1871) el Kedivè d’Egitto el gh’ha distaccaa on assègn de 150.000 lira de allora. Disèmm on 500mila euro d’incoeu!
Ve spettom el 8 e ‘l 16 de febrar. La sarà l’occasion per passà dò or in allegria cont i nòster scenètt e tanta musica meneghina. Podarii trovà anca i nòster famosissim tazz de collezionà (vann ben anca come pòrtapenn, come pòrtafior ò per fà on penser a on amis/a) con sù stampaa i provèrbi e i maner de dì milanes.
Naturalment andii avanti a scriom a l’indirizz sòtta riportaa e chi el gh’ha i sòcial el pò trovamm su Facebook, Instagram e Youtube: “Scuola di milanese”. Bon Febrar a tucc e….. s’ciao.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese



LEGGENDE E STORIE MILANESI. I TRII DI DE LA MERLA 29, 30, 31 GENNAIO

di Giorgio Righetti
Or sono cento e cento anni, capito a Milano che i tre ultimi giorni di Gennaio fossero tanto freddi che la gente non usciva più di casa, la neve aveva steso un candido tappeto su tutte le strade. Anche sui tetti il bianco tappeto si era steso come una coltre, solamente i fumaioli dei camini con le loro fumate nere rompevano la monotonia della bianca distesa. Il freddo e la neve erano nemici degli uccellini, che per non morire si erano rifugiati nelle fenditure dei muri delle case. Ma una merla imprevidente si era attardata e quando arrivò con i suoi pulcini alla dimora dell’uomo le fenditure delle case erano tutte occupate. La merla non si scoraggiò e incitando i pulcini ad alzarsi in volo li portò vicino a un comignolo di un camino acceso, dove la merla e i suoi pulcini protetti da quel tepore riuscirono a sopravvivere al terribile freddo. Tre giorni passarono, furono tre giorni di neve e freddo, erano gli ultimi giorni di gennaio. Finalmente un pallido sole al primo di febbraio si lasciò intravedere nel grigiore del cielo. Erano bianchi i merli ai tempi di questa storia, tutti bianchi con il becco giallo, ma passò molto fumo sulle loro penne e le piume bianchissime della merla e dei suoi pulcini divennero nere, nere come la fuliggine che saliva dal fumo che veniva dal camino e che teneva tanto caldo, solo il becco era rimasto giallo, e da allora di merli bianchi non ne nacquero più. E ancor oggi per ricordare la trasformazione subita da questi uccelli, gli ultimi tre giorni di gennaio vengono chiamati a Milano: “l trii di de la merla”. Racconta una leggenda che un tempo Gennaio aveva ventotto giorni, durante una partita ai dadi con Febbraio lo ridusse sul lastrico, non sapendo come pagare i debiti, Febbraio offrì i primi tre giorni del suo mese, così Febbraio restò con ventotto giorni. Fin dall’antichità questi tre giorni considerati i più freddi dell’anno vennero chiamati a Milano: “I trii di della Merla”.
I CANTI DELLA MERLA. Quella dei trii dì della Merla 29-30-31 gennaio è la più cara e comune delle leggende, ma molti anni fa un giornalista ne raccolse un’altra più drammatica e più vicina alla realtà eccola:
Sulle opposte sponde del Po’ vivevano due famiglie dal nome Merlo. In una famiglia abitava, un uomo forte e giovane, chiamato il Capitano, perché in mancanza del ponte traghettava i viandanti da una sponda all’altra con un’imbarcazione, sulla sponda opposta, abitava una bella e graziosissima giovane, se ne innamorò di lei Capitan Merlo e volle sposarla. Le nozze vennero fissate per la fine di gennaio, furono fatti grandi preparativi perché Capiran Merlo voleva accogliere degnamente la sposa nella sua bella casa rinnovata, preparata per lei. Quell’inverno era terribilmente rigido, il fiume era sostituito da una alta crosta di ghiaccio, su cui si poteva passare anche con i carri. Molto festeggiati furono gli sposi in quegli ultimi tre giorni di gennaio, nell’ultimo di questi Capitan Merlo volle portare la sposa al di là del fiume nella bella casa preparata per lei, si avviarono gli sposi sulla crosta di ghiaccio, li seguivano un corteo di parenti e amici con canti e balli. Ma a un tratto delle grida, un tonfo, il ghiaccio spaccato aveva inghiottito la sposa e si era subito rinchiuso. Tutte le ricerche risultarono vane la sposa non venne più trovata, Capitan Merlo tornò solo alla sua casa e non volle più traghettare, passava le giornate desolato a guardare le acque del fiume. Gli ultimi giorni di gennaio 29 – 30 – 31, rimasero famosi come: “I TRI DÌ DEL MERLO” il popolo li cambiò poi in “I TRII DÌ DELLA MERLA”… forse per ricordare la sposa scomparsa (la Merla), per la quale la felicità durò solo quei tre ultimi giorni di gennaio. E l’anniversario di quel dramma 29-30-31 gennaio divenne una sagra, con balli danze frittelle tipiche e vin brûlé per ben tre giorni, durante i quali le ragazze da marito si trovano sulle rive del Po a ballare e cantare una canzone propiziatoria che dice:
“E DI SERA E DI MATTINA
LA SUA MERLA POVERINA
PIANGE IL MERLO E PIANGERÀ”.

IL DISCORSO ALLA CITTÀ

di Alessandro Bocci
Le parole rivolte alla città di Milano, e che in tanti aspetti richiamano narrazioni svolte dal
cardinale Martini, dall’arcivescovo Delpini contengono innumerevoli spunti di riflessione.
L’arcivescovo sostiene che, sopraffatte dalla quotidianità, le persone rischiano di perdere di
vista e di non riconoscere ciò che è davvero importante. Tutto ciò si traduce in una
stanchezza che va intesa non come un invito al disimpegno o al disinteresse verso ciò che ci
circonda, ma piuttosto come una sollecitazione a liberarsi della frenesia quotidiana per
lasciare affiorare ciò che è davvero importante e significativo. Nella tradizione biblica il
riposo è anche occasione per ridefinire le priorità.
L’arcivescovo dice che la gente è stanca di una vita appiattita, dove i rapporti sono ridotti a
esperimenti precari. La gente è stanca di attività lavorative che impongono orari e
spostamenti esasperanti. La gente è stanca degli incidenti sul lavoro e di giovani che non
riescono a trovare un’occupazione dignitosa. La gente non è stanca della famiglia, che è il
bene più importante della società. La gente è stanca di servizi pubblici che impongono di
ricorrere ai privati e di cronache giornalistiche che ingigantiscono il male e ignorano il bene.
La gente è stanca di case lasciate vuote e che potrebbero ospitare persone ed è stanca di
case occupate sottratte a chi ne avrebbe diritto. La gente è stanca della guerra e delle
ragioni addotte per giustificarla. Occorre educare alla pace e ciò richiede un impegno
costante per estirpare le radici dell’odio e della violenza.
L’arcivescovo ci dice anche che chi si è arricchito grazie alla propria intraprendenza è in
debito verso i poveri: la ricchezza è infatti una responsabilità sociale e il profitto non può
essere inteso solo come un dividendo per gli investitori.
Intontiti dai ragionamenti vuoti e fatui che i mass media ci propongono quotidianamente,
avevamo bisogno di parole così forti, importanti e significative. Sentivamo la mancanza di
qualcosa che scuotesse le nostre coscienze. La chiesa di Milano e l’arcivescovo Delpini lo
hanno fatto e, per questo, non possiamo che ringraziare.

IL 27 GENNAIO 1901 MORIVA GIUSEPPE VERDI

di Giorgio Righetti
Il grande maestro si era sentito male la mattina del 21 gennaio mentre si abbottonava il panciotto nella sua stanza al Gran Hotel et de Milan in via Manzoni 108. Qualche giorno prima di quel fatale 27 gennaio Giuseppe Verdi aveva scritto: “Ho paura del freddo! Sono ferocemente attaccato sulla mia sedia e non mi muovo”. Ormai in agonia, davanti all’Hotel et de Milan sua residenza, il Comune aveva fatto stendere della paglia per attenuare il rumore del traffico ma inutilmente, Verdi non sopravvisse. Giuseppe Verdi, aveva lasciato scritto: “Ordino che i miei funerali siano modestissimi e si facciano allo spuntar del giorno od all’Ave Maria di sera, senza canti e suoni, basteranno due preti, due candele una Croce”. Verdi non era mai stato amico dei preti, fu un agnostico convinto e anticlericale, eppure aveva chiesto che due sacerdoti accompagnassero la sua bara e così fu. Milano si era alzata all’alba per seguire nel suo ultimo viaggio l’uomo tanto amato. Nella fredda e nebbiosa mattina del 30 gennaio alle 6.30, un carro funebre di seconda classe si mosse dal Grand Hotel et de Milan. Ai lati del feretro Gaetano Negri, il pittore Mancini, Giulio Ricordi, i fratelli Boito. Tutta la via Manzoni, i balconi e le finestre del percorso fino al Cimitero Monumentale erano parati a lutto. Nei viali la gente si era arrampicata sugli alberi per vedere passare il feretro. Durante i funerali, in un silenzio agghiacciante, si elevava il coro del “Nabucco” diretto da Arturo Toscanini, un sussurro che diventava potenza. Un testimone del tempo scriveva: “Piangevom tucc come fioeu, tucc ghavevom qualcosa in gola, come un gnocch che l’andava nè su nè gio”. Alle otto e mezzo la bara veniva calata nella fossa accanto a quella di Giuseppina Strepponi. Giuseppe Verdi era arrivato.
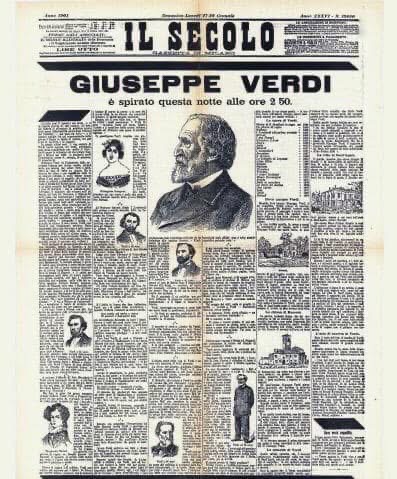
FACCIAMO UNA STRAGE?
INTERVISTA ALL’AVVOCATO FEDERICO SINICATO

a cura di Luigi Filipetto
Incontro nel quartiere milanese del Suffragio l’avvocato Sinicato carico di due borsoni della spesa. Accetta volentieri di parlare delle stragi di Piazza Fontana (Milano 12.12.1969) e di Piazza della Loggia (Brescia 28.54.1974). È presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime di Milano. È anche seriamente impegnato a tenere viva la memoria di quei fatti tragici. Anche dopo il 12 dicembre moltiplica le iniziative sulla strage di piazza Fontana.
Si parla di stragi, ma come nascono le dinamiche di questi crimini?
Sono passati 55 anni da quel 12 dicembre del ‘69. L’Italia da allora è cambiata molto. Però quello che è
successo nella Banca nazionale dell’agricoltura rimane un punto nodale della storia italiana. Prima c’erano stati grandi movimenti operai e studenteschi che avevano portato a importanti riforme che ancora oggi segnano la storia del nostro paese. Le riforme del diritto di famiglia, del divorzio, dei diritti delle donne, lo statuto dei lavoratori che viene approvato proprio quella mattina in Parlamento per la prima volta, la famosa legge Codignola che riconosceva a tutti i ragazzi di ogni condizione la possibilità di iscriversi all’università.
Poi scoppia la bomba. Il decennio che segue, sarà un decennio molto più cupo: quello del terrorismo,
della strage di via Fatebenefratelli nel ’73, di piazza della Loggia nel ’74, l’Italicus a Bologna dello stesso
anno. Un decennio terribile. Perché? Perché coloro che hanno voluto la strage di piazza Fontana e che
avevano già costellato Milano di attentati in quei giorni, pensiamo alla Fiera, al Tribunale, ai treni
nell’agosto del ’69, agli attentati anche nel Veneto, agli attentati di Roma. Quelle persone erano persone che appartenevano all’estrema destra di Ordine Nuovo. Le sentenze, ormai, hanno scritto a chiare lettere che sono le stesse persone che hanno compiuto anche le stragi degli anni seguenti. La strage di Bologna è opera dei NAR che sono i nipoti degli ordinovisti che hanno compiuto le stragi degli anni ’70. Hanno agito sotto la guida di Pino Rauti. Venivano dal grembo del Movimento Sociale Italiano, radicalizzando la visione nazista della società: il superuomo con la lettura dei filosofi nazisti. Il mito della Fenice, non a caso il nome di un’organizzazione parallela a Ordine Nuovo. C’era l’idea che bisognava distruggere tutto per costruire una società nuova.
I personaggi di spicco sono noti, non solo Freda e Ventura, e universalmente riconosciuti come
responsabili della strage di piazza Fontana. Il nome di Carlo Maria Maggi il capo indiscusso di Ordine
Nuovo, condannato all’ergastolo per la strage di Brescia compiuta più o meno con le medesime modalità con cui fu compiuta la strage di piazza Fontana. E poi il nome di Carlo Digilio l’armiere del gruppo. Abbiamo quattro nomi certi a cui attribuire quelle diciassette vittime, anzi diciotto includendo anche Pino Pinelli che muore, quale che sia la causa della sua morte muore però nel momento in cui viene accusato ingiustamente di avere partecipato alla strage.
Ancora oggi vediamo i segni della strage di quell’anno. Una delle ragioni per cui appare chiara
l’inconciliabilità tra l’estrema destra e la democrazia italiana nasce proprio dal fatto che non hanno mai
voluto fare i conti con il loro passato. Parliamo naturalmente non del fascismo del Ventennio, ma del
fascismo più recente che pesa sulla società odierna. Sono crimini addebitabili a persone fisiche ma che
nascono in un contesto, in un momento storico e sociale che li favorisce. Un momento in cui dominava
l’idea di dover a ogni costo fermare i movimenti democratici e comunque lo sviluppo del Paese che andava verso un’apertura, verso una maggiore democrazia, verso i diritti per tutti. Si voleva fermare tutto questo perché era visto come un pericolo comunista. L’intento era anche quello di voler tenere sotto controllo il governo italiano che era un governo a guida democristiana.
Ci sono anche delle scelte specifiche. Nel 1965 Viene tenuto a Roma un convegno organizzato dalle
forze armate italiane i cui relatori sono Pino Rauti e Guido Giannettini. Gli storici riconducono a questo
convegno la scelta di mettere in campo la guerra non convenzionale, cioè il terrorismo, come arma possibile per mantenere il controllo del Paese, costringendo il governo ad alzare il livello di reazione. Proprio Guido Giannettini è l’uomo che il Servizi segreti mettono a fianco di Freda e Ventura. I Servizi operano anche dopo i fatti avvenuti e su questo punto sono chiarissime le sentenze definitive che condanneranno ufficiali e generali per avere ostacolato le indagini. Quindi il lavoro sporco viene fatto dai Servizi segreti. Chiamati così perché fanno servizi in segreto che però non potrebbero essere autorizzati da nessun governo perché si tratta di operazioni coperte a favore del potere costituito in quel momento, che non è necessariamente lo stato italiano democratico. È il gruppo di potere che comandava in quel momento e che gestiva l’intero arco della società, o almeno i settori più importanti della Democrazia cristiana che come sappiamo era un partito molto ampio e composito.
Queste sono le dinamiche che stavano dietro alle stragi, che però ci sono anche oggi. Pensiamo alle
stragi del ’92 o ’93, via Palestro, via dei Georgofili, che rivelano il ruolo di alcuni personaggi dei Servizi,
alcune frange della mafia, e dei movimenti della estrema destra che si rifanno vivi in quel momento. Anche su questi fatti parlano le sentenze.
La gente come vive la memoria di quei fatti e come la tua opera di sensibilizzazione si sviluppa ora?
Mantenere la memoria di questi fatti è fondamentale per capire il nostro Paese. Il periodo storico di quei
decenni non è ancora storia ufficiale, non è ancora scritto nei libri di testo, ma non è neanche più cronaca
perché è già fuori dalla cronaca dei giornali. Siamo in una specie di limbo.
È invece importante che questo periodo venga capito e raccontato. Quello che fanno i famigliari
delle vittime, l’associazione che in questo momento rappresento, è proprio quello di portare in ogni ambito, nelle scuole e nei dibattiti questo pezzo di storia italiana, proprio per sollecitare approfondimenti, riflessioni, dibattiti, anche critiche se servono a confrontarsi su questi temi ma non lasciarli cadere nell’oblio. Cosa che si ripercuoterebbe anche sulla nostra capacità di vivere il presente. Si rischia di diventare indifferenti a tutto, di rinchiudersi nel proprio particolare e magari non si va neanche a votare. Questo impoverisce anche la nostra democrazia.
Per quanto riguarda le scuole noi andiamo nei licei e raccontiamo quei fatti. Abbiamo una specie di
format, un video che dura una mezz’ora, con immagini di repertorio evocative e suggestive e raccontiamo anche le esperienze personali perché i famigliari delle vittime hanno un portato umano personale straordinario. Ragazze e ragazzi allora di 17/18 anni che erano stati chiamati a riconoscere i corpi martoriati dei loro genitori, che hanno vissuto momenti profondamente drammatici e che riescono a trasmettere le loro emozioni ai ragazzi dei licei. Poi si instaura anche un dialogo con domande da parte dei ragazzi. Poi i ragazzi a scuola possono fare dei lavori con la guida dei docenti. È così che si semina conoscenza e speriamo anche educazione civica se così si può dire.
C’è anche un altro campo che a me preme molto, l’aspetto artistico. Una mostra di fotografie
dedicate alle vittime di piazza Fontana – si chiama 17grafi+1 – , una mostra che gira per tutta l’Italia. Un CD di canzoni, curato da Renato Franchi, che raccoglie 17 canzoni dedicate alle vittime compreso Pinelli – si chiama 17graffi –, scritte da vari cantautori. Sono canzoni molto belle.
Poi recentemente il musicologo Carlo Bernieri ha trovato per caso nel Conservatorio di Reggio
Emilia lo spartito di una canzone che si chiama Piazza Fontana del dolor, si trova su YouTube. Composta da dei musicisti di strada che si chiamavano I Cavallini che proprio negli anni ’70 giravano per le piazze della Lombardia. Questo musicologo ha avuto la bellissima idea di farla reincidere, con cantanti nuovi.
Con una veste nuova è ora cantata da una cantante di strada che si chiama Chicca Smile. Quest’anno il
Comune di Milano è stato d’accordo con noi nel proiettare questa videoclip della durata di cinque minuti in Piazzetta Reale accanto al Duomo, a cento metri da piazza Fontana. La proiezione, inframmezzata anche da immagini di repertorio, è come un evento tipico degli artisti di strada che cantavano la cronaca quotidiana – anche la canzone di Pinelli è nata proprio così – e racconta in questo modo la tragedia di piazza Fontana ai passanti e ai turisti che hanno la ventura di passare di lì.


SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 6
2 de Febrar “La Candelòra”

di Fabio Fumagalli
S’ciao bèlla gent. ‘Sto mes hoo pensaa de contentaa tucc quèi che ghe piasen i poesii. (Vi ricordo che per le vostre richieste milanesi su questo Giornale potete scrivetemi all’indirizzo mail sotto riportato). Se tratta de ona poesia de l’amis Renato Colombo. De part ve mètti la traduzion per quèi che gh’hann di dubbi.
La Candelòra del duu de Febrar
l’è la Presentazion de Gesù
al Templi a fass cognoss in su l’altar
a fagh capì ch’ el vegniva da lassù
e che Lù tutt el mond l’avaria cambiaa
per quèst al Maester el s’è presentaa.
Ma giamò la gh’era la Candelòra
fèsta che se pèrd in la nòtt di temp
quand de la civiltà serom a l’auròra
i nòster giornad eren scandii dal temp
la vita regolada di stagion
e ai Dei ghe se faseven i orazion.
La fin de l’inverna se festeggiava
cont el nòmm Imbòle e celtega l’era
con el sô che pian pian ‘l rivava
e gran ball per la noeuva primavera
anca i ebrei faseven ‘na gran fèsta
con ‘na scusa che l’era semper quèsta.
La Candelora del due di Febbraio
è la Presentazione di Gesù
al Tempio a farsi conoscere sull’altare
a farci capire che veniva da lassù
e che Lui tutto il mondo avrebbe cambiato
per questo al Maestro si è presentato.
Ma la Candelora c’era già
festa che si perde nella notte dei tempi
quando eravamo all’aurora della civiltà
le nostre giornate erano scandite dal tempo
la vita regolata dalle stagioni
e agli Dei si facevano le orazioni.
Si festeggiava la fine dell’inverno
con il nome Imbole e celtica era
con il sole che pian piano arrivava
e grandi balli per la nuova primavera
anche gli ebrei facevano una gran festa
con una scusa che era sempre questa.
Prima l’era el quattòrdes febbrar
quaranta dì dòpo l’Epifania
missa poeu al duu per on particolar
quaranta dì dal Natal e così sia
la ricòrda l’ebraica Lucernari
‘me del rèst la romana Lupercali.
La somiglianza che gh’hann tucc ‘sti fèst
l’è che se piazzaven di gran candel
perchè ‘l fil conduttor l’è pròppi quèst
sia per el Cristian che l’infedel
d’altrònde i Luminer se festeggiava
cont el ciar primaveril ch’ el rivava.
Anca se a Milan se dis la zerioeula,
ma l’è on tèrmin ch’ el se dopera pù
come scrivom scòla al pòst de scoeula
el milanes el cambia deperlù,
ma che sia fèsta celtega ò cristiana
mì la faria durà ‘na settimana.
On dì dedicaa a tutt i religion
perchè mì voeur fagh n’intòrt a nissun.
Prima era il quattordici febbraio
quaranta giorni dopo l’Epifania
spostata poi al due per un particolare
quaranta giorni dal Natale e così sia
ricorda l’ebraico Lucernario
come del resto la romana Lupercali.
La somiglianza che hanno tutte queste feste
è che si mettevano delle grandi candele
perché il filo conduttore è proprio questo
sia per il Cristiano che per l’infedele
d’altronde le luci si festeggiavano
con il chiaro primaverile che arrivava.
Anche se a Milano si chiama la zerioeula,
ma una parola che non si usa più
come scriviamo scòla anziché scoeula
il milanese cambia da solo,
ma che sia una festa celtica o cristiana
io la farei durare una settimana.
On giorno dedicato a tutte le religioni
perché non voglio far torto a nessuno.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese


I SACCHETTARI

di Aurora Marella
Non so perché ma in qualche modo sono arrivata alla conclusione che le più belle storie
d’amore spesso nascono da una delusione, da un desiderio di riscatto o da un profondo
senso di gratitudine. Comunque vadano o siano andate le cose, le storie d’amore nascono
da altre storie d’amore. Quindi, posso affermare di aver dimostrato la tesi che dall’amore
nasce amore. E ancora una volta, le mie personali cacce al tesoro nel mio capoluogo di
Regione mi hanno portato a riconoscere questa verità tanto grande quanto essenziale.
L’aspetto imprevedibile di questa tesi è costituito dal percorso che l’amore fa, da dove
passa e attraverso chi e con quali linguaggi si esprime. Di certo c’è che tutte le storie
d’amore hanno l’amore come partenza e l’amore come fine, inteso come scopo e come
chiusura del cerchio. E rinnovo della spirale solidale.
Nel mondo, soprattutto in quello più vicino a noi, quello inaspettato, ormai visto così tante
volte che non lo si vede più, ci sono un sacco di circoli virtuosi che spesso non si riescono
ad individuare nella frenesia del via vai di gente e di tante vetrine, soprattutto di questi
tempi festaioli.
Ancora una volta la mia partecipazione a questo Giornale mi ha consentito di andare alla
ricerca di un posto nuovo del cuore dove le mani, i piedi, i progetti orchestrano nuovi
percorsi di solidarietà.
Durante questo mese dell’ultimo terzo di autunno, nelle mie ricerche, mi sono imbattuta in
un gruppo che si occupa di distribuire sacchetti. Infatti si è dato il nome de I Sacchettari.
Circa sei anni fa nasceva l’idea dei Sacchettari, idea che si è sviluppata con l’intento di
portare un aiuto concreto a chi vive in strada, durante tutto l’anno.
I Sacchettari, appunto, portano dei sacchetti contenenti indumenti per chi, per scelta o per
mancanza di altre possibilità, si trova a condividere il marciapiede con i passanti, giorno e
notte.
I Sacchettari si trovano una volta alla settimana dal 2018. Escono nella bella Milano del
centro e portano il necessario a chi non ce l’ha. Per lo più indumenti, non cibo e non soldi.
Nemmeno la pandemia li ha fermati: non potendo uscire sul territorio in quel periodo, i
Sacchettari si trovavano online per rafforzare l’unione e gli intenti tra loro e l’energia non si
è mai spenta.
I Sacchettari sono diventati un’Associazione da pochissimi giorni ma, fino a questa nuova
definizione del gruppo, sono stati appoggiati e sostenuti da altre Associazioni. Ora che
sono un’Associazione potranno anche partecipare ai bandi del comune per avere dei fondi
e una sede propria dove depositare e smistare le donazioni di vestiti, abiti e coperte.
Il lavoro dei Sacchettari è del tutto volontario e si basa anche su autofinanziamento.
Il principale mezzo di comunicazione dei Sacchettari è il linguaggio della fiducia che
cercano di creare e rafforzare tra loro e le persone che vivono in strada.
Mi racconta una di loro che non è facile guadagnarsi la fiducia di queste persone perché
spesso si chiudono e sono diffidenti ma poi, quando si aprono, si scoprono le loro storie e
il loro mondo e tutto il percorso che li ha condotti fino a quel marciapiede, a quell’angolo, a
quel porticato.
Le persone che vivono in strada rivelano il loro nome e parlano di sé e narrano le storie
ruvide di quelle vite ai margini, storie che finiscono male, qualche volta, dove vince una
salute che perde le battaglie con gli anticorpi, oppure delle storie tristi dove si arriva a
vivere per strada perché qualcosa ti ha portato via tutto, o delle storie a lieto fine dove c’è
un riscatto, si ritrovano il lavoro e la casa.
E queste storie che mi sono state raccontate hanno un nome proprio e si chiamano Victor,
Pacifico e Sirio.
Voglio dare un nome a queste storie, perché sono le Storie delle loro Vite e sottolineare
anch’io, per come posso, la dignità e la fierezza e a volte anche la rassegnazione di quei
volti che, attraverso il racconto ricevuto da una sacchettara, si sono disegnati nella mia
mente in modo nitido e preciso.
La forza del gruppo dei Sacchettari è il passaparola e la collaborazione di persone comuni
dove ognuno mette una goccia in questo mare che non diventa più un mare di solitudine
ma un mare di mani unite. Anche una piccola differenza diventa un enorme atto di
solidarietà. Nel momento in cui ci diamo la possibilità di aprire lo sguardo, iniziamo a dare
un nome proprio alle Storie e iniziamo ad agire in modo più concreto, a lottare contro
l’indifferenza e la fretta con cui spesso di descrive il centro di Milano. Rallentiamo il passo
e ascoltiamo.
Questa Milano un po’ defilata è la Milano che mi piace e la Milano che dovrebbe fare più
rumore.
E mi sento orgogliosa di poter fare un po’ di rumore anch’io, così, con questo contributo.
Un grazie a Rosy, la sacchettara che ha dedicato il proprio tempo a farmi conoscere
questa realtà solidale.
I Sacchettari si trovano sui social e soprattutto ogni giovedì sera in centro a Milano.

LA SCHIAVITÙ È UNO STATO DI GUERRA. IL CAPITANO BROWN

di Giorgio Righetti
Abolizionista e fervente sostenitore dell’insurrezione armata come unica via per rovesciare la schiavitù radicata nel Sud degli Stati Uniti, John Brown inflessibile nelle sue convinzioni antischiaviste è stata una figura controversa nella Storia americana. Contrario all’atteggiamento degli Stati del Nord, che ritenevano di dover combattere la schiavitù solo con mezzi politici e ideologici, di sua iniziativa John Brown portò a termine diversi attacchi armati di guerriglia contro gli Stati schiavisti, allo scopo di tenere costantemente in allarme l’avversario infliggendogli continue perdite. L’ultima azione di guerriglia avvenne il 16 Ottobre 1859, quando John Brown attaccò con i suoi 19 fedeli, tentando di provocare una rivolta di schiavi neri l’arsenale di Harper’s Ferry nella Vecchia Virginia ma l’azione fallì e Brown fu catturato e molti dei suoi uomini uccisi, giudicato colpevole di cospirazione, omicidio e insurrezione armata fu condannato a morte per impiccagione. Così nella incerta luce dell’alba del 2 Dicembre 1859, arrivava per John Brown l’ora suprema, fu fatto salire su un carro che portava pronta la sua bara, il vecchio Capitano andava incontro alla morte con severità e austerità, i sudisti che lo circondavano avevano imparato a concepire per il nobile contegno dell’avversario un rispetto profondo, millecinquecento uomini della milizia in stato di guerra circondavano il patibolo dove il Capitano del Kansas si apprestava ad affrontare impavido la morte. Le sue ultime parole furono:
“Io sto per seguire la strada che Dio aveva segnato per me. Io John Brown sono ora del tutto certo che i delitti di questo colpevole paese non saranno mai espiati se non con il sangue. Perdonali o Signore, come io li perdono perché non sanno quello che si fanno”.
Le sue parole furono profetiche l’11 Aprile 1861 scoppiava la Guerra civile americana. A John Brown fu dedicata una ballata popolare “John Brown body” che divenne l’inno di battaglia dei nordisti durante la Guerra di secessione e che avrebbe scandito il passo a innumerevoli battaglioni marcianti alla sconfitta del Sud.
La Guerra civile terminata il 14 Aprile 1865 era costata oltre 600.000 morti. La sconfitta degli Stati del Sud e la scomparsa della schiavitù posero le premesse di una ricostruzione della nazione americana sulla base della democrazia, repubblica e federalismo.

“JEANS GENERATION O VOLARE VIA DALL’URSS”

di Viktoriia Lapa
“Jeans Generation o Volare via dall’URSS”, il primo romanzo di uno degli autori più rinomati della Georgia, Dato Turashvili, è stato pubblicato per la prima volta in Georgia nel 1988. Il romanzo si basa su un evento avvincente e tragico del 1983, in cui Gega Kobakhidze, un giovane attore, insieme a sette amici, dirottò un aereo diretto da Tbilisi a Leningrado. Desiderando disperatamente fuggire dall’URSS per raggiungere la Turchia, fallirono e furono incarcerati, e molti di loro morirono.
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la Georgia ha ottenuto l’indipendenza, ma non è riuscita a liberarsi dalla minaccia russa. Nel 2008, la Russia ha condotto una guerra aggressiva contro la Georgia, occupando il 20% del suo territorio—un’occupazione che persiste ancora oggi. La Georgia è stata costretta ad accettare un accordo di pace in sei punti con la Russia, che ha consentito alle truppe russe di rimanere nei territori occupati e ha permesso alla Russia di esercitare influenza tramite canali politici. L’Unione Europea, preoccupata per una possibile “escalation”, decise di non imporre sanzioni economiche contro la Russia nel 2008. All’epoca, un membro lituano del Parlamento Europeo, Vytautas Landsbergis, avvertì: “Non si tratta solo della Georgia, si tratta dell’Europa. …Chi sarà il prossimo? …Il prossimo è l’Ucraina.” Molti europei lo considerarono allarmista, ma la Russia invase realmente l’Ucraina nel 2014 e proseguì con un’aggressione su vasta scala nel 2022.
Tornando al romanzo di Turashvili: questo novembre 2024, il Liberty Theatre a Tbilisi metterà in scena uno spettacolo basato su “Jeans Generation.” Qualcuno potrebbe pensare che un romanzo del 1988 intitolato “Fuga dall’URSS” possa sembrare obsoleto, ma tutti i biglietti per le quattro rappresentazioni sono già esauriti. Perché? Per la popolazione georgiana, la lotta per la libertà dall’influenza russa, che ancora riflette tattiche dell’era sovietica, è di estrema attualità.
Attualmente, i georgiani si trovano a un bivio. Devono decidere se essere governati dal partito filo-russo “Sogno Georgiano” o dai partiti di opposizione pro-europei. Le elezioni parlamentari si sono svolte il 27 ottobre 2024, ma sembrano essere state segnate da accuse di frode. I risultati ufficiali riportano una vittoria del 54% per il partito filo-russo “Sogno Georgiano”, ma sono emerse numerose segnalazioni di brogli, interferenze e irregolarità ai seggi elettorali. La Presidente della Georgia ha respinto i risultati elettorali, insistendo che la volontà del popolo è stata rubata. Lunedì 28 ottobre, i cittadini si sono riuniti in protesta a Tbilisi, sventolando bandiere europee, ucraine e georgiane per chiedere giustizia. I leader dell’opposizione e la Presidente della Georgia chiedono nuove elezioni libere da interferenze.
Il futuro è incerto, ma una cosa è certa: i georgiani sono fermi nella loro scelta per l’Europa. Vogliono “volare via” dalla Russia e unirsi all’Unione Europea. Per loro, questa scelta è molto più che simbolica; rappresenta un impegno per la sicurezza, la prosperità e i valori democratici. La storia ha dimostrato che quando la Russia interviene—come ha fatto in Georgia nel 2008 e in Ucraina nel 2014—non porta né prosperità, né valori democratici, né sicurezza. Al contrario, impone occupazione, terrore, violazioni dei diritti umani e povertà. L’Unione Europea deve riconoscere l’importanza strategica di paesi come la Georgia e sostenere le sue aspirazioni europee; lasciare la Georgia sotto l’influenza russa potrebbe nuovamente minacciare la stabilità europea.
L’eredità di “Fuga dall’URSS” torna a colpire…
“Volare via dall’URSS” è stato pubblicato in Italia nel 2013.

DA SIMONE DE BEAUVOIR AD OGGI: UNO SGUARDO SULL’ESSERE DONNA

di Melissa Idonia
È il 1949. A Parigi viene pubblicato per la prima volta Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, considerato la prima opera sistematica – per forma e contenuto – del pensiero femminista contemporaneo. La teoria filosofica alla base del testo è più o meno la seguente: il tentativo di affermazione di ogni soggetto richiede la presenza di un altro che lo nega e lo limita. Alle sue origini il patriarcato ha individuato questa realtà altra nella donna in quanto «desiderato intermediario tra la natura straniera all’uomo e il suo simile che gli è troppo identico». In tal modo la donna ha assunto i connotati di un Altro assoluto, ovvero di un Altro senza reciprocità e definito solo per negazione. Viene così a delinearsi l’immagina del “secondo sesso” coincidente con un genere in subordine, addomesticato e neutralizzato per permettere al “potere virile di affermarsi”. L’origine culturale di questo processo di subordinazione femminile viene individuata -per quanto riguarda l’Occidente- nella società romana prima, nel cristianesimo poi, che fanno coincidere l’immagine della donna, in particolare della sua carnalità, con quella della colpa e del peccato. Per tale ragione le sacerdotesse antiche, come la maggior parte delle sante cristiane, vengono presentate come vergini; la verginità ha un ruolo essenzialmente privativo che permette loro di asservirsi agli uomini. Così la vergine Maria può affermare “Sono la serva del Signore”, riconoscendo la propria inferiorità come un privilegio.
L’idea della filosofa non piace in Italia dove Arnoldo Mondadori rifiuta di pubblicare il libro. Non piace nemmeno al Vaticano che nel 1956 lo mette nell’Indice dei libri proibiti.
Ma gli anni Sessanta sono alle porte e con essi le organizzazioni femminili di massa in cui il testo inizia a circolare, spingendo così la sua prima uscita che vede la luce nel 1961 a opera della casa editrice il Saggiatore.
Al di là delle critiche che, soprattutto negli anni Settanta, sono state sollevate alla teoria di de Beauvoir e legate prevalentemente al perseguimento di un’idea di parità dei sessi attraverso l’adeguamento al modello maschile, la domanda che oggi possiamo porci è: cosa è rimasto di questo testo?
L’idea del corpo femminile come elemento che porta con sé qualcosa di peccaminoso, perché associato al vizio, è oggi ancora molto marcata. Interessante al riguardo è la tendenza, che fatica a scomparire, ad associare la bellezza estetica delle donne all’ignoranza o alla stupidità, oppure il perdurare di sostantivi ed espressioni che declinati al femminile assumono sfumature di significato peggiorative (cortigiano/cortigiana, zoccolo/zoccola, gatto morto/gatta morta, ecc.). In quest’ultimo caso appare evidente come il registro simbolico veicoli significati che hanno importanti conseguenze di carattere sociale limitando, in alcuni contesti, la libertà di espressione individuale di ragazze e donne.
Allo stesso tempo però sembra esistere un implicito vantaggio nell’assoggettamento femminile. Manon Garcia nel testo Sottomessa non si nasce, lo si diventa elabora un’interessante analisi del rapporto costi/benefici della sottomissione partendo proprio dal testo di Beauvoir. L’idea di base è che tutti gli individui nascono assoggettati a un altro da cui dipendono e questa condizione richiede un’azione soggettiva faticosa, ma imprescindibile, per uscire dalla propria fatticità. In tal senso la sottomissione femminile non sarebbe un movimento attivo di rinuncia, ma assenza di movimento – passività – giustificata dal rischio a cui il soggetto va incontro quando insegue la propria libertà, indissociabile dall’angoscia esistenziale. La libertà è dunque un’azione di conquista che porta con sé un costo tanto maggiore quanto più incerto è il successo dell’impresa. Nel caso delle donne, la stretta interconnessione tra fattori individuali e struttura sociale renderebbe questa azione soggettiva particolarmente complessa. In primo luogo perché gli individui adattano le proprie esigenze alla situazione in cui si trovano. Al riguardo, sulla scia dell’economista e filosofo Amartya Sen, Garcia evoca l’esempio delle donne povere dell’India rurale convinte di avere dei bisogni nutrizionali limitati rispetto a quelli dei loro figli e mariti, semplicemente perché non c’è cibo a disposizione. In secondo luogo perché l’educazione impartita alle donne fin da bambine le porterebbe a non percepire la loro condizione di oppresse; un esempio sarebbe la tendenza a servirsi della propria apparenza fisica come mezzo per acquisire potere erotico sugli uomini, condizione vissuta non come ostacolo alla propria autodeterminazione bensì come un piacere, sebbene porti con sé l’ambiguità di aver bisogno di uno sguardo esterno per esistere e apprezzare il proprio valore e la propria identità. Questa linea di analisi spiegherebbe il tacito consenso al processo di riduzione qualitativa del ruolo sociale della donna.
Alla luce di quanto esposto sembrerebbe, ancora oggi, che la situazione della donna sfugga alla possibilità di una dialettica emancipatrice per questioni complesse che oscillano tra dinamiche sociali e fattori individuali.
Simone de Beauvoir ha avuto il grande merito di aprire un varco alla consapevolezza, spianando la strada alla creazione di nuovi paradigmi e alla decostruzione di alcuni stereotipi, perseguendo il suo lavoro di emancipazione femminile fino alla morte e lasciando in eredità un principio importantissimo: l’idea che il femminismo sia una via verso la libertà, non verso il potere.

I RITARDI NEI PAGAMENTI DEI SUPPLENTI BREVI NELLA SCUOLA: UNA QUESTIONE IRRISOLTA

di Francesco Maraia
I supplenti nella scuola italiana sono da anni costretti a fare i conti con un problema ricorrente: i ritardi nei pagamenti. Nonostante il ruolo fondamentale che ricoprono nel garantire il regolare svolgimento delle lezioni in caso di assenze degli insegnanti titolari, molti di loro si trovano a dover affrontare attese interminabili prima di ricevere il compenso per il lavoro svolto.
La situazione appare particolarmente critica per i contratti a tempo determinato, quelli con una durata limitata a pochi giorni o settimane, tipici delle supplenze brevi. La causa principale dei ritardi risiede nel sistema amministrativo e burocratico che gestisce i pagamenti, il quale, anziché essere snodato e rapido, è appesantito da una complessa catena di passaggi che include la trasmissione delle pratiche dalle scuole agli uffici competenti e la registrazione dei contratti. La mancanza di personale e le difficoltà nel coordinamento tra i vari uffici pubblici sono fattori che contribuiscono a rallentare l’intero processo, portando a ritardi che, nella maggior parte dei casi, possono arrivare a durare anche diversi mesi.
I disagi economici che derivano da questi ritardi non sono solo un danno per i supplenti, ma minano la loro dignità professionale. Molti insegnanti precari, infatti, si trovano in una situazione di incertezza costante, senza sapere quando arriverà il pagamento del loro stipendio. Una condizione che, per molti, porta a dover chiedere aiuto alle proprie famiglie o, peggio, a indebitarsi con istituti di credito per far fronte alle spese quotidiane. Per coloro che provengono da altre regioni, la situazione si complica ulteriormente, poiché la precarietà del lavoro rende estremamente difficile stipulare contratti di affitto o affrontare altre spese fisse, come la gestione della casa o delle necessità familiari. I contratti di locazione, infatti, spesso richiedono una stabilità economica che i supplenti brevi, con la loro incertezza lavorativa, non possono garantire.
Ma i ritardi nei pagamenti non riguardano solo gli aspetti economici della vita dei lavoratori.
Il problema si inserisce in un contesto più ampio che lede direttamente il diritto allo studio, diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Se da un lato si parla di garantire un’istruzione di qualità, dall’altro lato non si può ignorare la difficile condizione economica dei lavoratori, in particolare dei precari.
Questa situazione, che incide direttamente sulla dignità dei lavoratori del comparto scuola, solleva una questione cruciale: uno Stato che non garantisce i diritti fondamentali dei propri lavoratori, in particolare quelli che operano nel settore pubblico, tradisce i valori di giustizia e solidarietà su cui si fonda la nostra società. La tempestività nei pagamenti non dovrebbe essere un’opzione, ma un dovere imprescindibile, così come il riconoscimento del valore del lavoro dei supplenti brevi, che rappresentano di fatto uno dei pilastri su cui poggia il sistema scolastico italiano.
Nonostante le ripetute promesse di semplificare e velocizzare le procedure burocratiche, i supplenti brevi continuano a denunciare la mancanza di soluzioni concrete. Le dichiarazioni di intenti, le riforme promesse, non sono riuscite a risolvere un problema che rimane irrisolto, continuando a penalizzare una categoria di lavoratori che si trova costantemente in una condizione di fragilità economica e professionale.
I ritardi nei pagamenti dei supplenti brevi sono una ferita aperta per la scuola italiana. Un sistema che non riesce a garantire ai propri insegnanti una remunerazione tempestiva e adeguata al lavoro svolto non solo danneggia i lavoratori, ma compromette il diritto all’istruzione e il rispetto dei diritti umani fondamentali. Nella speranza che questi lavoratori vedano garantiti i propri diritti si rende urgente l’applicazione di soluzioni concrete per risolvere questa problematica, prima che diventi un ostacolo insormontabile per il futuro della scuola e della società italiana nel suo complesso.

LA (QUASI) SCOMPARSA DEL PATRIARCATO

di Rachele Grillo
Non si è femministi solo l’8 marzo e il 25 novembre.
“Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.
Un anno fa le parole di Cristina Torre Cácares risuonavano nelle piazze italiane il 25 novembre, forti e chiare insieme al grido “Non una di meno”. La rabbia e il dolore per l’ennesimo caso di femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, la ventiduennepadovana, studentessa di ingegneria, uccisa brutalmente dall’ex fidanzato, anch’egli coetaneo e compagno di corso, Filippo Turetta. Ognuna di noi, nel leggere dei due ragazzi scomparsi nel nulla, aveva internamente compreso il tragico epilogo. Quando uscì la notizia, mi ricordo perfettamente cosa stessi facendo: ero seduta davanti la mia scrivania, con libri e dispense aperti intentaa preparare gli esami da sostenere nella sessione inverale. E pi quella sensazione di angoscia, quella stretta allo stomaco e il nodo in gola.
Giulia fu la vittima 110; dopo di lei altre 10: non fu l’ultima.
Guardando ai numeri del 2023, delle 120 donne 63 hanno perso la vita per un partner o un ex partner, in 61 di questi casi uomini, la cui maggior parte di nazionalità italiana. In questo 2024 l’Osservatorio Nazionale dei femminicidi lesbicidi e transicididell’associazione Non Una Di Meno, conta, al 22 novembre, un numero di 106 femminicidi. Storie di donne ridotte a semplici numeri. Una conta dopo l’altra. Donne a cui è stata lentamente strappata dapprima la dignità, dopo la vita da mostri sani figli del patriarcato. Come possiamo notare, seppur il brutale omicidio di Giulia abbia scosso profondamente la coscienza comune, tanto che le segnalazioni e le richieste di aiuto nei centri antiviolenza sono aumentati, i dati collettivi non sono per nulla confortanti.
Il femminicidio è infatti solo la punta dell’iceberg di un sistema, quello patriarcale, mai del tutto decostruito. Da un punto di vista giuridico, ad esempio, le donne raggiunsero un primo grado di parità nel 1975 con la legge 151 sul diritto di famiglia; e solo nel 1981, a seguito del coraggio di Franca Viola, sono stato abrogati il matrimonio riparatore e il delitto d’onore. Abbiamo aspettato fino al 1996 per vedere invece lo stupro finalmente legge.
Nonostante ciò, qualunque donna di ogni età, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza, ha una sua storia da raccontare, poiché la violenza si manifesta anche nelle forme più semplici e subdole: manipolazione, tentativi di violenza, stupri, stalking, catcalling, revenge porn.
Uomini assetati di potere, fragili nel loro ego, che sentono ildovere e il diritto di prevaricare; uomini a cui non viene insegnato ad accettare il rifiuto, che se non c’è consenso, a prescindere dalle circostanze o dal modo in cui siamo vestite, tu non puoi. Emblematica l’attuale campagna “Se io non voglio, tu non puoi” della Fondazione Una Nessuna Centomila per il 25 novembre.
Si crede che con la nuova generazione le cose cambieranno, ma i dati raccolti tra gli adolescenti sono allarmanti. Secondo l’indagine svolta sui ragazzi tra i 14 e i 21 anni, il 45% dei 14-15enni crede che la gelosia sia una dimostrazione d’amore; inoltre, geolocalizzazione, il controllo sui messaggi e sull’abbigliamento sono considerati accettabili. Il problema alla base risiede nella mancata educazione da parte sia dalle autorità scolastiche, sia dalla famiglia. A questo proposito, è bene ricordare le aberranti esternazioni da parte del padre di Turetta, il quale ha considerato sempre la gelosia e l’ossessività del figlio nei confronti della ex come “normale come sono i ragazzi a quell’età”. Ma di normale in tutto questo non c’è nulla.
La rappresentazione lineare di cosa significa essere una donna al giorno d’oggi, a mio avviso, è stata data da Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice di Barbie, nello splendido monologo che Gloria (America Ferrera) fa a Barbie stereotipo (Margot Robbie) e che vi consiglio di recuperare. O ancora, le parole della cantautriceTaylor Swift sul sessismo nell’industria musicale statunitense “A man is allowed to react, a woman can only overreact” (ndr. “Ad un uomo è permesso reagire, una donna può solo reagire in modo eccessivo”).
Mentre sarà la Fondazione Giulia Cecchettin ad andare nelle scuole al fine di sensibilizzare i giovani, mentre il nostro governo temporeggia non istituendo ore di educazione affettiva e sessuale (uno dei pochi paesi rimasti in Europa a non avere l’obbligo) o non finanziando adeguatamente i centri violenza, qualcuna non è stata assunta per l’impiego che sperava di ottenere perché un giorno vorrà avere dei figli. Eppure, ai possibili candidati uomini nessuno chiede se vogliono diventare padri. Contrariamente, un’altra desidera ardentemente abortire ed è costretta a percorrere km per trovare un medico che non sia un obiettore di coscienza. Ancora, c’è chi sta cercando di trovare il coraggio per denunciare, nella speranza che per lei le conseguenze non siano smisurate; all’opposto c’è chi l’ha già fatto ma non è stata o creduta per la minigonna che indossava o perché era ubriaca, perché non ha urlato.
Viviamo in una realtà in cui esternazioni come “Eh ma queste femministe cosa vogliono sempre!” vengono osannate e applaudite; in cui noi non dobbiamo far troppo rumore quando un salario paritario, eguaglianza, di avere gli assorbenti gratuiti, di essere credute, ascoltate, aiutate, non uccise. Aspettiamo la metropolitana e leggiamo sui cartelli slogan che portano avanti la narrativa che siamo noi a dover avere gli strumenti, noi che dobbiamo difenderci, non gli uomini a dover essere educati.
E mentre dall’altra parte del mondo un uomo bianco, ricco, privilegiato, razzista, omofobo e antiabortista è diventato per la seconda volta il Presidente della nazione più potente al mondo, a Bologna la ventiduenne Chiara Balistreri si è sentita costretta a filmarsi e a dare la sua testimonianza su TikTok, nel caso in cui dovesse essere l’ennesima, dopo aver saputo che il suo ex è evaso dai domiciliari in cui stava a causa delle ripetute minacce e percosse.
È stata ben chiara la posizione del nostro Ministro dell’Istruzione,quando afferma che sia preferibile parlare di “residui di maschilismo che vanno combattuti”, ma lo è stato ancor di più Gino Cecchettin: “Mi sembra solo una questione di nomenclatura. È la parola, oggi, che mette paura: ‘patriarcato’ spaventa più di ‘guerra’”. Il punto è stato centrato in pieno, perché non chiamare la cosa con il suo nome significa continuare a trarre vantaggio da una società che si preme nel sopprimere la donna in quanto individuo ed essere in sé e in divenire, negando i ruoli di genere ancora ad oggi persistenti.
E mentre i cortei per il 25 novembre si preparano, le folle si infervorano e si attendono le mimose per l’8 marzo, Martina (ndr. nome di fantasia) sta mandando la posizione su Whatsapp alle sue amiche mentre è sul taxi per tornare a casa; Giorgia le tiene aggiornate sull’andamento dell’appuntamento; o una Lucrezia, che si sta divertendo in discoteca, ha invece accettato un cocktail da uno dei suoi amici, ignara del fatto che non passerà molto perché si rifiuti e perché il suo corpo, dopo essere diventato un giocattolo, verrà gettato lontano come un sacco dell’immondizia.

INCONTRI RAVVICINATI DI TERZO TIPO
QUA E LÀ FRA LE VIE DI UN QUARTIERE

di Luigi Filipetto
Mi è capitato tempo fa di incontrare in un sentiero della Liguria una lunga serpe che si arrampicava sui sassi. Ne approfittai per farci una foto. Visto che non si scomponeva e non mostrava i denti feci la foto da vicino.
Ci ripenso quando si presentano cose impreviste o comunque significative di un certo vivere dei nostri tempi. Cose da marcare, ma poi ti dici che è così. Prendiamo l’indifferenza. Ti metti a raccogliere nella piazza del tuo quartiere indumenti, coperte, scarpe per i bisogni di ogni tipo e di ogni colore – così scrivi nel volantino – e va bene, una grande sensibilità, ma il tipo che ti gira intorno ti chiede per chi è questa roba. Glielo spieghi e lui ti fa una smorfia. Non credo sia un razzista per quel poco che lo conosco, ma proprio non gliene frega niente. Come lui, altri cinque sei tipi stanno lì a osservare, poi qualcuno si stanca e se ne va. Fra questi, il primo tipo si applica e dà una mano a tenere in ordine le cose che arrivano.
La vecchietta che va verso i novanta conosce le vie intorno a menadito. Quella è stata bombardata durante la guerra, ti dice indicando la casa che fa angolo, mentre siamo accanto a una delle cinquecento fontanelle di Milano chiamate vedovelle. Ti dice anche chi abitava vicino all’edicola. Ci davamo del tu dice, una bella famiglia. Poco più in là ci sta l’avvocato che assiste i famigliari di Piazza Fontana e anche di Piazza della Loggia. Glielo dici tu, ma lei fa cenno con la testa di saperlo. Lo sa,insiste, che laggiù in quell’edificio a sinistra che fa angoloentravano i cavalli del generale Radetzky? Si chiama La Cavallerizza. Poi passa all’attacco. Qui ci manca una biblioteca, dice, dove i ragazzi possono andare, non solo per leggere o fare i compiti, ma anche per fare delle cose, non so, suonare, cantare. Le dici subito che tocca un tasto dolente. Là dove c’era il cinema XXII Marzo, sorto negli anni Venti con il nome di Cinema Imperiale – un programma! -, intorno al 1984 il XXII Marzo chiude definitivamente. Per quasi trent’anni rimane un rudere che è uno sfregio alla città. Abbiamo raccolto firme, fatto incontri ufficiali, richiesto una cosa con insistenza: uno spazio a uso del quartiere. Anche per riparare lo sfregio subito da noi. Non placet senza code chiude il discorso. Un giorno si pianta davanti il proprietario. Io pago le tasse, ti dice con gli occhi fissi sui tuoi. Ah!, rispondi. Quel rudere per la verità non era un bel vedere nemmeno per i personaggi importanti che ci passavano davanti con tanto di sirene e provenienti dall’aeroporto. Solo papa Francesco passò silenzioso mentre i bambini della parrocchia, assiepati con le suore davanti alla chiesa, gridavano a gran voce Papa Francesco fermati, nell’illusione di un abbraccio paterno. Il passaggio fra il cinema Imperiale e il XXII Marzo rappresentò anche un segno di adeguamento ai tempi. La nostra nonnina tira fuori dai suoi ricordi che il nuovo cinema aveva attirato l’attenzione dei parroci che raccomandavano ai fedeli di non andarci. Niente di grave, dice, solo qualche bacio clandestino sfuggito fra le sequenze.
Ha visto la Palazzina Liberty?, dice la nostra nonnina voltandosi verso il parco. Anche quella che storia! Lì dentro i contadini mangiavano e facevano accordi. Lì dentro?, chiedi. Non lo sa? Nel parco un tempo c’era un grande mercato. I contadini venivano anche da lontano con i cavalli, altri con il treno. Eh già, a due passi c’era la stazione di Porta Vittoria. Da lì era partita la salma del generale Radetzky. L’edificio ora è stato demolito. Ora si usa così. Ci poteva stare benissimo la Biblioteca Europea. Ora in costruzione poco lontano. Questa nonnina sa un sacco di cose, ti dici. Ti legge nel pensiero e completa la lezione di storia. Prima si chiamava Porta Tosa e dopo la vittoria sugli austriaci nelle famose Cinque Giornate è divenuta Porta Vittoria. Un po’ di cose le sai anche tu, ma è un piacere sentire parlare lei con tutte le memorie che si porta dentro.
Dicevamo dell’indifferenza. Sì perché resti lì a chiederti ma è possibile? In piazza un clown, si chiama magiclown, fa dei numeri incantevoli per i bambini ma anche per i grandi. I bambini lo seguono seduti per terra. Passa un papà che ha per mano un bambino, schiva il clown e prosegue senza neanche girare la testa. Cose che ricorrono con una certa frequenza. Tu sei abituato a vedere il bambino che tira il genitore per la mano per fermarlo. Invece ti dici ancora che così non si può.

DONNA, VITA, LIBERTÀ: LA REPRESSIONE DELLO SLOGAN CHE INCARNA LA LOTTA DELLE DONNE

di Nurgul Cokgezici
La Turchia ha recentemente bandito lo slogan “Jin, Jiyan, Azadî” (Donna, Vita, Libertà), un’espressione di origine curda che negli anni è diventata un simbolo di emancipazione e resistenza. Lo slogan, nato nel contesto del movimento di liberazione curdo, esprime una verità profonda: la donna come fonte di vita e libertà, in un ciclo che sottolinea il suo ruolo fondamentale nella società. Questa frase, che per milioni di donne in tutto il mondo rappresenta una chiamata alla rivoluzione, è ora considerata una minaccia dal governo turco.
Un Simbolo Universale e la Repressione Turca
In Turchia, “Jin, Jiyan, Azadî” è stato ampiamente utilizzato da movimenti femminili e per i diritti umani, tra cui le Madri del Sabato, un gruppo di donne che si batte contro le sparizioni forzate di familiari. Tuttavia, il governo turco, associando lo slogan a movimenti considerati sovversivi come il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), ne ha vietato l’utilizzo e ha intensificato le azioni repressive contro chi lo adotta.
Nel 2024, durante una manifestazione a Istanbul in solidarietà con le donne iraniane, lo slogan è stato scandito da manifestanti davanti all’ambasciata iraniana. La risposta delle autorità è stata rapida e brutale: lo slogan è stato ufficialmente definito una minaccia alla sicurezza nazionale, e chiunque lo utilizzi rischia conseguenze legali. Questa repressione ha scatenato l’indignazione delle organizzazioni per i diritti umani, che denunciano il crescente attacco alla libertà di espressione in Turchia.
L’Uscita dalla Convenzione di Istanbul: Una Ferita Aperta
Il divieto dello slogan si inserisce in un contesto più ampio di violazione dei diritti delle donne in Turchia. Nel 2021, il governo ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale volto a prevenire e combattere la violenza contro le donne. Un’ironia crudele, considerando che la Convenzione era stata firmata proprio nella città che ne porta il nome.
La decisione ha rappresentato un duro colpo per milioni di donne turche, soprattutto alla luce di tragici episodi come quello di Nahide Opuz, una cittadina di origini curde la cui vicenda ha avuto risonanza internazionale. Nahide aveva ripetutamente denunciato il marito violento, ma le autorità non hanno mai preso provvedimenti adeguati. Il risultato? L’uomo ha ucciso la madre di Nahide, un crimine che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto come un fallimento delle istituzioni turche nel proteggere le vittime di violenza domestica.
Un Grido Universale di Resistenza
Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, le azioni del governo turco appaiono ancora più emblematiche. Il divieto di “Jin, Jiyan, Azadî” non è solo una mossa politica; è un simbolo della repressione che pervade ogni aspetto della società. Lo slogan, che ha trovato eco anche in Iran durante le proteste contro la morte di jina Amini, è diventato una bandiera globale per i diritti delle donne, ma in Turchia chi lo utilizza rischia di essere perseguitato.
Una Lotta che Non Può Essere Fermata
Nonostante la censura e la repressione, il messaggio di “Donna, Vita, Libertà” continua a risuonare. Questo slogan rappresenta una promessa di cambiamento, un rifiuto del patriarcato e una chiamata universale a combattere per un futuro più giusto. La Turchia, con la sua politica di oppressione e disprezzo per i diritti umani, non può fermare il movimento che queste parole ispirano.
La lotta per i diritti delle donne è una lotta per l’umanità intera. E mentre il governo turco tenta di soffocare la voce delle donne, queste parole – “Jin, Jiyan, Azadî” – continueranno a vivere come un grido di speranza, resistenza e libertà.

SCUOLA DI MILANESE – PONTÈLL nr. 5

di Fabio Fumagalli
S’ciao bèlla gent. Voeuri finì el 2024 cont ona leggenda de come l’è nassuu el nòster car Milan. L’origin de Milan e del sò nòmm else pèrd tra stòri favolos e leggend.
Serom pressapòcch a la quarantacinquesima olimpiade, ses’cent ann prima che ‘l nassèss elSignor. On brutt avveniment l’ha mettuu sòttsora la vita di pacifichabitant de quèi pòcch villagg rurai de l’Italia settentrional: hinn rivaa i Galli.
Dalle Alpi, a s’cera, esercit guidaa dal sò capitan Belloveso, vegniven giò i invasor. Casciaa via i pastor e i paisan che occupaven chi terr lì, i Galli s’hinn stabilii ne la zòna.
Anzi, Belloveso el gh’aveva addirittura l’intenzion de fondà ona città, simil a quèi del sò paes. L’ha decis però, prima de passà a la fas operativa, de domandà consili ai dèi su quèll che gh’era de fà.
L’ha nominaa sètt sò confident per fagh consultà i oracol, per savèse l’era ona decision giusta e che nòmm l’avaria dovuu dagh a la città che l’avaria fondaa. I dèi gh’hann risponduu che ’l progètt else podeva sì fà, ma a condizion de trovà on pòst adatt: quèll indoeavarien trovaa a pascolà ona loeuggia con la s’cena per metà quattada de lana.
E da sta loeuggia la città l’avaria dovuu ciappa el nòmm. Belloveso l’è restaa on poo perpless: indoe mai seren vist di simil animai? Ma i ordin di dèi, del rèst, se podeven minga discutt …
Hinn partii a la ricerca de la bèstia, e dòpo di ricerch longh e faticos, hinn riessii a trovala per de bon. In ona radura disabitada, circondada da bosch fittissim, hann trovaa ona loeuggia quattadade lana domà per metà.
Pròppi nel pòst indoe aveve trovaa l’animal, Belloveso l’ha disegnaa i confin de la città, che l’hann dòpo battezzada cont elnòmm de Mediolanum (da “medio-lanata” o “in medio lanae”, se sa minga ben). La loeuggia con metà l’è diventada subit el simbolde la città per tanto temp, come la lupa l’era emblèma de Ròma.
Ancamò incoeu, muraa sul second arch del palazzi de la Reson, in via Mercant, se pò vedèl’antich stèmma de la loeuggia: trovaa nel 1233 intanta che scavavenper costruì el palazzi, el bassoriliev con l’immagin de la loeuggia quattada con la lana domà
a metà l’hann mettuu indoe el se troeuva adèss, ben in vista. On poo rovinaa dal temp, ma semper al sò pòstnel coeur de la città.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese


UGUALMENTE ARTISTI

di Aurora Marella
Non è la prima volta che, per trovare un nuovo spunto da condividere e scrivere su Nuove Cronache, io mi imbatta, nelle mie varie ricerche e inciampi sul territorio milanese che percorro ogni giorno, in persone e storie che partono dal cuore e dal riscatto o dal bisogno di dare e restituire amore e solidarietà. In questi viaggi circolari, in questi momenti in cui annuso il tocco di essere umano, mi fermo e riesco a percepire che sono questi l’essenza e il senso che cerco del mio camminare, qualcosa di impalpabile e di vitale che troppe volte qualche attimo di capitalismo vuole farci dimenticare, ma non si può scordare così facilmente.
Questa storia parla di una donna e di tanti ragazzi di tutte le età che, attraverso loro incontro, crescono, dando e ricevendo, reciprocamente.
È una storia di danza, di musica, di coinvolgimento assoluto e totale.
E la donna da cui questa storia prende inizio si chiama Patrizia. E con lei c’è Frank, che fin da subito è stato un amico importantissimo.
2016. L’incontro con Frank è stato illuminante per Patrizia.Si sono subito trovati in una grande intesa fatta di prospettive, di sensibilità, di umanità. Lei, un’insegnante di danza; lui, un ragazzo in carrozzina. Entrambi, menti e cuori vivaci.
Dialogano, condividono idee e bisogni. Nasce così un progetto coraggioso e nobile, un progetto che parte dall’immaginare movimento dove è più difficile realizzarlo: far danzare le menti, la fantasia e i corpi di persone abili diversamente le une dalle altre ma tutte ugualmente desiderose di esprimere se stesse.
Il progetto si chiama Ugualmente Artisti.
E questo nome racconta già tutto.
http://www.ugualmenteartisti.it/
Da allora il progetto che era nato nel 2016 ha continuato a crescere, partendo da una sede storica a Buccinasco per arrivare poi ad aprire altri due poli nel milanese, uno a Segrate da settembre 2024 e uno alla Barona da ora, novembre 2024.
Il progetto Ugualmente Artisti è costituito da lezioni di danza. Potrebbe apparire come una delle tante proposte di palestre e studi artistici in cui si insegna la grazia del movimento ma queste lezioni sono speciali e uniche per almeno due grossi motivi.
Per prima cosa, gli utenti (ormai più di cinquanta) hanno età compresa tra l’infanzia e la pensione e insieme si muovono con la maestra Patrizia e con le musiche proposte da Stefania Belotti, ognuno come può e si sente di fare. Le abilità di questi ragazzi di tutte le età sono diversissime ma tutti sono ugualmente artisti perché ugualmente esprimono capacità, potenzialità, desideri, sogni e libertà attraverso il movimento e la musica.
Ognuno di questi ragazzi porta la propria esperienza di vita e la storia delle proprie conquiste: percorsi molto diversi tra loro ma ognuno di questi viene valorizzato e lasciato esprimere in tutta la pienezza che può raggiungere.
Il secondo motivo per cui le lezioni di danza di Patrizia sono uniche risiede nel fatto che sono gestite da volontari. E il progetto è gratuito per gli utenti.
Durante le lezioni, per un anno accademico, si prepara un musical. E al termine del ciclo annuale viene organizzato uno spettacolo. Grazie a questo immenso lavoro di coordinamento, organizzazione, collaborazioni unito a ricerca umana, fantasia, fiducia, impegno, costanza, amore si realizza il progetto di Ugualmente Artisti. E poi c’è anche la partecipazione ad eventi e festival sulla disabilità e l’inclusione, in luoghi iconici di Milano come la Piazza Duomo o l’Arco della Pace.
L’impegno di Patrizia continua anche in ospedale: visita regolarmente il reparto di pediatria nell’Istituto nazionale Tumori per portare avanti il progetto Musica e movimentocon Stefania Belotti, sua collaboratrice anche nelle lezioni di danza: quest’ultima si occupa della musica e Patrizia del movimento e insieme animano i bambini ricoverati. Ogni volta, essere lì rappresenta l’aver mantenuto una promessa. Per chi in quel momento ha bisogno di altri esseri umani e per se stessi.
Prima del reparto pediatrico oncologico, portava la sua esperienza nella danza e il suo operato umano al Don Gnocchi, nel reparto di riabilitazione cardiologica.
Patrizia, per tutto questo lavoro voluto e organizzato ormai da tanti anni e che cresce sempre di più, ha appena ricevuto un importante riconoscimento in Senato, Il Testimone del Volontariato Italia OdV. Questo è accaduto a Roma, martedì scorso, il 19 novembre 2024.
Ugualmente artisti ha un logo bellissimo e colorato, un disegno di persone in movimento, un cerchio di braccia, gambe, ruote che resta sulle magliette sempre diverse ogni anno, create per ogni ragazzo e ragazza del gruppo. Questo logo fa sorridere e sperare. Fa vedere sole e luce. Fa ricordare il cerchio da cui ognuno di noi prende anima e riceve forza.
Con stima, ringrazio Patrizia per avermi dedicato del tempo per raccontarsi, i volontari tutti, i suoi ragazzi che ho avuto la fortuna di vederli danzare ed è stato un tuffo di emozioni, un mondo di riflessioni.
Quando si inizia a crescere, si cammina e non ci si ferma.
NATALE A MILANO

di Giorgio Righetti
Per le strade è uno spettacolo di folla, di vetrine ricolme di strenne natalizie, di colori, di luci, che si concluderà tra non molto con la grande parata gastronomica di ottimo livello, che porterà sulla tavola vini sontuosi, antipasti assortiti, il tradizionale cappone, per non parlare poi dei ravioli e della mostarda del torrone, dei dolci, della frutta, e del favoloso panettone simbolo con la Madonnina e Meneghino di Milano. La maggior parte delle case straripano di benessere, di luci e di tavole imbandite. Natale ormai è la festa del regalo e del giocattolo, dei viaggi al mare o in montagna, dei pranzi e dei cenoni. Nel bel tempo passato, come tavola imbandita a Natale si conosceva solo quella familiare, non era molto ricca ma accontentava lo stesso tutti. Dopo la Messa di Mezzanotte si tornava a casa a piedi, c’era la neve, il freddo era intensissimo e la casa riscaldata dalla stufa a carbone accogliente, non si chiedeva altro. A tavola i tortellini di Natale, qualche arancio a volte una fetta di panettone, i fichi secchi e delle noci che si conservavano poi fino all’Epifania per prolungare la gioia del Natale, ma quella povertà, quella semplicità, facevano assaporare a pieno lo spirito del Natale. Il benessere oggi ci regala a Natale le vacanze, gli alberghi pronti e attrezzati, le piste da sci, molti partono, fanno crociere, vacanze all’estero. Tutto questo, le vacanze e le tavole imbandite, le feste, le luci, le musiche e i regali possono convivere con noi, possono anche esserci utili e illuderci di essere felici, ma la nostra esistenza non è fatta solo di beni materiali, questi beni, abbelliscono, arricchiscono, ma rimane lo stimolo dello spirito a cui questi beni dicono ben poco o niente, esso cerca la ricchezza che ci può solo dare il Bambino di Betlemme. BUON NATALE.

ALCIDE DE GASPERI

di Alessandro Bocci
Settant’anni fa moriva Alcide De Gasperi, il più grande statista italiano e fondatore della Democrazia cristiana, il partito cardine della prima repubblica.
“Quidam de populo”, De Gasperi nacque povero in una famiglia di contadini e taglialegna della Valsugana. Da studente non possedeva nemmeno le venti corone al mese che permettevano di affittare una stanza singola per frequentare l’università.
Arrestato dalla polizia austriaca a Innsbruck per aver difeso l’insegnamento della lingua italiana, fu forgiato dalle esperienze parlamentari a Vienna, capitale dell’impero austro-ungarico, e a Roma, a partire dal 1921.
Incarcerato da Mussolini, da lui definito “un modest’uomo” dalle colonne del giornale “Il trentino”, seppe andare contro la volontà di papa Pio XII, che nelle elezioni comunali di Roma del 1952 prediligeva un’alleanza fra Dc, monarchici e Msi. Le esperienze franchiste e salazariane a De Gasperi non interessavano.
Nella notte fra il 12 e 13 giugno 1946, fece approvare dal governo un ordine del giorno che gli attribuiva, in qualità di presidente del consiglio, le funzioni di Capo dello stato, vincendo le reticenze di re Umberto II, restio all’esilio dopo l’esito del referendum monarchia-repubblica.
Per De Gasperi per potersi definire antifascisti non bastava avversare il fascismo, ma occorreva denunciare e contrastare, fino in fondo, ogni forma di totalitarismo. Su queste basi stravinse le elezioni del 1948 contro il Fronte popolare di Togliatti, ancorando l’Italia alle democrazie liberali dell’Occidente. Anni dopo, Andreotti dichiarerà che a De Gasperi gli italiani dovevano “la libertà e la democrazia”.
I governi guidati dallo statista trentino attuarono un numero impressionante di riforme: voto alle donne, distribuzione delle terre dei latifondisti ai contadini, con l’esproprio di oltre un milione di ettari di terra, Piano Casa, con il supporto di Fanfani, fondazione dell’Eni, in accordo con il partigiano democristiano Mattei. A giudizio di Polito, “l’ambizione, la visione e la capacità riformista dei governi centristi di De Gasperi non hanno più avuto eguali nella storia successiva della Repubblica”.
Con Adenauer e Schuman, comprese l’importanza di quella che defini’ “la nostra patria Europa”, concetto poi ripreso da Gorbaciov nel saggio “La casa comune europea”. De Gasperi era convinto che le cessioni di sovranità nazionali avrebbero rafforzato non soltanto l’Europa, ma anche i singoli stati che la componevano. L’esatto contrario del sovranismo!
Isolata, nella DC, la posizione di Gronchi e Dossetti, neutralisti cattolici, e assicurata l’adesione dell’Italia alla Nato, De Gasperi avrebbe voluto anche una difesa comune europea, che non si realizzò a causa della posizione francese. A fronte dell’aggressione neoimperiale russa dell’Ucraina, si capisce una volta di più lo spessore e la lungimiranza dello statista trentino.
De Gasperi intuì che per garantire la stabilità del paese il governo doveva poter disporre di un’ampia maggioranza parlamentare. Per solo lo 0,2 % dei voti non riusci’ nel suo intento. Se quella era una legge truffa rimane da chiedersi come definire quelle della seconda repubblica, in cui, tra l’altro, ci si guarda bene dal far scegliere i parlamentari, tramite le preferenze, agli elettori.
Ma tutta l’opera politica di De Gasperi non si comprende se non la si collega alla sua profonda fede religiosa. Alla figlia Maria Romana poco prima di morire disse: “Adesso ho fatto tutto ciò che era in mio potere, la mia coscienza è in pace. Vedi, il Signore ti fa lavorare, ti permette di fare progetti, ti dà energia e vita, ma poi quando credi di essere indispensabile al tuo lavoro, ti toglie tutto improvvisamente… La nostra piccola mente umana ha bisogno delle cose finite e non si rassegna a lasciare ad altri l’oggetto della propria passione incompiuto”.
De Gasperi, che concepiva la politica come un servizio, non era un cattolico clericale e nemmeno un cattolico adulto. Il nostro padre della patria aveva ricevuto un cappotto in prestito per incontrarsi con il presidente statunitense ed era un “Servo di Dio” che morì invocando il Suo nome.

PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI
INCLUSIONE SOCIALE AI GIOVANI: NON SONO SOLO IL FUTURO, SONO IL PRESENTE
Diritti, giovani e quote di genere

di Emanuela Maritato
Svolgere un’attività di sensibilizzazione e sostegno all’inclusione sociale in ogni sua forma ed espressione è imprescindibile. Un naturale processo di sviluppo culturale che consenta il rispetto della dignità umana e la valorizzazione dei diritti di tutti, con l’obiettivo di arrivare ad avere garantite concretamente le pari opportunità nel mondo del lavoro e in ogni prospettiva sociale.
Sostenere le pari opportunità donna-uomo, lottare contro la violenza sulle donne e delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e identità di genere, è una sfida ed un impegno costante per tutti.
Un altro fenomeno a cui prestare attenzione sono le tematiche riguardanti la conciliazione dei tempi di vita di lavoro dei cittadini e delle cittadine.
Meritocrazia è la parola chiave. Un intervento utile è rompere le barriere d’accesso nei vari contesti sociali. La capacità dei giovani di adattarsi rapidamente alla tecnologia, di portare idee fresche ed innovative si traduce in una risorsa preziosa per il futuro ma soprattutto per il presente.
Il programma Agenda 2030 delle Nazioni Unite prevede 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile che hanno ad oggetto la tutela delle persone, lo sviluppo economico e non di meno interesse “l’inclusività”.
L’introduzione di un Sistema di certificazione della parità di genere rientra nella Missione 5 del Pnrr “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro: strumento essenziale per migliorare la coesione sociale e territoriale, nonché di fondamentale importanza per la crescita economica del nostro Paese.
Introdotto dal PNRR e disciplinato dalla legge n. 162 del 2021 (legge Gribaudo) e dalla legge n. 234 del 2021 (legge Bilancio 2022), il sistema di certificazione della parità di genere ha l’obiettivo di assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile, promuovendo la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, riducendo il “gender pay gap” (“divario retributivo di genere” che indica la differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini), aumentando le opportunità di crescita in azienda e tutelando la maternità
Un forte cambiamento è in atto. Lo dimostrano anche le migliaia di aziende che hanno ottenuto la certificazione di genere nel recente anno 2023.
Meno discusso è il tema della parità di generazionale: i giovani devono essere messi nelle condizioni come altri di dare il loro contributo di idee e la loro visione nei vari dinamiche professionali e lavorative.
Esiste un’ampia variabilità in Europa di incidenza dei giovani non occupati e non inclusi in alcun percorso formativo. Il posizionamento sui livelli peggiori del nostro paese su tale indicatore, che più di ogni altro misura lo spreco di giovani in un territorio, è andato consolidandosi nel tempo.
Deve quindi preoccupare particolarmente il fatto che l’Italia sia il Paese che da più lungo tempo detiene il record negativo di questo fenomeno, con un’ incidenza che rimane elevata. I dati dell’Osservatorio giovani mostrano come quasi l’80 per cento i Neet (Not in Education, Employment or Training), indicatore atto a individuare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione, siano insoddisfatti della propria situazione economica. Alto è il rischio, per troppi giovani, di portare fragilità e frustrazioni nella vita adulta. L’auspicio è, allora, che termini la fase di ampliamento delle diseguaglianze a danno dei giovani e se ne apra una nuova in grado di collocare finalmente in modo pieno le nuove generazioni al centro dei processi di sviluppo del paese.

GIUSY SALA: UNA MAMMA CORAGGIO

di Francesco Maraia
Giuseppina Sala, conosciuta come Giusy, è una madre di tre figli. Lavoratrice instancabile, presta servizio in un bar di una scuola nel milanese. Come ogni mamma, il suo amore per i figli è incondizionato e profondo. Tuttavia, la sua vita ha subito una tragica svolta dal 5 agosto, giorno in cui ha perso suo figlio, Omar Bassi, un giovane di 23 anni, a causa di un’emorragia cerebrale.
La storia di Giusy è segnata da un drammatico evento avvenuto il 20 luglio, quando Omar, durante una serata in discoteca al Dolce Beach di Origgio, è stato brutalmente malmenato dagli addetti alla sicurezza. Le violente percosse al capo del giovane, inflitte con scarpe antinfortunistiche e guanti di sabbia, hanno segnato l’inizio di un’agonia per la famiglia. Nonostante i referti medici iniziali non evidenziassero un grave danno, Omar ha mostrato segni di un costante e progressivo peggioramento delle sue condizioni.
Il 5 agosto Omar è spirato tra le braccia dei suoi genitori, un momento che ha segnato il culmine del dolore per Giusy e la sua famiglia. Tuttavia, da quel tragico momento, la sua disperazione si è trasformata in una forza d’animo straordinaria.
Con grande determinazione, Giusy ha autorizzato la donazione degli organi di Omar, salvando dieci vite.
Subito dopo la morte del figlio, Giusy ha deciso di non rimanere in silenzio. Ha sporto denuncia, avviando un caso che ha catturato l’attenzione nazionale. Con instancabile coraggio, ha denunciato la violenza e la brutalità dei buttafuori attraverso interviste, comunicati e manifestazioni. Al grido di “Giustizia per Omar”, Giusy ha dato voce a un dolore condiviso, chiedendo che gli autori di questo crimine vengano giustamente processati.
Giusy non si è limitata a combattere per la giustizia di suo figlio; ha anche esortato tutti a denunciare episodi di violenza simili, affinché nessun’altra madre debba affrontare un dolore simile. La sua lotta è un atto d’amore che trascende la perdita, e la sua volontà di prevenire futuri drammi la rende un esempio di resilienza e speranza.
La storia di Giusy Sala è un monito per tutti noi, un richiamo a riflettere sulla brutalità della violenza e sull’importanza di una società che protegga i propri giovani. La sua umanità e il suo spirito sociale riescono a sovrastare la tristezza, trasformando il suo dolore in una missione di giustizia. Giusy è una vera mamma coraggio, e la sua lotta non deve essere dimenticata.

GOVEND (HALAY): LA DANZA CURDA COME ESPRESSIONE DI UNITÀ E MEDITAZIONE COLLETTIVA

di Nurgul Cokgezici
Le danze tradizionali rappresentano spesso molto più di un semplice atto di intrattenimento o celebrazione: racchiudono identità, storia e valori profondi di una comunità. In questo contesto, la danza curda Govend, come viene chiamata nel contesto culturale curdo, non fa eccezione. Govend è una delle danze più antiche e simboliche della Mesopotamia, una regione che ha visto il fiorire di numerose civiltà e religioni nel corso dei millenni. Ma oltre alla sua funzione sociale, questa danza collettiva può essere considerata una forma di meditazione dinamica e un atto di coesione spirituale, capace di unire i partecipanti in un movimento sincronizzato e simbolico.
ORIGINI STORICHE E CULTURALI DEL GOVEND
Govend è una danza popolare tradizionale delle regioni del Medio Oriente, in particolare nelle aree abitate dai curdi, ma è diffusa anche in altre comunità come quelle assire e armene. Questa danza, che viene eseguita in gruppo, spesso tenendosi per mano o per le spalle, può essere vista come un’espressione di unità, fiducia e solidarietà comunitaria. Il nome “Halay” è utilizzato principalmente in Turchia, ma la stessa danza viene chiamata Govend dai curdi, con una differenza che va oltre la mera questione linguistica.
Govend ha origini molto antiche, risalenti alle culture e civiltà della Mesopotamia, una regione conosciuta come la “culla della civiltà”. In origine, la danza aveva probabilmente una funzione religiosa e rituale, utilizzata per celebrare eventi importanti, stagioni agricole o momenti spirituali della comunità. Con il tempo, è diventata parte delle celebrazioni sociali, come i matrimoni o le feste collettive, ma la sua essenza spirituale e il suo significato comunitario sono rimasti intatti.
GOVEND COME MEDITAZIONE DINAMICA
La danza Govend, quando eseguita in gruppo, diventa un’esperienza profondamente trasformativa. In molti sensi, può essere paragonata a una forma di meditazione dinamica, una pratica in cui il movimento, l’energia e il respiro diventano strumenti di connessione interiore ed espressione spirituale. Il concetto di meditazione dinamica è stato reintrodotto nel mondo occidentale dal mistico indiano Osho, ma ha radici profonde nelle pratiche antiche, come quelle mesopotamiche.
Nella meditazione dinamica, proprio come nel Govend il movimento ha un ruolo centrale. Durante la danza, i partecipanti si muovono all’unisono, seguendo il ritmo di strumenti tradizionali come il davul (tamburo) e lo zurna (uno strumento a fiato). Questo movimento collettivo permette di liberare tensioni emotive e fisiche, e di raggiungere uno stato di presenza consapevole. Il gruppo diventa un corpo unico che si muove con lo stesso respiro, lo stesso ritmo, creando un senso di appartenenza e unione spirituale. Non c’è spazio per la disconnessione: ogni passo, ogni movimento è sincronizzato e coordinato con gli altri, creando una connessione tra il corpo, la mente e lo spirito.
UN SIMBOLO DI FIDUCIA E COESIONE
Una delle caratteristiche più affascinanti del Govend è la fiducia reciproca che si instaura tra i partecipanti. Ogni persona deve fidarsi dell’altra affinché il movimento collettivo sia armonioso e sincronizzato. Questo aspetto va oltre la semplice esecuzione di passi di danza: diventa un atto di fiducia collettiva, dove l’intera comunità si muove insieme come un unico organismo.
Partecipare al Govend significa anche accettare e rispettare i propri compagni di danza, stabilendo un legame simbolico che trascende le parole. Ogni partecipante si impegna a non “rompere” il cerchio, a mantenere lo stesso passo e lo stesso sguardo verso gli altri, rappresentando un patto implicito di fiducia e coesione. Questo rende la danza una potente metafora della vita comunitaria, dove ogni individuo ha un ruolo e una responsabilità nei confronti degli altri.
GOVEND COME RELIGIONE DI CONNESSIONE
La riflessione sul Govend come una “religione di connessione” introduce un aspetto interessante e profondo della danza. Nei tempi antichi, la danza era spesso un modo per entrare in contatto con il divino o per celebrare momenti sacri della vita. In questo senso, Govend potrebbe essere vista non solo come una danza popolare, ma come una pratica spirituale e quasi religiosa. Attraverso il movimento condiviso, i partecipanti si connettono non solo tra di loro, ma anche con una tradizione antica che ha attraversato i millenni.
Nel contesto curdo, e in altre culture della Mesopotamia, Govend rappresenta un legame con il passato e una continuazione delle tradizioni ancestrali. La sua pratica oggi, specialmente tra i curdi e altre comunità come gli armeni, ebrei, assiri diventa un atto di resistenza culturale e spirituale, un modo per mantenere viva l’identità collettiva in un mondo in costante cambiamento.
La rilevanza del Govend non è sfuggita nemmeno a grandi figure spirituali come Georges Ivanovič Gurdjieff, un filosofo mistico di origine armena e greca, cresciuto nella città di Kars, dove la cultura curda era fortemente presente. Gurdjieff, figlio di un cantastorie itinerante conosciuto come Dengbej o Aşık, fu profondamente influenzato dalla ricca tradizione culturale e spirituale del Kurdistan.
Le danze come il Govend e l’Halay lasciarono un segno duraturo nel sistema di insegnamento esoterico di Gurdjieff, che incorporò movimenti ritmici e collettivi nelle sue pratiche spirituali, noti come “Movimenti Sacri”. Gurdjieff vide in queste danze un mezzo per risvegliare la consapevolezza, rompere la meccanicità della vita moderna e connettere il corpo, la mente e lo spirito.
Govend è molto più di una semplice danza popolare: è un atto di connessione spirituale e culturale che unisce i partecipanti in un’esperienza collettiva di unità, fiducia e coesione. Che venga eseguita per celebrare un matrimonio, una festa o un rituale religioso, Govend conserva intatta la sua essenza di meditazione dinamica e di pratica spirituale. Attraverso il movimento sincronizzato, il gruppo si unisce in un cerchio di energia e fiducia, celebrando la propria identità e il proprio legame con una tradizione antica che affonda le sue radici nella storia millenaria della Mesopotamia.
In un mondo frammentato, la danza Govend continua a ricordarci l’importanza di muoverci insieme, di sincronizzarci gli uni con gli altri e di celebrare ciò che ci unisce, piuttosto che ciò che ci divide.

PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ E MANTENERE IN EQUILIBRIO IL SISTEMA

di Teresa Tardia
Le questioni legate al clima e ai suoi cambiamenti sono sempre più urgenti da affrontare e spesso la sensazione è che non sia mai sufficiente quello che viene realizzato. In questa direzione va anche la prevenzione della biodiversità, vera ricchezza per mantenere in equilibrio la natura e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento, allo sfruttamento e alla degradazione degli ecosistemi.
La biodiversità permette di mantenere in equilibrio gli ecosistemi! Deve essere un impegno di tutti.
Per la prima volta in Italia, il National BiodiversityFuture Center (NBFC) – il primo centro nazionale di ricerca dedicato alla biodiversità finanziato dal PNRR – Next Generation EU, mira a promuovere la gestione sostenibile della biodiversità su tutto il territorio italiano in collaborazione con l’Università di Padova.
Il National Biodiversity Future Center (NBFC) lancia una call for talent rivolta a 60 menti brillanti che hanno voglia di orientare i propri obiettivi professionali e scientifici verso la salvaguardia e la promozione della biodiversità, al fine di garantire un futuro più sostenibile alle generazioni future.
L’investimento è rappresentato da una cifra interessante, ed è un primo passo verso una nuova consapevolezza: si tratta di oltre 2 milioni di euro per sostenere chi si farà promotore degli obiettivi costitutivi del Centro, con nuove idee imprenditoriali e azioni concrete per il monitoraggio, la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della biodiversità del nostro Paese.
I 60 partecipanti selezionati attraverso una scolarshipindividuale, con un sostegno di 30.000,00 euro, saranno i protagonisti di un percorso di formazione, mentoring e networking per acquisire competenze e conoscenze trasversali, utili a sviluppare idee di business, servizi e modelli innovativi nel campo della biodiversità.
Questo programma è stato chiamato di UpSkilling e si articolerà in due percorsi distinti:
– uno manageriale, rivolto ad aspiranti manager dell’innovazione con l’obiettivo di realizzare un project work;
– un secondo, di stampo imprenditoriale, rivolto atutti coloro che sono desiderosi di sviluppare un’idea d’impresa nel campo della biodiversitàcon l’obiettivo finale di elaborare un businesstechnology plan, per sostenere la fattibilità di una start-up, e realizzare un proof-of-concept, che dimostri l’utilità della nuova tecnologia e dei prodotti.
Al termine del periodo formativo ai 10 migliori project work o business plan sarà assegnato un premio di 30.000,00 euro.
Per favorire la partecipazione di tutti coloro che vi aderiscono (le attese sono di numerosi iscritti) il percorso di Upskilling sarà preceduto da un bootcamp di sette giorni aperto a tutti i candidati, a conclusione del quale saranno selezionati i 60 migliori partecipanti.
Il programma di formazione che durerà circa 8 mesiprevede sei corsi, con sede in diverse città italiane:
– Nature based solution for biodiversity restoration (Montelibretti, Roma);
– Sviluppo di Sistemi avanzati per la condivisione, comunicazione e fruizione dei dati e contenuti di NBFC (Lecce);
– Biodiversità e benessere (Milano);
– Biodiversità e implementazione delle produzioni in pesca e acquacoltura (Fano e Bologna);
– Modelli di comunicazione innovativa sulla biodiversità (Venezia);
– Monitoraggio della biodiversità (Palermo).
Il percorso di UpSkilling sarà in forma mista con 150 ore di lezioni frontali, in presenza e da remoto – con esperti e professionisti della biodiversità, e 150 ore di attività sperimentali, nonché due visite formative presso centri di eccellenza e incubatori italiani ed esteri, e un workshop finale in cui i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con investitori e venture capital per vendere le proprie idee.
Proprio per generare attenzione interno a questo tema sabato 2 novembre al Festival della Scienza di Genova e domenica 3 novembre al Comics&SciencePALACE di Lucca sarà presentato The BiodiversityIssue, l’albo a fumetti gratuito realizzato da Comics&Science di CNR Edizioni in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (NBFC).L’albo è curato dai ricercatori e comunicatori della scienza Chiara Anzolini e Fabio De Pascale e coordinato dal filosofo evoluzionista Telmo Pievani.Tutto questo avviene per favorire:
• la comunicazione scientifica e rappresentare un mondo in cui la biodiversità è compromessa e l’essere umano non è riuscito a preservare i principali ecosistemi del pianeta;
• approfondimenti scientifici che permettono di osservare come la diversità genetica permette alle specie di rispondere ai cambiamenti ambientali e di resistere a malattie e parassiti, mentre la diversità di specie – dal minuscolo plancton alle balene – è utile per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema,
• valorizzare risorse e strategie già presenti nel mondo naturale per aumentare la resilienza delle comunità umane e degli stessi ecosistemi.
Su tali temi tutti dovremmo impegnarci e l’obiettivo dell’NBFC è attrarre attenzione su una tematica significativa e per molti che vi possono partecipare sfidarsi e cogliere delle opportunità di lavoro per creare un mondo migliore per tutti.

IL FASCINO DELLA TRADIZIONE: LA FIERA DEGLI “OH BEJ, OH BEJ”

di Giorgio Righetti
“Oh Bej, oh bej”, era il grido dei venditori e l’esclamazione dei bimbi meravigliati davanti a tanti banchetti di giocattoli e, “OH BEJ, OH BEJ si chiamò la fiera che dal 1288, ogni anno si tiene a Milano. Un tempo quando Natale faceva capolino la fiera si teneva in piazza Sant’Ambrogio nel giorno della festa del “Grande Vescovo”, in seguito per la grande popolarita invase anche le strade limitrofe. Per la vicinanza delle feste di Natale, gli espositori mettevano in mostra di preferenza giocattoli e dolciumi, i genitori vi portavano i bambini per avere un’indicazione sulle preferenze dei doni e non potevano soffocare il grido di ammirazione di questi davanti a tante cose belle: “Oh bej, oh bej”. “Guardate che belli” era il richiamo degli ambulanti, che si trattasse di giocattoli, di libri, quadri, stampe e strumenti musicali. La contrattazione del prezzo era un altro aspetto tipico della fiera di Sant’Ambrogio, dove il cliente per non far aumentare il prezzo non doveva mai dimostrare eccessivo interesse per l’articolo che intendeva acquistare. La fiera era il ritrovo obbligatorio di saltimbanchi, mangiatori di fuoco e acrobati, era una cornice multicolore impregnata dall’odore delle caldarroste e dei dolciumi più svariati. In questo ambiente popolare non mancava mai il “fachiro”, che con un tappeto steso per terra, alcuni attrezzi e catene, era pronto a esibizioni impressionanti, sollevamento pesi, piegamento sbarre, farsi spaccare una pietra sullo stomaco, poi una buona bevuta di petrolio da spruzzare contro la fiamma di una torcia accesa, alla fine l’esercizio più spettacolare, la rottura delle catene, poi il solito imbonimento comune “Signori io lavoro per la fabbrica dell’appetito”, e il fachiro faceva il giro col piattino tra la folla per raccogliere qualche palanca.
Sempre presente agli “Oh bej, oh bej”, “La banda del Tirazza”, uno di quei complessi ambulanti che si vedevano un tempo per le vie di Milano, tromba, trombone, clarinetto, pochi pezzi orecchiabili provati alla bell’e meglio, e via per il debutto. La formula che concludeva il concerto era abitualmente questa:
Buona salute e buona fortuna!…
Grassie, Siore, Siori e Siorinne!
Al vostro buon cuore!…
Signori si lavora tutti per la fabbrica dell’appetito!…
Faccio il giro!…
Oggi la fiera è molto cambiata, vi si espone e si vende di tutto e di più, ai vecchi oggetti ormai rari sono abbinati oggetti nuovi, per questo la fiera ha mutato il suo aspetto. La fiera degli “oh bej, oh bej”, fino al 1858 si teneva in piazza Mercanti davanti al Palazzo della Ragione e si protraeva ben più a lungo dei giorni nostri, poi spostata prima in piazza Duomo e in seguito in piazza Fontana, prima di scegliere la stessa piazza Sant’Ambrogio. Recentemente la fiera è stata sloggiata anche da lì e spostata al parco dietro al Castello Sforzesco, dove accorrono tuttora gli appassionati. Ricordo con nostalgia quando la fiera era ancora in piazza Sant’Ambrogio, bellissima al crepuscolo al suono delle campane, la nebbia e il freddo del “generale Inverno imminente”, illuminata dalle lampade ad acetilene delle bancarelle e profumata dal fumo delle caldarroste. Questa era la fiera degli “oh bej, oh bej” di ieri, allestita allora intorno alla Basilica del nostro Patrono.

SPETTACOLO 2024!!!!

di Fabio Fumagalli

Bentrovaa gent al nòster 4° pontèll. Pensavi nanca de ricevinscì tanta pòsta…. E son pròppi content perchè voeur dì che gh’è l’interèss de leg in milanes. Mi avete richiesto proverbi, aneddoti, storia, testi di canzoni, vignette, articoli vari….. Insòmma ghe voraria tutt “Nuove cronache” domà per el milanes
Cominci col spiegà ona bèlla manera de dì che l’è anca el titol del nòster spettacol 2024. De minga pèrd!!!
Acqua pader che el convent(pron.: cunvent) el brusa (pron.: brüsa).
Bellissima e colorida espression che la se dis a chi – avendo bevuto troppo – dopo aver dormito, ha sete insaziabile. L’allusione scherzosa si rifaceva a incendi di conventi un tempo frequenti, come in tutte le abitazioni, a causa dell’abbondanza di legno nelle costruzioni. Se doveva domandà el permèss al padre priore per ogni cosa, anche per impienì el sidèll d’acqua per smorzà el foeugh, nonostante l’urgenza.
Ve spettom el 24 de november. La sarà l’occasion per passà dò or in allegria con le nostre divertenti scenette e tanta musica meneghina. Potrete trovare anche le nostre famosissime tazze (vann ben anca come pòrtapenn, come pòrtafior ò per fà on penser a on amis/a) con incisi proverbi e modi di dire milanesi.
Naturalmente continuate a scrivermi all’indirizzo sotto riportato e chi el gh’ha i sòcial el pò trovamm su Facebook, Instagram e Youtube cercando “Scuola di milanese”. A la pròssima e….. s’ciao.
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese

SANITÀ DI STRADA

a cura di Luigi Filipetto
INTERVISTA CON GABRIELLA SCRIMIERI, INFERMIERA

Gabriella Scrimieri di professione è coordinatrice infermieristica presso un nosocomio milanese. Più di un anno fa ha avviato, insieme ad altri suoi colleghi e anche con il supporto di alcuni medici specialisti in vari rami della medicina, una serie di ambulatori medici del tutto gratuiti sotto la dicitura Ali di Leonardo. Ultimamente ha anche edito un giornale online informativo (quotidiano della salute.it), su scala nazionale con un focus importante sulla sanità, la salute e il sociale. Il giornale tratterà anche argomenti di prevenzione, malattie rare ma anche di quella sanità che stenta ad entrare nelle case delle persone più fragili e indigenti.
Di questo ci parla nella presente intervista.
Da che cosa è nata l’idea di un ambulatorio gratuito?
Vengo dalla Puglia e sono a Milano da circa trent’anni anni. Provengo da una realtà di case popolari dove mancava un po’ tutto. Da quella esperienza ho maturato un progetto di vicinanza con i bisogni più elementari della gente che vive all’interno di queste case popolari e che è deprivata di tutto. Su questo progetto ho scritto anche un libro dal titolo Sono solo un’infermiera.
Così ho pensato di mettere in piedi un ambulatorio infermieristico che offra assistenza sanitaria in forma del tutto gratuita. Ho cercato di farlo in ambienti della città di Milano popolati da persone che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica e ci siamo concentrati su questo impegno. Abbiamo creato un’associazione che si chiama Ali di Leonardo con altri colleghi infermieri e anche medici specialisti e inizialmente siamo stati ospitati nelle case popolari del quartiere di Calvairate. Dopo qualche mese abbiamo aperto un secondo ambulatorio nella zona di Ponte Lambro. A breve avvieremo un altro ambulatorio nel quartiere di Calvairate. In questo caso, avendo vinto un bando, non saremo più ospiti ma legittimi destinatari di uno spazio adeguato. Oltre alle attività di carattere sanitario ci occuperemo anche delle svariate situazioni proprie delle persone indigenti.
Come è stata la risposta dei cittadini?
La risposta dei cittadini è sempre stata del tutto positiva, volevano sapere di che cosa ci occupavamo, erano perplessi perché ormai la gente non è più abituata a ricevere qualcosa di gratuito. Così, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo allargato i confini dei nostri interventi specifici, regalando per esempio anche degli occhiali da vista. Abbiamo avviato delle collaborazioni molto efficaci con medici specialisti nei vari settori della medicina. Da poco tempo abbiamo avviato anche un giornale on line che parla di salute, di patologie, di nuovi virus, di dubbi che la gente può avere e di problemi sociali. Il giornale risponde anche alle domande che pongono i cittadini in merito alle cure, questo attraverso la collaborazione di nostri specialisti, perché il giornale dispone di un comitato scientifico di tutto rispetto. Insomma, facciamo di tutto per occupare il nostro tempo libero dal lavoro per fare del bene.
Quali sono i limiti dei vostri ambulatori? Curate ogni tipo di malattia?
Nella nostra attività ambulatoriale abbiamo naturalmente dei limiti strutturali nel senso che non possiamo fare cure di tipo interventistico perché non abbiamo spazi adeguati, ma soprattutto perché dovremmo avere un accreditamento che non abbiamo. Facciamo una rilevazione dei parametri vitali, una attività di prevenzione anche di carattere alimentare. Accompagniamo il paziente con indicazioni pratiche sulle strutture sanitarie più vicine per una visita particolare, su come fare nel caso vengano superati i tempi di attesa previsti dalla legislazione.
Dalla vostra esperienza quali sono i disturbi più ricorrenti che avete rilevato?
Nella nostra esperienza le patologie prevalenti che abbiamo osservato nelle persone che vivono nei quartieri polari sono una grossa prevalenza di patologie psichiatriche, demenze, ragazzi che sono in cura presso i centri di salute mentale, persone che soffrono di depressioni perché hanno perso il lavoro, adulti che vivono ancora con i genitori, abuso di droghe. Altra cosa da dire è che spesso e volentieri quando uno avverte qualche sofferenza se ne accorge dai sintomi perché non fa prevenzione e se ne accorge quando la patologia è già troppo avanti e quindi si deve rivolgere al medico. Altre patologie ricorrenti sono di tipo cardiovascolare specie in persone obese. Abbiamo assistito molti bambini anche perché a Ponte Lambro, per esempio, non c’è il pediatra, per cui anche per una piccola febbre si rivolgono al Pronto soccorso. Noi abbiamo chiesto la collaborazione di un pediatra per due giorni alla settimana. Seguiva attentamente questi bambini, curava i loro piccoli disturbi, bronchiti, polmoniti specie sotto Natale. Una bambina che aveva un problema piuttosto serio l’abbiamo fatta ricoverare. Un altro supporto importante offerto a questi bambini è stato il certificato di idoneità fisica per la palestra. Molte sono famiglie con cinque sei bambini e non possono permettersi di pagare cinquanta euro per un certificato. Noi l’abbiamo fatto gratuitamente, con visita completa da parte del pediatra e il cardiogramma. Siamo riusciti così a garantire circa cinquanta certificati per questi bambini. In certi casi però, avendo notato degli aspetti che meritavano di essere approfonditi abbiamo inviato il bambino dal medico curante della famiglia.

MUSICA SUI PIANEROTTOLI…E NON SOLO

di Aurora Marella
Un concerto all’alba. Nell’alba estiva milanese del Parco Nord. Bella musica nella cornice verde e acqua. Bella temperatura. Sensazione di essere sospesa nel tempo e nello spazio. Per un po’ di tempo è svanito il desiderio di essere in vacanza.
Musica e aria fresca mi hanno impresso un significativo ricordo.
Tanto significativo che non ho avuto dubbi sull’approfondirlo quando ho ascoltato le parole dell’organizzatrice: Lucia Martinelli.
E ho subito intuito che fosse un’iniziativa interessante, parte di un disegno più grande.
Da quelle parole è nata la curiosità che mi ha portato a chiedere, a dialogare con Lucia. Parlando con lei, ho avuto conferma che la sua esperienza fosse ciò che stavo cercando per scriverne, per contribuire alla diffusione di quelle attività della Milano bella che ci piace, quelle che aiutano le persone a stare insieme.
Il mio contributo di questo mese per Nuove Cronache verte su ciò che crea ponti e ancora una volta, dopo gli articoli sulle associazioni Sbarre di Zucchero e Gli Amici della Nave, tocca il tema del carcere, il carcere di San Vittore della nostra Milano. Ma non narrerò solo di questo.
Dopo aver parlato di queste realtà associative che colorano la Milano grigia del viavai lavorativo, ora voglio parlarvi di una donna che ha creato una struttura di interventi su più fronti umani, tutti con lo scopo di diffondere, attraverso la musica, gioia, sorriso, serenità, di regalare un momento di unione tra sé e l’altro.
La fautrice di tutto questo, come anticipato poche righe fa, si chiama Lucia e ha un sito web:
https://musicanellaria.it/.
Ci ho parlato al telefono prima di scrivere queste pagine e mi ha raccontato di aver voluto intraprendere il proprio viaggio alla ricerca di ponti a seguito di una sofferenza personale dove la musica è stata una via di salvezza per cui, poi, ha sentito il bisogno di sdebitarsi col mondo donando lo stesso bene.
Così inizia il percorso di costruzione, che forse resta sempre anche costruzione di sé, insieme alla costruzione di cose belle.
Nel 2018, dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio, inizia la sua avventura per restituire al mondo la gioia che la musica le ha dato.
Inizia a voler portare sollievo proprio nel carcere di San Vittore in cui sempre si reca con la propria squadra di musicisti, da allora, due o tre volte al mese, visitando a turno ogni raggio, proponendo concerti per i detenuti.
Questa è stata la notizia che mi ha colpito, quella mattina al parco. In modo immediato compresi che non stavo assistendo ad un semplice spettacolo di intrattenimento.
Una volta al mese visita l’ospedale Niguarda: nello specifico, entra nel reparto di psichiatria e molti pazienti piangono, ballano, cantano insieme a lei e trovano piacere, interesse curiosità, stimolo nell’ascoltare la musica, nel partecipare la musica, nel lasciarsi avvolgere da essa, nell’osservare gli strumenti diversi che di volta in volta porta.
Lucia ha portato la propria musica anche alle persone in fila al Pane Quotidiano di via Toscana dove aveva iniziato come insacchettatrice del cibo destinato alle persone bisognose.
E poi c’è il quartiere di San Siro, la zona in cui Lucia è cresciuta, in cui c’è tanta ricchezza ma anche tanto degrado, e per questo motivo ha proposto dei concerti nei cortili così come
in una scuola primaria, fino ad arrivare a mettere in atto l’idea che ha costituito l’occasione che l’ha resa più conosciuta, anche tramite il TG regionale, cioè la Musica sui Pianerottoli. Nel periodo del Covid, Lucia girava su chiamata nei pianerottoli delle case e proponeva concerti e serenate entrando nelle storie degli altri e lasciando che gli altri entrassero nella propria storia.
E visitava l’ospedale di Brescia dove portava musica nei reparti, fino alla terapia intensiva. Dense sono state queste esperienze che non ho vissuto personalmente ma solo ascoltate e di cui ho potuto vivere un pezzetto al concerto all’alba, questa estate, in mezzo agli alberi del Parco Nord di Milano, dove c’è il laghetto in cui abitava il cigno Brutus. Un pezzetto che, avevo intuito bene, era un tassello di una rete più articolata.
Lì, quella mattina, con un bicchiere di caffè-à-porter tra le mani, ho conosciuto Lucia e la sua musica. Ho conosciuto Lucia e le sue iniziative contro corrente, ma che seguono il flusso della Bellezza per tutti, di tutti.
Con questo articolo voglio ricordare a tutti coloro che lo leggeranno, e a me stessa, ciò che ho imparato nuovamente: è possibile diffondere la Bellezza. Chi con la Musica, chi con le Parole, chi con il Movimento, chi nell’Arte creativa e chi con la Politica e anche con il proprio Lavoro. E ognuno di noi ha questa responsabilità nel mondo: non dobbiamo mai dimenticare di esserne parte attiva, di esserne in parte debitori e di essere sicuramente un’importante possibilità.

IUS SCHOLAE

di Alessandro Bocci
Uno studio effettuato da Immerse, un consorzio che si occupa dell’immigrazione minorile, evidenzia come il possesso o meno della cittadinanza segni i vissuti di generazioni di ragazzi che vivono nel nostro paese. Il non possederla è fonte di discriminazioni spesso legate a stereotipi che spingono questi giovani in situazioni di marginalità e rendono difficoltosa la loro partecipazione alla vita sociale.
A regolare l’acquisizione della cittadinanza è una legge approvata dal legislatore nel ’92 e fondata sul cosiddetto ius sanguinis. Una legge definita quindi in un differente contesto storico ed ormai inadatta a fotografare la complessità della società. Basti pensare, per fare un esempio, che negli ultimi due anni, per sfuggire all’aggressione russa, si sono stabiliti in Italia circa duecentomila profughi ucraini.
Secondo l’Istat, circa l’80% dei ragazzi di origine immigrata che frequentano le nostre istituzioni scolastiche si sente italiano. Si tratta di circa un milione di persone che, con l’introduzione dello ius scholae, potrebbero usufruire di percorsi educativi aventi l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze negli apprendimenti.
A nessuno può sfuggire che, non solo il futuro, ma anche il presente è multiculturale. E’ questa la realtà. E per far progredire questo paese, fatto di anziani e di famiglie senza figli, occorre favorire una maggiore integrazione, mettendo in primo piano il rispetto della persona e della sua libertà.
In passato, le discussioni sullo ius solis, ius culturae e ius scholae non hanno prodotto risultati apprezzabili. Su quest’ultimo, oggi sembrerebbe esistere una convergenza fra forze politiche di maggioranza e di minoranza, come del resto è avvenuto per la formazione della Commissione europea. Per contrastare gli estremisti che soffiano sul disagio sociale delle fasce di popolazione meno acculturate per trarne vantaggi elettorali, occorre definire spazi di dialogo che trascendano dalle logiche di appartenenza. La valanga di firme che in questi giorni sta supportando il referendum sulla cittadinanza dimostra, con chiarezza, che nel nostro paese non possono esistere persone di serie A ed altre di serie B.

LA SACRALITÀ DELLA DONNA NEL KURDISTAN: UN FARO DI CONOSCENZA E RESISTENZA

di Nurgul Cokgezici
Recentemente, l’India è stata teatro di un tragico episodio: l’uccisione di una ginecologa che ha spinto migliaia di donne a scendere in piazza, adottando lo slogan “Jin Jiyan Azadi”, parole che risuonano profondamente nella lotta di liberazione di un grande leader curdo. Questo avvenimento ci porta a riflettere sul ruolo della donna nella società curda, dove essa riveste un’importanza centrale e sacra, non solo come individuo, ma come simbolo di vita e conoscenza.
Nel Kurdistan, la donna ha storicamente avuto un potere simbolico e sociale inestimabile. Basti pensare al rituale che si svolge durante i conflitti: quando una faida o una guerra raggiunge un punto critico, la donna più anziana si toglie il velo e lo pone a terra, un gesto che obbliga tutti gli uomini presenti a fermarsi e a cercare la pace. Questo potere ancestrale risuona come un richiamo alla centralità della donna nella gestione delle relazioni e nella risoluzione dei conflitti.
Un altro simbolo eloquente del potere femminile si trova nella bandiera curda, dove il sole è rappresentato con i suoi raggi, ognuno dei quali simboleggia i vari gruppi religiosi che convivono nel Kurdistan. Il sole, da sempre considerato sacro dai curdi, è la personificazione della donna. Così come il sole riscalda e illumina, la donna è vista come colei che fornisce non solo l’affetto e il calore umano necessari per la sopravvivenza, ma anche la luce della conoscenza e della saggezza. In questo senso, la donna è sia un pilastro emotivo che intellettuale, incarnando il legame tra il sapere e la vita.
Tuttavia, questa sacralità della donna ha subito un grave declino dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il Kurdistan fu smembrato e diviso in quattro parti con il Trattato di Losanna. Gli invasori – Turchia, Iran, Iraq e Siria – introdussero un pensiero islamico rigido e patriarcale, con l’intento deliberato di sottomettere le donne e ridurre la loro importanza sociale. Questo cambiamento forzato ha provocato una regressione del ruolo femminile nella società curda, spingendo le donne ai margini.
Nonostante tutto, la nascita del movimento curdo e del Partito dei Lavoratori del Kur.. ha segnato l’inizio di una rinascita per la donna curda. Le donne hanno iniziato a riaffermare la loro importanza e autorità, riscoprendo quella forza innata che è sempre stata parte del loro “inconscio etnico”. Questa rinascita non è stata solo simbolica, ma ha avuto profonde ripercussioni politiche e sociali. Le donne curde, infatti, hanno assunto ruoli di leadership e sono diventate figure chiave nelle lotte per la liberazione, sfidando non solo il patriarcato interno, ma anche le potenze esterne che continuano a opprimerle.
Tuttavia, questo potere rinnovato non è accettato di buon grado dagli stati che occupano il Kurdistan. Turchia, Iran, Iraq e Siria dipingono ancora i curdi come un popolo “arcaico delle montagne”, cercando di sminuire la loro identità e la loro cultura, ignorando deliberatamente il valore e il ruolo cruciale della donna nella loro società.
Da mediatrice culturale con esperienza in antropologia e sociologia, posso affermare con certezza che poche società, incluse quelle occidentali considerate più evolute, attribuiscono alla donna un’importanza e un potere simili a quelli riconosciuti nel Kurdistan. La donna curda non è solo un individuo, ma una guida, un faro che illumina la strada verso la conoscenza e la libertà. Il suo potere risiede non solo nella sua capacità di resistere, ma anche nella sua capacità di costruire una società più giusta e armoniosa, in cui la pace è il valore supremo.
Oggi, mentre il mondo continua a lottare contro le disuguaglianze di genere, la figura della donna curda rimane un esempio potente di forza e resilienza. Le lotte delle donne curde ci ricordano che la liberazione di una società non può avvenire senza la liberazione delle sue donne, e che la loro forza è intrinsecamente legata alla costruzione di un futuro più giusto e luminoso, per tutti.
Jin Jiyan Azadi

LA NAVE E I SUOI AMICI

di Aurora Marella
Libertà è partecipazione, citava Gaber.
E così, con queste tre parole, che sole racchiudono un largo pensiero, inizio il racconto di questo mese su una Milano che si muove, si agita, si prodiga per dei valori nuovi e vecchissimi come la possibilità di scegliere e cambiare, la comunità, la rinascita. Nei miei scritti di Nuove Cronache amo mettere in luce quelle realtà che aiutano la realtà. E ho proseguito la ricerca.
Come avevo anticipato nell’ultimo mio scritto sul numero di giugno di Nuove Cronache, ho sentito il bisogno di intraprendere un percorso di scoperta e conoscenza sulla vita e sulle possibilità di chi non può usufruire della libertà per un po’. Ho voluto parlare di una realtà invisibile a noi, che stiamo fuori. Perché si tratta di una realtà tangibile solo per chi sta dentro. Cercando di descrivere con la massima neutralità ciò che ho potuto imparare. Osservando solo ciò che accade. Chiedendo, parlando con chi è parte di quel processo delicato che cerca di congiungere il dentro con il fuori.Lo spartiacque sono le mura della prigione. In particolare, le mura a raggiera di San Vittore, Milano.
A giugno parlai dell’associazione diffusa sul territorio nazionale Sbarre di zucchero che offre il proprio attivismo sul fronte della valorizzazione della vita delle donne in carcere, perché essa possa trascorrere nella ricostruzione, nella consapevolezza e nella dignità. Partendo dalla fornitura di beni primari ed essenziali per l’igiene personale fino al supporto emotivo e psicologico. Quelle cose che servono come l’aria e se mancano, tutto è nero, perduto. Quelle cose che, in effetti, non possono mancare se si considera la detenzione come una fase per ricostruirsi, per rimettere in ordine ossa e pensieri.
Perciò, sempre sul tema della vita in carcere, voglio raccontare di un gruppo di Volontari, gente che dedica parte del proprio Tempo al Tempo di qualcun altro. Sono gli Amici della Nave. Amici di chi sta dentro.
La Nave è il braccio del carcere di San Vittore di Milano in cuistanno le persone con dipendenze e, mentre scontano la pena detentiva, hanno la possibilità di intraprendere un percorso di cambiamento. Di responsabilizzazione.
Nella Nave vengono proposte diverse attività per ritrovare sestessi e imparare a considerarsi parte di un collettivo in cui riconoscersi e attraverso cui sostenersi. I detenuti hanno la possibilità di scrivere un periodico mensile redatto e distribuito gratuitamente da Feltrinelli, Oblò. Scrivono e si esprimono, riflettono, crescono (tutti dovremmo trovare qualcosa che ci stimoli a crescere, a credere che un nostro seppur piccolo contributo può rappresentare un’importante svolta. Scusate la digressione, sorta spontanea).
Nella Nave i detenuti hanno la possibilità di praticare attività sportive e di svolgere percorsi di educazione alla legalità.
La Nave è un braccio che naviga verso il recupero e la ricostruzione di sé, prima dentro sé, poi fuori.
In questo fuori entrano in gioco gli Amici della Nave, che poi gioco non è ma si vuole gli somigli.
Le attività e le buone pratiche per l’allontanamento delle persone dalle dipendenze proseguono dal braccio al mondo, attraverso un gesto catartico e antico come la Madre Terra abitata da creature: il canto. Gli Amici della Nave sono un coro. Dal repertorio variegato e impegnato, sensibile e toccante sulle tematiche della libertà, del rispetto, della dignità, del lavoro, della comunità.
La voce degli Amici della Nave genera un ciclo di continuità con i percorsi intrapresi dentro e li porta fuori. Si canta, si suona Tutti. Chi è dentro, esce fuori e chi è fuori arriva dentro. C’è partecipazione e c’è libertà.
Il coro organizza eventi con e per i detenuti. Costituisce un gruppo di riferimento per chi ha bisogno di possibilità. Chi è dentro con chi è fuori trova un’altra possibile rotta per la Bellezza e, attraverso questa, per sé stessi.
Io credo che ciò valga per ognuno di noi. Un gruppo, una rotta, la voglia di condividere e partecipare ci rendono un po’ migliori, un po’ più pieni, un po’ più ricchi.
Sulla tematica del recupero dei detenuti, recentemente ho assistito ad una proiezione domestica del film di Antonio Albanese Grazie ragazzi. La trama incarna bene il messaggio della Cultura e del Coinvolgimento che, entrando come proposte in un carcere, divengono un approdo, una mappa, un porto. Devono però essere abbracciati anche al rientro in cella contro la monotona ripetitività delle giornate. Il film termina però in modo malinconico.
Gli Amici della Nave vogliono agire anche contro il rischio di dispersione raccontato nel film di Albanese e continuano costantemente a sostenere il braccio e mantenerlo vitale, credendo che il riscatto debba partire da dentro con autodeterminazione madebba anche essere sostenuto fuori e continuare a lavorare da lì, supportato e incoraggiato. Con gesti semplici quali una cantata corale, il fare musica insieme, all’interno di un grande movimento di persone.

AVVOCATO SÌ, MA ANCHE ALTRO

a cura di Luigi Filipetto
Glauco Gasperini fa di professione l’avvocato, ma ha una particolare sensibilità per dare una mano a chi, specie se immigrato, ha bisogno di essere indirizzato nel complesso mondo della burocrazia e anche di essere orientato a realizzare una convivenza rispettosa di diritti e di doveri. È uno dei fondatori del progetto “Io parlo italiano”, che sono incontri bisettimanali del tutto volontari, per immigrati ma non solo, che si tengono presso il Circolo Carminelli di via Archimede 13, nel quartiere del Suffragio di Milano.

Glauco Gasperini
La tua esperienza professionale ti permette di fare un quadro più realistico della situazione degli immigrati.
In quanto avvocato penalista mi capita di imbattermi in persone in particolari situazioni. Le difficoltà di inserimento nel nostro paese da parte di persone che provengono da altri paesi porta a volte a commettere dei reati. In questi anni ho avuto modo di mettere a fuoco il fatto che la non conoscenza delle regole della nostra società, dei riferimenti, di come fare per organizzarsi e relazionarsi con le altre persone, di come fare banalmente per esempio la domanda dell’allaccio della luce, porta le persone a diventare progressivamente più marginalizzate. Di fronte a queste difficoltà di base, alle quali possiamo sopperire offrendo degli adeguati sostegni, emerge la necessità di guidare queste persone a inserirsi sempre di più nel tessuto sociale, cosa che consente anche una maggiore possibilità di trovare un lavoro. Quando si realizza tutto questo, allora anche la propensione a commettere dei reati o delle irregolarità scende in maniera significativa.
Il tuo impegno nel progetto “Io parlo italiano” sembra che sia non solo fondamentale ma anche piuttosto vasto.
Il nostro progetto sulla convivenza “Io parlo italiano” mira a offrire alle persone delle opportunità per inserirsi nel nuovo contesto sociale in cui si trovano affinché possano mettere a fuoco quella che è la loro personalità, i loro talenti, di lavorare, così da acquisire una condotta assolutamente regolare. Oltre ai problemi della lingua, una associazione di volontariato umanitario deve avere presenti una serie di altri problemi fondamentali per favorire un adeguato inserimento in una nuova società. C’è una serie di problemi dei quali bisogna occuparsi e sono sicuramente l’insegnamento dei rudimenti della lingua italiana altrimenti non c’è modo di comunicare, si sa che molti immigrati non hanno la capacità di comunicare sulle cose più semplici, non sempre hanno il vantaggio di una lingua ponte che può essere l’inglese o il francese perché se scappano dal loro paese a causa di guerre o altre difficoltà non hanno avuto modo nemmeno di frequentare le scuole. Occorre poi allargare i nostri supporti su molti aspetti diciamo burocratici, quali la compilazione di un modulo. Nessun lavoro poi, anche il più semplice, prescinde dalla necessità di relazionarsi con altre persone. Altri problemi possono essere quelli di trovare una casa, un lavoro. Noi non possiamo occuparci direttamente di questi problemi, ma possiamo orientarli verso le strutture di riferimento che loro non conoscono. In questo modo offriamo un aiuto concreto per inquadrarsi correttamente nella società. Le prestazioni che io personalmente all’interno del nostro progetto fornisco sono quelle che, secondo il livello di conoscenza della lingua, della città in cui si trovano, delle regole del vivere, sono appunto quelle di offrire maggiori elementi di conoscenza. Alcuni provengono da città, altri da villaggi spersi. Quindi non possiamo dare per scontato che loro conoscano regole del vivere civile che a noi appaiono elementari. Quindi a volte si tratta proprio di partire dalle basi. Credo anche che sia importante che ciascuno all’interno del nostro progetto dia il proprio contributo, non solo per un doveroso senso civico e umanitario, ma perché se queste persone si inseriscono, se possono lavorare, ne giovano sicuramente loro, e questo è l’aspetto umanitario che non va mai dimenticato, ma anche la nostra società in quanto la loro emarginazione non è vantaggiosa per nessuno.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 3

di Fabio Fumagalli
S’ciao bèlla gent. Bentornaadai feri! Settember l’è el mesche ricomincen tutt’i attività: el laorà, i impègn, la scòla, e anca i cors de lingua milanesa.
E novità: dal 23 de settember ricominciom conti LEZION DE MILANES in la Cà di Associazion in piazza Stovani (indoegh’hinn i uffizi de l’Anagrafe del Comun) finalment in presenza inscì suddivis:
El LUNEDI dai 21,00 ai 22,30: per quèi che voeuren imparà o hinn giamò bon de recità ò cantà
El MARTEDI dai 15 ai 16: cors elementar de milanes
dai 16 ai 17: cors de perfezionament de milanes
Naturalment ghe voeur iscrives perché gh’è on limit de pòst (nòpussee de 20 persònn per lezion) : l’è assee invià ona mail a: Fabio.Desdott@gmail.com.
El material necessari de portà l’è: on nòtis per scriv e on poovoeuja de applicass in tutta serenità.

E chi sòtta el nòster indovinèll
In che ann la Nazional de fòlber l’ha vinciuu con la Germania e l’è diventadacampion del mond?
(1978 – 1980 – 1982)
Sòtta l’articol, a gamb all’ari, podii dòpo controllà se avii rispòst giustament!!!
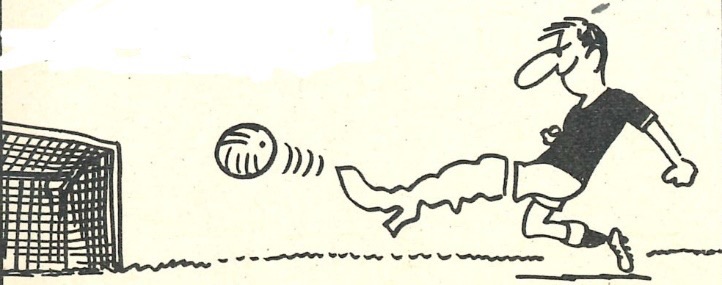
E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese
UNA STORIA RACCAPRICCIANTE. LA COLONNA INFAME

di Giorgio Righetti
Quindici pestilenze dal secolo IX al XVII devastarono la popolazione di Milano. Una ondata di peste la più tremenda si abbattè nell’estate del 1630, la credenza popolare che malefici untori propagassero l’epidemia spargendo sulle porte delle case un unguento scuro trovò capri espiatori nel barbiere Gian Giacomo Mora e nel commissario alla Sanità Guglielmo Piazza. Era la mattina del 21 giugno 1630 verso le ore otto, quando Caterina Trucazzano e altre donne abitanti alla Vedra de’ Cittadini videro un uomo ammantellato con un cappello nero calato sugli occhi, che camminava strisciando presso un muro, aveva una carta in mano e faceva strani gesti, dissero i testimoni. Nessuno lo aveva riconosciuto ma gli indizi portarono a Guglielmo Piazza commissario di sanità del Ducato di Milano. Da qui il terribile equivoco che doveva portare al barbiere Gian Giacomo Mora. Arrestato e in mano agli inquisitori dopo qualche ora di terribili torture il Piazza aveva confessato tutto quello che i suoi inquisitori volevano che dicesse, di essere un untore e di aver ricevuto l’unguento della peste dal barbiere Gian Giacomo Mora. Anche il povero Mora una volta finito nelle mani dell’Inquisizione confessò di tutto e di più. I due malcapitati furono condannati a morte. All’alba del 2 agosto 1630 dal cortile del palazzo di Giustizia usciva un carro trainato da due buoi. Sul carro legati spalla a spalla Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, due frati di cui uno reggeva una grossa croce e dei boia armati di tenaglie, davanti al carro un messaggero a cavallo annunciava la pena per i delitti commessi dai due untori, durante il percorso i due vennero attanagliati con pinze roventi e davanti alla bottega del Mora venne loro tagliata la mano destra. Le loro sofferenze erano appena iniziate, arrivati al patibolo vennero legati a una ruota, i boia spezzarono loro le ossa delle braccia e delle gambe, in quella posizione secondo la condanna dovevano rimanere per sei ore. I due presunti untori trascorso il tempo stabilito vennero rimessi nelle mani dei boia, erano ancora vivi, vennero scannati e gettati su una catasta di legno in fiamme, i resti vennero gettati nelle acque della Vedra. A questa roggia sono legati sinistri ricordi, la attraversava un ponticello, detto ponte della Morte che portava al patibolo e in quelle acque male odoranti erano gettate le ceneri di quei disgraziati che secondo le accuse erano streghe malefiche o untori. Il palco dei supplizi a quel tempo era recintato da una solida cancellata, era questo il posto delle esecuzioni dei condannati del popolo, mentre i nobili erano favoriti dal privilegio della decapitazione in altri luoghi, oltre che esenti da quelle torture feroci che martoriavano le carni dei plebei sul palco della morte. Il popolo accorreva a quegli orrendi spettacoli e le donne alzavano sulle braccia i figli per far conoscere la sorte dei cattivi. La casa di Gian Giacomo Mora, presunto diffusore dell’unguento della peste, fu rasa al suolo, al suo posto fu eretta una colonna di granito con in cima una sfera, destinata a ricordare il terribile misfatto dei due untori. “La Colonna Infame”, abbattuta nel 1778 per volere di Pietro Verri e Cesare Beccaria, recava una scritta in latino, che così diceva:
LUNGI DUNQUE DA QUI
BUONI CITTADINI
CHE VOI L’INFELICE INFAME SUOLO
NON CONTAMINI
La Storia della Colonna Infame rappresenta la “insufficienza della umana giustizia”, ma che purtroppo qualche volta può presentarsi come “suprema giustizia” e segna invece il trionfo della imprudenza umana, quando l’uomo faccia sue regole di vita pregiudizi, supposizioni non accertate, ipotesi e atti di culto falsi e superflui.
Sotto il manifesto della sentenza dei due malcapitati presunti untori.
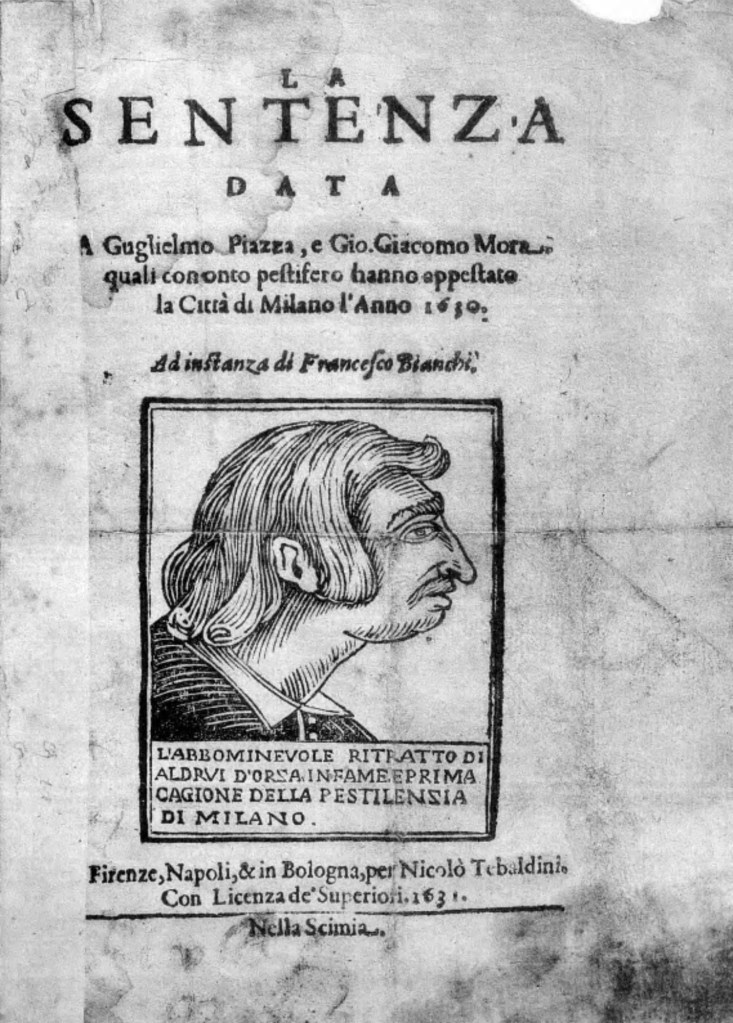
GLORFINDEL, L’EROE DIMENTICATO

di Luca Dragani
A dispetto della grande ammirazione che ho sempre nutrito – che nutro ancora – verso la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ho un rammarico insistente al punto da volerlo esternare e circostanziare: l’assenza di Glorfindel, il mio personaggio preferito. Glorfindel è un Elfo della Prima Era, un ‘Signore Elfico’ come lo definisce Gandalf durante il soggiorno degli Hobbit a Imladris.
Tuttavia, da questa scarna seppur importante definizione non si evince la grandezza del personaggio: essa però si può già intuire, a quel punto della narrazione e senza addentrarsi nello studio delle Appendici o di altri libri quali i Racconti Perduti o La Caduta di Gondolin, apparsi postumi a cura del figlio di J. R. R. Tolkien, Cristopher, perché è Glorfindel che, inviato in soccorso degli Hobbit incalzati dagli Spettri dell’Anello, riesce a porli in fuga nei pressi del Guado del Bruinen, dopo aver affidato Frodo, ormai intossicato dal veleno della Lama Morgul del Capo dei Nazgûl, al proprio cavallo Asfaloth.
Come, il Re degli Stregoni, colui che quasi sconfigge Gandalf il Bianco sulla porta di Gondor, che incute terrore in ogni creatura, fugge dopo una carica ‘a piedi’ e mette in fuga lui e gli altri Cavalieri Neri?
Leggiamo attentamente: Frodo, ormai quasi preda della dimensione delle ombre, vede ‘una figura luminosa’ scagliarsi contro il Re degli Stregoni. E questi fugge. Solo dopo arriva l’aiuto di Elrond e Gandalf, che gonfiano le acque del fiume travolgendo i loro cavalli. Come spiegherà poi Gandalf al convalescente Frodo, lui l’aveva visto come lo vedono coloro che vivono nell’ombra, presente dunque nel mondo manifesto della Luce e in quello occulto dell’Ombra.
Ma non è questa la prima sconfitta del Signore dei Nazgul (il più potente dei nove Re degli Uomini corrotti da Sauron con gli Anelli del Potere nella Seconda Era) subita da parte di Glorfindel: era già accaduto quando egli era il Re di Angmar, che aveva via via già sconfitto i regni divisi dell’Arnor e minacciava già Gran Burrone. Elrond all’epoca inviò lui con una schiera di Elfi (Noldor, Sindar e Silvani) sconfiggendolo duramente in battaglia e decretando così la fine di quel tenebroso Regno del Nord.
Dunque Glorfindel era un Elfo molto potente, perché?
Qui bisogna andare a cercare indietro, nella Prima Era, quando Glorfindel era il Signore della Casa del Fiore d’Oro di Gondolin, la città nascosta governata da Turgon, figlio di Fingolfin, che l’aveva costruita con i consigli di Ulmo, il Vala delle Acque, nel perduto Beleriand. Trovata alla fine grazie al tradimento di Maeglin da Morgoth (il capo di Sauron, uno dei Valar poi votatosi al Male) e messa a ferro e fuoco, venne dopo strenua resistenza e molte perdite evacuata dei pochi superstiti guidati da Tuor e da Glorfindel, il quale morì proteggendo i fuggitivi combattendo con un Balrog, che morì con lui.
Un destino analogo (anche se non così immediato) a quello di Gandalf, ‘rimandato’ in vita dai Valar per contrastare Sauron. Leggendo la messe di scritti di Tolkien, pubblicati negli anni dal figlio, si evince che Glorfindel sia tornato nella Terra di Mezzo, richiamato dalle Aule di Mandos più o meno dopo l’avvento dei primi Istari (gli Stregoni Blu Alatar e Pallando) e prima di quelli di Radagast, Saruman e infine Gandalf.
Come Gandalf torna ben più potente dalla morte, così avviene per Glorfindel, il quale era già saggio e potente di suo, ma viene restituito ai Popoli Liberi dotato di preveggenza e capacità di consiglio.
Sua fu, infatti, la premonizione per cui, quando il Re di Angmar venne sconfitto a Fornost, ed il Re di Gondor Earnur avrebbe voluto inseguirlo, venne da lui fermato con le parole ‘egli non morirà per mano d’uomo’. Egli era anche membro del Bianco Consiglio, e il motivo per cui non accompagnò Frodo nella Compagnia dell’Anello fu probabilmente proprio perché, manifesto com’era fra i morti al pari che fra i vivi, sarebbe stato come un faro acceso, un bersaglio evidente per tutte le creature del Male. Infine, mentre Aragorn e Eomer fronteggiavano l’esercito di Sauron davanti al Morannon, Glorfindel, Elrond e i suoi figli erano impegnati a difendere Imladris, attaccata da forze di Sauron da Nord.
Si comprende ora il mio rammarico?

“DONA VITA, DONA SANGUE”

di Kateryna Semenchuk
“Dona vita, dona sangue” è lo slogan della campagna per la donazione del sangue e del plasma, promosso dal Ministero della Salute. Questa breve frase rappresenta pienamente il perché ho deciso di diventare donatrice di sangue, ossia per poter salvare vite umane ed essere socialmente utile.
Personalmente, sono diventata donatrice quest’anno grazie ad un progetto scolastico. Dopo la prima donazione volontaria, ho deciso che questo piccolo gesto sarebbe diventato una parte di me e non molti giorni fa sono tornata al Policlinico di Milano per fare la mia piccola opera buona, che poi piccola non è.
In seguito troverete alcune informazioni utili e curiosità sulla donazione del sangue. Buona lettura.
Perché è importante donare il sangue?
Innanzitutto, la donazione del sangue permette alle strutture sanitarie di garantire le terapie mediche necessarie alle persone fragili, ma non solo. Chi dona sangue o plasma ha la possibilità di monitorare la propria salute, grazie agli esami di routine che vengono fatti gratuitamente nei laboratori. Infine, questo semplice gesto permette di diventare un cittadino attivo e di dare un buon esempio alla comunità.
Per cosa vengono utilizzate le sacche del sangue?
Il sangue donato viene utilizzato in numerose terapie ed interventi medici, tra questi troviamo: trapianti di organi, cura delle leucemie, parto cesareo, chemioterapie ed interventi di primo soccorso e di emergenza.
Chi può diventare donatore?
Per diventare donatore/ donatrice bisogna rispettare alcuni parametri: avere un’età
compresa tra 18 e 60 anni, il peso corporeo deve essere superiore a 50 kg e bisogna godere di un buono stato di salute. Prima di donare il sangue, ogni paziente deve fare un breve colloquio con il medico il quale verificherà l’idoneità alla donazione.
Informazioni utili sulla donazione.
La procedura della donazione richiede 2-3 ore di tempo, dal momento dell’accettazione fino allo spuntino post-donazione. Inizialmente il paziente viene sottoposto alla verifica della pressione sanguigna e del livello di emoglobina e in seguito ad un colloquio con il medico. Una volta confermata l’idoneità del volontario si procede con la donazione vera e propria, durante la quale vengono prelevati 450 ml di sangue. Generalmente il processo richiede 10-15 min, ma è importante non avere fretta ad andarsene, perché è possibile avere un malessere (nausea o giramento di testa). Dopo il prelievo ad ogni donatore viene offerto uno spuntino nel bar dedicato; qui è possibile gustarsi un buon panino per riprendere le forze e fare nuove conoscenze con gli altri donatori.

A BOLOGNA I GRAFOLOGI IN AZIONE DAL 27 AL 29 SETTEMBRE

di Teresa Tardia
Negli ultimi anni la Grafologia si è notevolmente arricchita di studi e di applicazioni. La grafologia è una disciplina volta a identificare la persona nei suoi aspetti intellettivi, temperamentali e relazionali attraverso l’interpretazione della sua scrittura e, più in generale, della sua attività grafica spontanea. Studia l’uomo, essere unico e irripetibile, attraverso ilcompimento del gesto grafico, anch’esso unico e inimitabile, poiché elaborato dal cervello e tradotto per mezzo della mano in scrittura.
In Europa e nel mondo sono nati, soprattutto a partire dal XIX Secolo, vari metodi e scuole per lo studio e l’interpretazione della scrittura. Ciò che spesso contraddistingue le diverse scuole è il livello di approfondimento raggiungibile con l’analisi e la complessità dei criteri metodologici. I vari metodi non sono necessariamente in contrasto fra loro, anzi, è importante rilevare che, seguendo metodi di scuole diverse, fra le più quotate, si ottengono risultati simili.
La grafologia si sviluppa in diversi ambiti: Consulenza individuale, Consulenza familiare, Orientamento professionale e scolastico, Consulenza peritale-giudiziaria, Età evolutiva e Educazione del gesto grafico.
La Terza Edizione dell’incontro dei Grafologi Italiani si terrò presso varie location itineranti e di prestigio a Bologna:
- la Biblioteca dell’Archiginnasio Sala Stabat Mater
- Biblioteca Salaborsa
- Oratorio San Filippo Neri
- Teatro di Villa Aldrovandi MazzacoratiBisogna partire da un principio che la scrittura a mano è patrimonio dell’Umanità.Nel nuovo secolo dove tutti scriviamo al computer o sulle tastiere degli smartphone appare paradossale, quasi controcorrente, parlare di scrittura a mano in particolare in un momento storico in cui sembra destinata a tramontare. Eppure, mai come in questi ultimi anni se ne parla e se ne stanno riscoprendo i benefici in ambiti di studio anche molto distanti fra loro.L’incontro dei Grafologi vuole in primo luogo promuovere, diffondere e difendere il valore della scrittura a mano come grande e insostituibile patrimonio dell’uomo, che trova nella scrittura la sua vera espressione unica e inimitabile. Ed è proprio come patrimonio dell’umanità che si chiederà l’impegno all’UNESCO di proteggere la manoscrittura corsiva.Consapevoli che tecnologia e mondo del digitale siano ormai una realtà imprescindibile, intento del festival è quello di integrare e far convivere le due modalità comunicative: manoscrittura e web writing. L’iniziativa rappresenta anche un interessante strumento di
marketing territoriale, capace di promuovere tanto la città, quanto gli operatori e le realtà che a diverso titolo vi prenderanno parte.
Il comitato tecnico scientifico è rappresentato da Guglielmo Incerti Caselli – Presidente A.G.I., Fermino Giacometti – Presidente Istituto Grafologico Internazionale G. Moretti, Carlo Nofri – Professore all’Università di Fermo, Portavoce del Coordinamento Nazionale delle Città Unesco dell’Apprendimento, Benedetto Vertecchi – Professore emerito di Pedagogiasperimentale presso l’Università Roma Tre e Cinzia Angelini – Professoressa associata di Pedagogia sperimentale presso l’Università Roma Tre
Il programma degli eventi è ricco e pano di iniziative che spaziano dagli incontri per parlare del rapporto tra scrittura e musica con Daiano, Dario Baldan Bembo e Andrea Faccani, Presidente Fondazione Lucio Dalla. Ci saranno anche considerazioni su scritture e iscrizioni trovate nei progetti di ricerca archeologica in Tunisia (scavi e ricognizioni) e sono previsti laboratori per bambini e adulti.
Nei primi sono previsti esercizi di disegno, psicomotricità, prescrittura accompagnati e guidati da un esperto che potrà dare indicazioni funzionali alla crescita grafomotoria e ad un sano sviluppo delle abilità grafiche del bambino; nei secondi esercizi di calligrafia
Sono previste anche delle al Teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati tratte dall’ opera “Destinatario sconosciuto” che è la trasposizione teatrale dell’omonimo testo di Katherine Kressmann.
È la storia del legame strettissimo fra Max, ebreo americano, e Martin, tedesco: amici e soci in affari, i due si separano nel 1932 quando Martin abbandona la California e torna in Germania con tutta la famiglia.
Il loro rapporto prosegue attraverso un fitto rapporto epistolare, caratterizzato da forte affetto, che permette la condivisione di ricordi, pensieri, racconti, speranze, ma che cambia con lo svilupo del contesto geopolitico. Ed ecco che la corrispondenza muta inesorabilmente: gli stati d’animo dei due personaggi si fanno sempre più distanti, fino ad arrivare alla frattura definitiva dell’amicizia con una clamorosa svolta finale. Questo spettacolo molto intenso, con un’interpretazione magistrale dei due attori: Massimiliano Lotti, nelle vesti di Martin, e Marco Pagani, in quelle di Max. Regia di Gabriele Calindri vuole proprio mettere in evidenza l’impatto della scrittura.
Per maggiori informazione sull’iniziativa manuscribere sul sito di seguito riportato è possibile trovare tutti i dettagli e gli approndimenti (www.manuscribere.it).

NON SOLO SATNAM

di Alessandro Bocci
I padroni lo hanno lasciato morire dissanguato. Hanno sottratto i cellulari ai suoi compagni per evitare che chiamassero i soccorsi, poi lo hanno scaricato morente davanti a casa con il braccio amputato in una cassa da frutta. Nelle campagne di Latina dove vige impunito e tollerato il caporalato, Satnam Singh è morto così. Aveva trentun anni. La ruralità dell’agropontino, e non solo, è anche questa roba qui.
Come tanti immigrati, Satnam era arrivato in Italia per lavorare, con la speranza di una vita migliore. Forse aveva pensato che gli italiani fossero brava gente, come favoleggia la retorica nazionalista, ma aveva dovuto rapidamente ricredersi. Nelle campagne di Latina i braccianti agricoli lavorano fino a quattordici ore al giorno e per resistere devono far ricorso ad oppioidi, prescritti e venduti da medici e farmacisti. Vivono stipati in appartamentini dai fitti esorbitanti, ovviamente in nero. Su settemila aziende della zona solo un centinaio sono iscritte alle registro istituito sulla base della legge anticaporalato. Poi, magari, certi imprenditori agricoli salgono su trattori, comprati con i soldi dell’Ue, per manifestare contro l’Ue stessa: sono destinatari di oltre il trenta per cento del bilancio comunitario, 386 miliardi di euro, ma non va bene lo stesso.
I padroni di Satman non sono mele marce, smettano di raccontarcelo. Già nel 2019, infatti, i “Medici con l’Africa CUAMM” riferivano che nei sei anni precedenti i braccianti agricoli morti nel nostro paese fossero circa millecinquecento. Su Repubblica, Concita de Gregorio ha parlato di schiavismo ed in effetti la realtà della filiera agroalimentare richiama quel sistema. Il bracciante dipende totalmente da chi dispone della terra e dei mezzi di produzione. La celebre eccellenza alimentare italiana è spesso opera degli schiavi e se muoiono ci pensano i caporali a mandarne altri.
Più in generale, i numeri del lavoro nero in Italia sono impressionanti. Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre oltre tre milioni di persone tutti i giorni svolgono un’attività lavorativa irregolare, pari secondo l’Istat a 174 miliardi di euro di sommerso (per fare un paragone, il Pnrr italiano vale poco più di 190 miliardi). Per spezzare questa violenza dell’uomo sull’uomo occorrerebbe una grande sanatoria in favore degli immigrati, simile a quella del 2002, e modificare profondamente la Bossi-Fini.
Per la Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente per assicurare a sé ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Per la Laborem exercens, vale il principio della priorità del lavoro nei confronti del capitale e il primato dell’uomo nel processo produttivo. Nella Rerum Novarum, Leone XIII scriveva che la proprietà privata dei mezzi di produzione era ammissibile solo se orientata al bene di tutta la comunità.
Purtroppo, la realtà è ben diversa. Lo sappiamo tutti, soprattutto quelli che minimizzano.
Ha ragione la De Gregorio. Di Satnam non dobbiamo mai smettere di parlare. Perché la sua morte non è casuale. A volerla non è stato soltanto chi lo aveva schiavizzato. Satnam è vittima di un sistema che calpesta i diritti dell’uomo, che trasforma i migranti in clandestini, in carne da macello. E poi non ne dobbiamo mai smettere di parlare perché il mondo appartiene a tutti, non è solo dei bianchi. Il mondo non è proprietà di coloro che costruiscono i muri per sporcarli con il sangue della povera gente.

DALLA VERDE IRPINIA ALLA VIA DELLA SETA, IL VIAGGIO DI LEO

di Francesco Maraia
Leopoldo Lagrimosa, conosciuto da tutti come Leo, è un professore di origine irpina che ha deciso di intraprendere un’avventura straordinaria nell’Asia più remota con nient’altro che uno zaino in spalla. Questo viaggio, che attraversa le terre affascinanti e poco esplorate del Uzbekistan, Kazakistan, Tajikistan e Kirghizistan, segue le orme dell’antica Via della Seta, unendo storia e scoperta personale.
Con treni, passaggi in auto e lunghe camminate, Leo ha deciso di intraprendere un viaggio spartano e autentico, lontano dalle rotte turistiche comuni. La sua missione? Scoprire il mondo con occhi nuovi, apprezzare le differenze culturali e crescere come cittadino cosmopolita, figlio del mondo.
Durante il suo cammino, Leo ha visitato le capitali affascinanti di questi paesi e i villaggi più remoti, immergendosi nelle culture locali e stringendo legami con persone di ogni estrazione sociale. La sua determinazione e la sua apertura verso gli altri sono state ripagate con innumerevoli sorrisi, gesti di solidarietà e momenti di empatia che hanno arricchito il suo viaggio.
Nello zaino, Leo porta con sé l’essenziale: la voglia di scoperta, la fiducia nel prossimo e l’urgente necessità di riscoprirsi. Questo viaggio, pur essendo difficile e a volte scomodo, è una vera lezione di vita per tutti noi. Ci insegna l’importanza di guardare il mondo con occhi diversi, di apprezzare le diversità e di crescere come persone grazie alle esperienze che viviamo e alle persone che incontriamo.
Leo, con il suo viaggio itinerante, ci ricorda che spesso, le esperienze più significative non si trovano nelle comodità moderne, ma nella semplicità del vivere e nel contatto umano. Un viaggio ricco di sfide, ma anche di momenti indimenticabili, che ispirano e insegnano il valore della fiducia, della scoperta e della solidarietà umana.

Puoi seguire il viaggio di Leo sulla pagina Instagram @leopoldolagrimosa.
TURANDOT, L’INCOMPIUTA

di Libera Iannetta
Turandot è l’ultima opera di Giacomo Puccini alla quale il compositore lucchese attese fino al 1924, quando partì per Bruxelles dove subì un’operazione per un tumore alla gola. Aveva orchestrato l’intero spartito ma si era fermato al duetto ultimo e al finale, in attesa di definitiva redazione del libretto. Aveva portato con sé gli abbozzi dell’ultima parte che, però, sarebbe stata realizzata solo dopo la sua morte da Franco Alfano e in due differenti versioni, la prima bocciata da Arturo Toscanini.
A Torre del Lago, nella villa di Edoardo Fassini Camossi, ex diplomatico, Puccini aveva incontrato i librettisti Giuseppe Adami e Renato Simoni e ascoltato da un carillon, portato dalla Cina, melodie poi utilizzate. L’interesse per l’argomento è documentato da una lettera a Simoni datata 18 marzo 1920: “Ho letto Turandot, mi pare non convenga staccarsi da questo soggetto […] semplificarlo per il numero degli atti e lavorarlo per renderlo snello, efficace e soprattutto esaltare la passione amorosa di Turandot che per tanto tempo ha soffocato sotto la cenere del suo grande orgoglio”.
Il soggetto deriva dalla novella Saggezza sotto le novantanove teste tagliate, contenuta nella raccolta Le mille e una notte. Ispirò la stesura di Turandot, la quarta delle Fiabe drammatiche scritte dal veneziano Carlo Gozzi (1720-1806) in chiave irrealistica e bizzarra per polemica contro il realismo del teatro di Carlo Goldoni. Friedrich Schiller aveva tradotto le fiabe di Gozzi in tedesco e Andrea Maffei le aveva nuovamente tradotte in italiano, sintetizzandole. A Torre del Lago, la raccolta di Maffei fu data da Simoni a Puccini che, diretto a Roma, la lesse in treno e, scelta Turandot, propose poi degli aggiustamenti nonché l’inserimento della figura di Liù, non presente in Gozzi.
La sera della prima esecuzione, il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala, giunti al terzo atto, dopo l’aria di Liù, Tu che di gel sei cinta, il direttore Arturo Toscanini scelse di non eseguire l’ultima parte composta da Alfano e nella versione da lui stesso precedentemente approvata; deposta la bacchetta, si rivolse al pubblico dicendo commosso: “Qui il maestro è morto”. A quel punto Puccini si era, infatti, arrestato.
Turandot è la storia di una principessa cinese dal cuore di ghiaccio che sottopone i suoi pretendenti a tre enigmi mortali. Suo padre la vuole moglie e madre per assicurare un erede alla dinastia ma lei, distaccata e crudele, odia gli uomini in quanto la sua ava, Lo-u-ling, è stata violentata ed uccisa. La repulsione al maschio è dichiarata nella scena quarta dell’atto secondo: […] Per tutta / L’Asia, invilita e condannata al giogo / Del servaggio è la donna, e vendicarla / Mi proposi e giurai, nei baldanzosi / Nostri oppressori, che vantar non ponno / Privilegio su noi fuor d’una rozza / Vigoria […]. Una donna che rifiuta l’ordine patriarcale, quindi, che non si sottomette all’elemento maschile, che rifiuta il peso di un’identità di genere che non la rappresenta.
La spietata principessa che condanna alla decapitazione tutti coloro che non risolvono i tre enigmi è un personaggio inaspettato nel teatro pucciniano. Il compositore ne è conquistato e, al contempo, respinto. La conclusione che la vuole convertita all’amore del principe Calaf che, unico, riesce a risolvere gli enigmi e a sciogliere il ghiaccio del suo cuore lo lascia dubbioso, incerto sul finale. Per un anno intero, infatti, prima del tragico viaggio a Bruxelles, il musicista si tormenta invano, fino alla fine, sulle pagine del gran duetto d’amore.
D’altra parte, l’introduzione della figura di Liù da parte del compositore stesso, rappresenta una soluzione tradizionale, rassicurante, il tòpos della fanciulla-vittima sfiorita sulla tomba dell’amore. Le morti femminili, infatti, sono un luogo comune nell’opera lirica e il personaggio di Liù, innamorata senza speranza di Calaf, torturata perché, in un estremo atto di generosità, si rifiuta di fare il nome del principe, finirà col togliersi la vita. Il maestro lucchese realizza l’opera, che rappresenta la fine del melodramma romantico, proprio fino alla conclusione del corteo funebre di Liù e le scene finali sono solo abbozzate in trentasei foglietti.
La conclusione prevista, con l’abbandono di Turandot nelle braccia dell’amore, avrebbe implicato l’accettazione di un unico punto di vista, di un’unica scontata soluzione. Il finale aperto di Turandot, invece, mette in discussione l’immagine machista dell’uomo e propone un cammino femminile di rivendicazione e di libertà.

CONSERVATORISMO – ALLA RICERCA DISPERATA DI UNA VIA D’USCITA…

di Slobodan Fazlagic
L’Europa sta faticando in questi giorni. Vediamo che riesce appena a tenere la testa sopra il livello dell’acqua. Ha qualcosa agganciato ai piedi che la tira giù, ad affondare. Malgrado ciò, riesce ancora a galleggiare. C’era da aspettarsi che fosse un compito faticoso, quello che riguarda tutti i progetti innovativi. Non chiamiamoli rivoluzionari solo perché il termine in questione ha subito tante violazioni da parte di seguaci autoproclamatisi leaders delle rivoluzioni che hanno finito con lo sciupare il concetto stesso di rivoluzione, fino a svuotare di senso anche lo stesso significato del nome.
Dunque, un progetto tanto nobile quanto necessario, direi, doveroso per la sopravvivenza di tanti, ma che dico, di tutti i paesi del continente europeo per affrontare draghi economici mondiali come gli USA, la Cina, la Russia, l’India, i vari possessori emergenti di denaro facile proveniente da risorse petrolifere o minerarie. I padri fondatori hanno trascorso anni non semplici di fronte all’opposizione all’idea di Europa, hanno convissuto con lo shock, ben piantato nello stomaco, della Seconda guerra mondiale che ha visto popoli impoveriti e stremati e che non ha prodotto la coscienza della necessità di andare in un’altra direzione. Comunque, è nata un’unione puramente economica, ma che per sé non poteva reggere a lungo troppi localismi inutili. Quell’unione si è lentamente allargata verso l’idea di oggi, quella di imparare a camminare su due gambe, malgrado problemi con la scelta delle scarpe e addirittura anche con uno stesso numero per entrambe…
Il problema che rende quel cammino stentato è evidente a tutti: i passi all’indietro da parte delle piccole comunità, delle tribù nazionali che tentano l’impossibile (ma non per loro), ovvero tenere per sé i piccoli privilegi locali, la propria fattoria in cui produrre ciò che serve… L’autarchia. Il conservatorismo, appunto, da parte di tanti movimenti, partiti o partitini, sparsi sull’intero continente, che vedono i nemici fuori dalla recinzione stretta attorno al loro piccolo feudo, ereditato o conquistato è lo stesso.
I nemici. Chi sono? Tutti coloro che si posizionano fuori dalla terna magica alla quale si sono aggrappati come ad una roccia nel fiume in piena e che sarà l’unica a salvarli: Dio, patria e famiglia. Cosa potrebbero significare questi tre totem? Totem che minacciano i pensatori liberi, gli scrittori, gli stranieri e gli immigrati, gli omosessuali e gli LGBT in generale, gli studiosi scienziati, i musicisti rock, gli studenti e i giovani alla ricerca del proprio naturale spazio di crescita, in poche parole tutti coloro che non vogliono restare complici nella recinzione, a spiluccare il grano prodotto in cortile? Ci sono da sempre, dai primi giorni della rivoluzione industriale (ad es. il luddismo nel XIX secolo), per allargarsi poi dai puri perimetri delle periferie operaie, timorosi delle nuove tecnologie, verso tutte le classi sociali e le sfere produttive. Ciascuno, insicuro di sé e delle proprie capacità nell’affrontare il mondo e la concorrenza libera, ha trovato qualcuno di cui avere paura e di conseguenza ha voluto e vuole fermarlo o eliminarlo. Come? Visto che hai paura perché sei più debole come lo affronti? Unendoti e partecipando alle faide promosse da una tribù creata dai tuoi simili… È così che nascono tanti movimenti conservatori, leghe, “patrioti”, fratellanze…
Ma sono fatti che conosciamo tutti. Per parecchi anni occupavano una percentuale trascurabile delle società europee, al margine dell’errore statistico, 4% o 5% … Ultimamente, e testimoni ne siamo oggi in Italia, nei Paesi Bassi, in Ungheria, Slovacchia, Francia, Germania, Polonia, paesi ex-comunisti dell’Europa dell’Est, superano di tanto queste percentuali e addirittura conquistano la maggioranza politica. Altro discorso, che ho affrontato l’altra volta sull’articolo relativo al fatto che l’assenteismo al voto li aiuta per cui vengono al potere praticamente grazie a un quarto degli aventi diritto a quel voto, un quarto che corrisponde ad una percentuale cinque volte quella storica ed attesa… Non intendo, pertanto, entrare nella discussione sull’origine ormai conosciuta da tutti di questo fenomeno: tanti studi ed analisi politico-economiche ne hanno dimostrato le cause nel fatto che la base elettorale dei partiti tradizionalmente di sinistra si è spostata verso destra.
La domanda che mi pongo dall’inizio è: il conservatorismo di oggi alla ricerca disperata di una via d’uscita riuscirà a far affondare la signora Europa che, per il momento, già non partecipa più alla gara mondiale di nuoto, ma tenta solo di galleggiare?
Il voto per la Commissione europea ha visto i conservatori italiani schierarsi contro un’Europa che guarda avanti, che cerca di trovare un posto nella scacchiera internazionale per diventare finalmente un giocatore e non essere schiacciata dai pesi massimi mondiali. Visto il successo, assai dubbioso riguardo ai modesti numeri locali assoluti, la destra italiana si vanta di poter dirigere la direzione in cui L’Europa nuota. Non verso l’oceano aperto, certo, ma tenendosi in una piscinetta in cui a malapena sguazzare, tutti divisi nelle proprie vasche da cortile. Per il momento si sono trovati fuori dai giochi, facendosi del male da soli.
Penso che questo potrebbe essere il segnale che il loro sia un progetto improbabile e condannato al fallimento. Come tanti progetti conservatori nella storia, di cui non si riesce a vedere il successo. Quanti feudi fortificati e chiusi sono arrivati ai nostri giorni? Nessuno. Non rimane che aspettare che arrivi il momento in cui si scioglieranno dentro quella pentola dove sono ancora al caldo. Senza preoccuparci troppo. Può darsi che, a breve, trovino una via d’uscita, magari strettissima, come l’hanno trovata finora nell’individuazione di altri nemici, di volta in volta nuovi. Terrestri per il momento, ma in futuro chissà…

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 2

di Fabio Fumagalli
31 MAGG 1983
S’ciao bèlla gent. ‘Sto mes hoo pensaa de contentaa tucc quèi che m’hann domandaa de pubblicà i poesii.
(Vi ricordo che per le vostre richieste milanesi su questo Giornale potete scrivetemi all’indirizzo mail sotto riportato). Se tratta de ona poesia del scior Domenico Alzati che l’ha scritt per el sò fioeu.
In fond ve mètti la traduzion per quèi che gh’hann di dubbi.
Quand te nass on fioeu te par de vèss el padron del mond,
te corret subit a dà la notizia.
Dòpo tanto aspettà finalment l’è rivaa,
l’è lì de vedè,
el se pò toccà,
ciappà in brasc sto fagottin cont i manin inscì picinin,
te rèstet impacciaa quasi paralizzaa.
Subit comincia la guèrra dei somiglianz,
per fà tòrt a nissun, te convien vendigh on queicòss a ògnun.
Quand t’el pòrtet a cà, ògni tant te stee lì ad ascoltà
per sentì se l’è adree anmò a respirà.
A vedèll nel sò lettin, tutt scrusciaa giò come ona coccinèlla,
te penset: ma la vita come l’è bèlla.
In on canton ben nascòst te consèrvet on tesorètt:
on cossin e on conigliètt, on dentin e duu ciuffètt,
ma anca on sacch de emozion che te regala pù nissun.
Quando ti nasce un figlio ti sembra di essere il padrone del mondo, – corri subito a darne notizia. – Dopo tanta attesa finalmente è arrivato, – è lì da vedere, – si può toccare, – prendere in braccio questo fagottino con le sue manine così piccoline, – resti impacciato quasi paralizzato. – Subito comincia la guerra delle somiglianze, – per non far torto a nessuno, ti conviene venderne qualcosa ad ognuno. – Quando lo porti a casa, ogni tanto stai ì ad ascoltare – per sentire se sta ancora respirando. – A vederlo nel suo lettino, tutto rannicchiato come una coccinella, – pensi: ma come è bella la vita. – In un angolo ben nascosto conservi un tesoretto: – un cuscino e un coniglietto, on dentino e due ciuffetti, – ma anche un sacco di emozioni che non ti regala più nessuno.

E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese
LA FABBRICA DELL’OLINDA. DA OSPEDALE PSICHIATRICO A CENTRO CULTURALE DI QUALITÀ

di Giorgio Righetti
È un progetto collettivo nato nel 1996, la cui missione è l’inserimento lavorativo di persone a rischio di emarginazione sociale. Olinda è una comunità stravagante e simpaticissima molto accogliente con la gente del quartiere, che viene a passeggiare nel bel parco alberato di tigli, tra i padiglioni dell’ex ospedale Paolo Pini. “DA VICINO NESSUNO È NORLMALE” è uno degli appuntamenti estivi più importanti attesi in città, un centro di incontri e di creatività che si conclude sempre con una rassegna ricca di eventi. Il punto più importante è il Teatro “LA CUCINA”, predisposto all’interno delle ex-cucine, dove un tempo erano decine di fornelli, oggi si provano gli spettacoli. Sono ospiti tutte le compagnie teatrali che cercano un loro palcoscenico per le prove. Nel parco qualche tempo fa avevo fatto amicizia con un ex paziente che appendeva annunci leninisti, era soprannominato “il bolscevico”, era un signore molto perbene, colto, intelligente e benvoluto da tutti, da tempo ormai non vedo più con dispiacere questo caro personaggio, che con la coda dell’occhio sbirciava i passanti per vedere se erano interessati ai suoi proclami, all’interno del Parco: “IL GIARDINO DEGLI AROMI”, che promuove l’uso e la conoscenza di piante aromatiche e medicinali, un’oasi di pace celata dietro le mura dell’ex’ospedale, dove hanno trovato un abitat ottimale e un rifugio sicuro molte specie di uccelli, una numerosissima colonia di pappagallini, i parocchetti è presente tutto l’anno, nelle sere d’estate si può ammirare la bioluminescenza delle lucciole e sentire il bubolare del Gufo e dell’Allocco, presenti con altri rapaci notturni il Barbagianni, l’Assiolo e la Civetta, numerosissimi gli scoiattoli, anche i ricci si riproducono facilmente senza pericolo di essere investiti dalle macchine, è stato anche trovato un piccolo falco “Gheppio”, caduto da un nido durante un temporale e poi affidato alla LIPU. Un grande quadro all’interno allestito dalla LIPU, illustra tutte le varietà di uccelli presenti o di passo durante l’anno. Nel Giardino degli Aromi si coltivano anche molte piante officinali e altri ortaggi, è un piccolo paradiso all’interno del quartiere. Olinda e il Giardino degli aromi, sono un esempio di integrazione in cui le diverse culture coesistono pacificamente e si arricchiscono tra di loro. Chiunque può venire a passeggiare nel parco, magico e misterioso, uno spazio accogliente, disponibile per il riposo e la sosta, si chiede solo il rispetto per la natura. È DI RIGORE IL BEL TU CORDIALE.

IO CANTO LA CITTÀ

a cura di Luigi Filipetto
Abbiamo intervistato Beppe Boron, presidente della Audorasitalia, che è di casa in Piazza Santa Maria del Suffragio con il suo sassofono. Beppe ci parla con passione e anche con un po’ di amarezza della vita degli artisti di strada nelle nostre città e in particolare a Milano.
Beppe, parlaci dell’arte di strada.
Intanto devo informare che con l’ultima assemblea la nostra associazione, che si chiamava FNAS (Associazione Nazionale Artisti di Strada), ora si chiama Audorasitalia, perché gli associati chiedono una maggiore presenza anche a livello internazionale, di poter partecipare a bandi europei, a festival o altro. Quindi ora abbiamo due rami che caratterizzano l’associazione, arte di strada e spettacolo di strada. Il primo ramo per noi comprende il diritto di ogni cittadino di utilizzare lo spazio pubblico per fare arte. Il secondo ramo è spettacolo a tutti gli effetti, sono professionisti, hanno cooperative, società, partite IVA eccetera. In questi due ambiti la Audorasitalia si occupa di formazione, di convegnistica, di essere da supporto per tutti gli iscritti per poterli indirizzare al meglio. Per l’arte di strada in senso stretto l’associazione si è sempre occupata di regolamenti cittadini per tutto quello che riguarda le esibizioni spontanee ed estemporanee. Le più comuni perfomances dell’arte di strada pura interessano la musica, la danza, le arti circensi, la pittura. La musica è l’arte più semplice e più comune. Per quanto riguarda le problematiche legate all’esibizione di un artista di strada, ogni comune legifera e produce norme proprie. Non abbiamo una legge nazionale che definisce che cos’è l’arte di strada, chi la può fare e dove. A volte un comune elabora un proprio regolamento, altre volte demanda alla polizia urbana il compito di mettere uno o due articoli sull’arte di strada. Quindi noi ci troviamo, ogni volta che giriamo, ad avere normative differenti. Capita così che, secondo noi, queste normative non vengono neanche applicate correttamente. Alla fine può capitare che chi decide è un vigile urbano, per cui succede a volte che dobbiamo spiegare a lui, che magari si occupa di tantissime altre cose, alcuni aspetti del regolamento.
Tu sei anche milanese. A Milano come funzionano le cose?
Non so neanch’io come definire la situazione nella nostra città. Milano su questo viaggia un po’ a spanne. Vorrebbe che tutto fosse incasellato e caratterizzato alla perfezione. In realtà quello che sta succedendo la definirei una situazione confusa. Contrariamente a quello che vorrebbero ottenere hanno creato un caos totale. C’è una piattaforma che non aiuta l’artista di strada a capire quello che può o non può fare. Non c’è una linea chiara, per cui chi va su questa piattaforma capisca esattamente quali siano i limiti a cui attenersi. Si va su questa piattaforma e da qui si può accedere a una piazzola. Ma l’arte di strada è una esperienza umana con le sue esigenze e modalità personali per essere vissuta. Invece ti capita di prenotare una postazione nel centro di Milano, il cosiddetto salotto, tu vai lì in modo del tutto impersonale. Meglio sarebbe poterti recare all’ufficio competente, prenotare di persona, chiedere anche informazioni per esempio sul volume contemplato. Con il risultato di creare in questo modo una scrematura di chi ha veramente voglia di fare arte di strada, di confrontarsi con il pubblico e di creare empatia con esso. C’è poi il problema del rapporto fra il centro e le periferie. È chiaro che tutti mirano al centro, nelle periferie il cosiddetto cappello si riempie di meno. Le norme del comune valgono sia per il centro sia per le periferie. Se però per quanto riguarda il centro l’obbligatorietà della prenotazione dello spazio è comprensibile, non altrettanto lo dovrebbe essere per le periferie. Regolamentare l’arte di strada nella stessa maniera è una follia. Uno va in una piazza di periferia e si esibisce. Se poi arriva un altro artista e trova la piazza già occupata se ne va da un’altra parte. A Londra, che è dieci volte Milano, questo succede. Ci sono regolamenti differenti fra luogo e luogo. A Milano questo non c’è, è un gran calderone. Oltretutto, gli artisti veri, quelli bravi che ci tengono a creare con la loro presenza un rapporto di simpatia e di rispetto con tutto quello che sta loro intorno, ci vanno sempre meno in centro. Ecco, il comune di Milano dovrebbe considerare con maggiore sensibilità l’importanza dell’arte di strada e non accontentarsi di emettere regolamenti. Oltretutto l’arte di strada a Milano non è sotto l’assessorato alla cultura ma sotto l’assessorato alle politiche giovanili. Cosa che non c’entra nulla.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MUSICA MODERNA: OPPORTUNITÀ O DECADENZA?

di Giorgio Caporale
Negli ultimi anni, la produzione musicale ha subito una trasformazione radicale. Un tempo, fare musica richiedeva non solo talento naturale, ma anche uno studio approfondito della teoria musicale, una conoscenza dettagliata dei dischi che hanno fatto la storia e un’abilità sviluppata nel riconoscere e creare melodie e strutture armoniche complesse. Oggi, invece, con l’avvento della tecnologia e delle piattaforme digitali, chiunque può produrre e pubblicare musica con pochi click, riducendo drasticamente le barriere d’ingresso al mondo della musica.
L’ACCESSIBILITÀ DELLA TECNOLOGIA
La democratizzazione degli strumenti musicali digitali ha aperto le porte a milioni di aspiranti musicisti. Software come Ableton Live, FL Studio e GarageBand permettono a chiunque di creare tracce musicali senza bisogno di conoscere la notazione musicale o di possedere strumenti costosi. Basta un computer e un po’ di creatività per iniziare a comporre. Questo ha portato a un’esplosione di contenuti musicali, ma ha anche sollevato domande sulla qualità e sulla profondità di queste nuove produzioni.
LA CRISI DELLA CRITICA MUSICALE
Parallelamente alla produzione musicale, anche la critica musicale ha subito una metamorfosi. Se un tempo i critici erano figure autorevoli, con anni di esperienza e una profonda conoscenza del panorama musicale, oggi chiunque può esprimere opinioni e recensire brani attraverso i social media e i blog personali. Questa proliferazione di critici improvvisati ha contribuito a una dispersione dei parametri di giudizio. Molti di questi nuovi critici non possiedono una formazione adeguata né una comprensione approfondita della musica, riducendo spesso le loro analisi a semplici impressioni soggettive.
LA MUSICA SENZA MELODIA
Un’altra conseguenza di questa democratizzazione è la crescente popolarità di brani che mancano di una struttura melodica e armonica ben definita. Molte delle produzioni odierne si concentrano più sulle parole e sui ritmi che sulla composizione musicale tradizionale. Questo non significa necessariamente che tutta la musica moderna sia di scarsa qualità, ma indica una tendenza verso una semplificazione che spesso sacrifica la complessità e la profondità emotiva della musica.
LA NECESSITÀ DELLO STUDIO
In conclusione, sebbene la tecnologia abbia reso più semplice l’accesso alla produzione musicale, la qualità e la profondità della musica dipendono ancora dalla dedizione e dallo studio. Per creare musica che duri nel tempo e per analizzarla con autorevolezza, non si può fare a meno di una solida formazione. Solo così si potrà evitare di “non tirar su un ragno dal buco” e contribuire realmente all’evoluzione del panorama musicale contemporaneo.

ESISTONO GLI ZOMBIE? A QUANTO PARE SÌ, E SONO PURE DROGATI

di Carmine Pizzino
Già nel 1880 lo scienziato Cotard, ci aveva informati di questa patologia che porta il suo nome: una patologia psichiatrica che induce il malato a credere di essere morto o di aver perso tutti gli organi interni. Bisogna aspettare il ventunesimo secolo per conoscere le loro cattive abitudini.
La “droga degli zombie” è un termine colloquiale utilizzato per descrivere una sostanza stupefacente che induce effetti estremamente debilitanti e pericolosi, dando l’impressione che chi la usa si comporti come uno zombie. Questo termine può riferirsi a varie droghe, ma una delle più comunemente associate è il fentanyl (desomorfina), un oppioide sintetico, con una formula chimica “allucinogena” C₂₂H₂₈N₂O, utilizzato principalmente in medicina già negli anni Sessanta per il trattamento del dolore grave e per l’anestesia, ovviamente con il giusto dosaggio. Gli effetti sedativi di questo oppiaceo sono circa 80 volte più potenti della morfina: sono sufficienti, infatti, appena 2-3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona. Il fentalyl è noto per i suoi effetti devastanti sul corpo, tra cui gravi danni ai tessuti, cancrena e necrosi, che possono portare alla decomposizione della pelle e dei muscoli, creando un aspetto “zombificato” nei consumatori. Altri effetti includono sedazione estrema, incapacità di provare dolore, e comportamenti disorientati o violenti.
In Italia, la droga degli zombie non ha avuto una diffusione vasta come in altri paesi, ma ci sono stati casi isolati di uso e traffico di questa e di altre sostanze simili.
È importante rimanere informati e sensibilizzare la popolazione sui pericoli di queste droghe estremamente dannose e sulle risorse disponibili per prevenzione e trattamento. In Italia, come in molti altri paesi, il fentanyl è disponibile solo su prescrizione medica e può essere acquistato legalmente solo in farmacia, previa presentazione di una ricetta medica specifica.
Acquistare fentanyl al di fuori di questi canali legittimi è illegale ed estremamente pericoloso. Il fentanyl venduto sul mercato nero spesso non è regolamentato e può essere miscelato con altre sostanze, aumentando il rischio di overdose fatale. Inoltre, l’uso non supervisionato di fentanyl può portare a gravi problemi di salute, dipendenza e morte. Per cui, evitate di assumere fentanyl e qualsiasi altra forma di droga; se proprio volete “zombificarvi”, fatelo ascoltando i Cranberries, “euforizzatevi” con la musica, lo sport, il cinema , i libri, il sesso, l’amore.
Si vive una volta sola, ma se si vive bene, una volta sola è abbastanza.
MAE WEST

IL SACERDOTE DEGLI OPERAI

di Alessandro Bocci
Quando le venne mostrata la fotografia del figlio assassinato, con l’abito talare sporco di fango e il viso deturpato, Marianna Popieluszko lo riconobbe a malapena. “Io non condanno nessuno, non chiedo la morte di nessuno. La cosa che mi farebbe più piacere sarebbe che gli assassini si convertissero. E, se tale sarà la volontà di Dio, vorrei vivere fino a quando verrà fissata la data della beatificazione”, commentò quella donna.
Nell’estate del 1980, le autorità della Polonia comunista introdussero drastici aumenti dei prezzi
dei generi alimentari. Gli operai dei cantieri navali di Danzica iniziarono a scioperare, guidati da Lech Walesa, il futuro fondatore di Solidarnosc, il sindacato libero. La protesta si estese all’intero paese, raggiungendo gli stabilimenti di Huta Warszawa, nella capitale. Gli operai chiesero che un sacerdote si recasse a celebrare la messa all’interno della fabbrica.
Inaspettatamente, venne scelto don Jerzy Popieluszko. Tra gli operai e il giovane sacerdote che usava il loro linguaggio si creò un forte legame e migliaia di loro presero a frequentare la messa nella parrocchia del quartiere di Zoliborz, quella di don Jerzy. Alle sue messe, le messe per la Patria, c’era una straordinaria atmosfera di preghiera. Lui parlava di amore, di coraggio, di solidarietà, di vincere il male con il bene, si soffermava sulla dignità del lavoro dell’uomo.
Un intero paese era sceso in strada e, per fronteggiare le proteste, l’Unione sovetica impose
alla guida dello stato il generale Jaruzelsky e la legge marziale. L’ordine instaurato a Budapest e a Praga doveva regnare anche a Varsavia.
Intanto alle messe di don Popieluszko partecipavano sempre più persone e il sacerdote rimase illeso da un attentato predisposto dai servizi di sicurezza polacchi. Gli operai decisero di
proteggere don Jerzy, fissando dei turni di guardia attorno alla sua abitazione, ma servì a poco.
Gli squadristi del regime lo arrestarono e, una volta che il sacerdote ritornò libero, lo sottoposero a minacce, perquisizioni, pedinamenti, infiniti interrogatori. Sul quotidiano Izvestija, voce ufficiale del governo sovietico, i padroni moscoviti fecero scrivere che don Jerzy, nelle sue omelie provocatorie, intendeva “distruggere l’amicizia fraterna fra Polonia e Unione sovietica”. Si trattava, evidentemente, di una condanna a morte.
Don Jerzy sentiva di non aver molto più tempo da vivere, il cappio degli assassini di stato si stava stringendo, ma non ebbe mai paura. Il 19 ottobre 1984 il sacerdote si recò a Bydgoszcz, una città non lontana da Varsavia. Quando si presentò in chiesa risuono’ un applauso e prima di iniziare la messa dovette calmare i fedeli. Quella volta non pronunciò l’omelia, ma svolse delle riflessioni sui misteri dolorosi del rosario. Mentre rientrava a Varsavia, la sua auto venne fermata da tre agenti del servizio di sicurezza polacco. Lo picchiarono con dei manganelli e lo rinchiusero nel bagagliaio della loro auto, dopo averlo legato. Il corpo, forse già privo di vita, venne poi gettato nella Vistola, nei pressi di Wloclawek. Don Jerzy aveva 37 anni.
La cerimonia funebre si tenne a Zoliborz. Di fronte ad oltre un milione di persone, il cardinale Glemp, da qualche tempo Primate di Polonia, riferendosi alla vita di don Jerzy, concluse l’omelia con le parole di san Paolo: “Ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore mi consegnerà in quel giorno”. Nessuno dei presenti aveva dubbi. Stavano dicendo addio ad un santo.
L’assassinio di don Popieluszko ebbe risonanza mondiale. Il presidente statunitense Reagan fu il primo a stringersi alla Chiesa polacca; dall’Italia giunsero, fra gli altri, i telegrammi del ministro degli esteri Andreotti e del senatore Piccoli, presidente della Democrazia cristiana. Prive di pudore e di senso del ridicolo, le autorità polacche cercarono di impedire a Giovanni Paolo II di recarsi sulla tomba di don Jerzy. Ma lo fecero invano: papa Wojtyla andò comunque a Zoliborz, si inginocchiò e abbracciò la pietra tombale. Poi disse alla mamma: “Madre, ci hai dato un grande figlio”. “Santo Padre, non l’ho dato io, ma Dio l’ha dato al mondo attraverso di me”, rispose lei.
Nel 1994, venne organizzato un pellegrinaggio a piedi da Varsavia al Monte delle Croci, presso la città lituana di Siauliai, per piantarne una che ricordasse don Jerzy. Il tragitto venne percorso da tanti suoi operai, quelli della Huta Warszawa.
Nel 1995, il cardinale Glemp istituì la commissione per la preparazione del processo di beatificazione di don Popieluszko. Nel 2009, Benedetto XVI emise il decreto che ne attestava il martirio per la fede. Don Jerzy era morto a causa del suo amore per Cristo e in comunione con Lui. Il 6 giugno 2010 il sacerdote polacco fu dichiarato beato.
Marianna Popieluszko era ancora viva. Il suo desiderio di vedere quel giorno aveva trovato accoglimento.

DIRITTI UMANITARI E DIRITTO PENALE
LA DICOTOMIA LEGISLATIVA

di Milena Ruffini
A salire sul banco degli imputati oggi DA, un cittadino maliano in carcere in misura cautelare da cinque mesi, con l’accusa di aver contribuito alla contraffazione di alcuni documenti validi per l’espatrio al fine di agevolare l’ingresso clandestino in Italia di alcuni connazionali.
AD veniva arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa in quanto ricercato nell’ambito di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica alcuni mesi prima.
A destare sospetto inizialmente era stato il fatto che risultassero delle anomalie nella prenotazione di biglietti aerei nella tratta Bamako/Milano Malpensa.
Nel suo bagaglio, prontamente sottoposto a perquisizione dalla polizia di frontiera erano stati rinvenuti diversi documenti contraffatti. Obbligatorio dunque l’arresto in fragranza di reato.
AD aveva ammesso l’addebito ma aveva fornito chiaramente la spiegazione del proprio agito. Aveva prestato il suo aiuto ad alcuni connazionali che stavano cercando di abbandonare il paese d’origine per fuggire dal regime terroristico imposto dalle autorità maliane per chiedere asilo politico in Italia.
La circostanze era dimostrata agli atti.
Tutti i cittadini maliani entrati in Italia con quei documenti contraffatti, al loro arrivo avevano immediatamente espresso alla Polizia di Frontiera l’intenzione di chiedere asilo in Italia ed avevano avviato le relative procedure.
La Costituzione e la vigente normativa in materia di diritto di asilo (D.Lgs N 25/2008) tutelano lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
L’Italia, in particolare, garantisce diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Dunque i cittadini stranieri che presentano richiesta di asilo politico sono da ritenersi inespellibili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito come i doveri di solidarietà non possano prevalere sugli obiettivi statali di controllo delle frontiere e dei flussi migratori proprio ad eccezione dei soggetti inespellibili.
Orbene il reato commesso da AD ad una attenta e coerente analisi dovrebbe ritenersi non penalmente perseguibile. Non è possibile per coloro che subiscono persecuzioni nel paese d’origine espatriare legalmente. La condotta che agevola l’ingresso dei richiedenti asilo andrebbe dunque, a parere di chi scrive, scriminata.
Tale principio solidaristico parrebbe già aver orientato il legislatore laddove all’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 286/98, nell’ambito del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha previso la c.d. “clausola umanitaria”, che scrimina la condotta di colui che abbia agito senza fine di lucro e per semplice spirito umanitario prestando le proprie attività di soccorso e di assistenza a cittadini stranieri in condizioni di bisogno introdottisi o stabilitisi illegalmente nel territorio dello stato.
Il legislatore qui ha dunque posto in essere una valutazione in termini di prevalenza dell’interesse alla vita ed all’integrità fisica della persona umana rispetto al bene giuridico dell’ordine pubblico tutelato dall’art. 12 del T.U. sopra citato.
Con riguardo al tema in esame, si ritiene necessario un intervento riformatore.
La questione è delicata e coinvolge la tutela di beni giuridici differenti e di pari dignità sociale ma, inevitabilmente, investe anche questioni di carattere politico.
Nell’ambito del giudizio di primo grado il Tribunale, in considerazione della difesa svolta, ha condannato AD per il reato contestato al minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche, sospensione condizionale e immediata scarcerazione.
Ci si auspica che i rimedi giurisdizionali previsti (ricorso in Appello e Cassazione) diano modo di far luce sulla questione e conducano conseguentemente ad una pronuncia assolutoria e chissà ad un inedito orientamento giurisprudenziale.

ATMI/ATMIYAN
La patria della tribù Atmî comprende le regioni montuose delle odierne Aleppo e Malatya-Sivas. Attualmente, vivono sparsi in località come Maraş, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya, Afrin, Kobani, Koçgiri, Elazığ, Erzincan, Sivas e Tokat. La loro popolazione attuale è di circa 2 milioni. Non è chiaro se abbiano legami con la grande tribù Atmaneki, che si estende su un’ampia area da Hakkari e Mardin fino a Urfa, Bitlis e Ağrı. Sebbene vi sia una somiglianza linguistica con gli Atmaneki di Ağrı, la differenza di accento mostra una notevole differenza rispetto agli Atmaneki di Bitlis. I curdi che vivono nel Khorasan e nel Caucaso provengono in gran parte dalla tribù Atmi.
Gli Atmi sono un ramo della Federazione Tribale dei Grandi Rishvan, che inizialmente era yazida. Successivamente, scelsero l’alevismo, ma recentemente alcune tribù Atmi sono state sunnizzate.
Parlano una delle lingue più antiche della storia, che è l’antenata dei dialetti curdi come Kurmanji, Zazaki, Sorani e Gorani, e che oggi è un dialetto distinto del Kurmanji. È quasi impossibile trascrivere questa lingua con gli alfabeti odierni. Questa lingua, che può essere considerata la fonte arcaica di tutte le lingue latine, è quasi in via di estinzione.
La tribù professa la fede Aluwi, che si pensa esistesse molto prima dell’Islam e che benedice la natura e le persone. Sebbene alcuni membri abbiano adottato l’Islam a causa delle tendenze politiche dei loro leader, hanno continuato a praticare le credenze e le tradizioni Aluwi nella vita quotidiana. Questa fede precede e ha influenzato lo yazidismo e lo zoroastrismo, che sono ancora praticati oggi.
Nonostante Pazarcık, dove vivono in gran parte, sia uno degli insediamenti più antichi della storia, la tribù Atmi era originariamente nomade. Pertanto, possiamo affermare che vivevano inconsapevoli dei curdi Mittani, degli Ittiti, dei Komagene che governavano la loro terra, di Alessandro Magno che attraversava il loro territorio con i suoi eserciti, e di Roma e persino degli Ottomani. Anche se gli Ottomani alla fine li costrinsero a stabilirsi, demolirono le case costruite per loro e continuarono la loro vita nomade. Entrarono in conflitto con lo Stato quando furono costretti a pagare le tasse, quando si tentò di espropriare le loro rotte migratorie o quando la loro libertà fu minacciata. Quando questi conflitti si risolvevano con la superiorità dell’altra parte, la tribù sperimentava divisioni e disgregazione dovute all’esilio e alle morti.

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE

di Libera Iannetta
Dal principio di eguaglianza al diritto al lavoro, dalla libertà sindacale ai diritti della persona, dalla
sovranità popolare ai poteri dello Stato. La nostra Costituzione tutela e governa la vita di ciascuno
di noi. Attraverso il controllo dell’applicazione dei principi stabiliti nella Costituzione, i cittadini sono
chiamati a custodire quella democrazia nata dopo vent’anni di regime fascista e cinque di guerra,
di cui uno e mezzo di guerra civile in cui gli italiani si sono odiati ed uccisi.
Proprio nel momento in cui 526.317 studenti sono impegnati negli esami di maturità, il disegno di
legge Calderoli sull’autonomia differenziata diventa legge dello Stato, minando dalle fondamenta le
linee disegnate dai padri costituenti della solidarietà e della dignità della persona umana, andando
a stravolgere i principi fondamentali dell’unità della Repubblica e dell’uniformità dei diritti personali
e delle prestazioni sul territorio nazionale. Un combinato disposto, quelli di autonomia e premierato
in questi giorni, che, nell’attacco alla Costituzione, torna a dividere quel popolo italiano prostrato
dalla dittatura e dalla seconda guerra ed esprime una deriva autoritaria figlia dell’indifferentismo
alla politica.
Se già Platone ne La Repubblica si chiede come organizzare le istituzioni in modo da impedire che
governanti cattivi o incompetenti, nel perseguimento di interessi particolari, facciano troppo danno,
nel suo celebre e sempre attuale discorso tenuto il 26 gennaio 1955 presso il Salone degli
Affreschi della Società umanitaria a studenti milanesi, Piero Calamandrei, che nella “Commissione
dei 75” aveva collaborato alla redazione della Costituzione italiana, ricorda che questa non è una
macchina che, una volta messa in moto, va avanti da sé. “Perché si muova bisogna ogni giorno
rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, […], la propria
responsabilità”. Come? Partecipando.

SBARRE DI ZUCCHERO. QUANDO IL CARCERE È DONNA IN UN MONDO DI UOMINI

di Aurora Marella
Anche questo mese prosegue il mio viaggio alla scoperta di un Paese che non si vede, che nasconde il suo viso tra i muri, nei luoghi più lontani dal centro, proprio perché non mostra esperienze facili, non si manifesta con i colori della leggerezza, non rappresenta una realtà digeribile, ma è come un pugno nello stomaco.
È una realtà critica perché ha a che fare con i diritti umani, con la dignità, con la coerenza tra le leggi e le pratiche.
È una realtà che costituisce il cambiamento che voglio imparare ad osservare, capire e accompagnare. Ho voluto gettare un piccolo filo di luce su una situazione tra le più velate, uno di quei contesti che, quando vengono scoperti, sembra di aver aperto il vaso di Pandora.
Parlo della vita in prigione, e in particolare, della vita in prigione al femminile e minorile, due anelli molto delicati.
Una frazione non prevalente di questa realtà ma presente con forza, delicata per tanti temi che coinvolge nelle sue sfaccettature sociali, culturali, personali. Una frazione a cui è necessario prestare attenzione e per la quale penso che scriverne sia un modo seppur piccolo e quasi trasparente per dare voce a questa filigrana di vita che non si sente, non si vede e quindi non si conosce. Ma esiste.
Le famose vicende di Ilaria Salis hanno toccato un punto del mio stomaco per cui ho sentito la necessità di cercare di capire come funzionasse il sistema carcerario in Italia.
Così ho potuto scoprire numerose attività che si occupano di vita in carcere. Che resti Vita.
Una semplice ricerca in rete mi ha posto di fronte ad un’associazione che si prodiga per diffondere la conoscenza della realtà della detenzione femminile: si tratta dell’Associazione Sbarre di Zucchero.
L’associazione nasce nel 2022 inizialmente come progetto voluto da alcune donne, amiche di D.H, una detenuta che si è tolta la vita durante lo sconto della propria pena, perché non vedeva il proprio futuro, non riusciva più ad immaginarlo.
Questa scena ha mosso i cuori e le mani di chi le era vicino per lavorare affinché il carcere non rappresenti una fine ma piuttosto un rinnovato inizio, come cita l’articolo 27 della nostra Costituzione.
Le persone detenute hanno bisogno di vedere concrete prospettive di rinascita e per questo agisce il progetto Sbarre di Zucchero.
Il progetto parte da Verona e raccoglie in fretta consensi e adesioni attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni divulgativi, progetti che entrino tra le mura della prigione e raccolta di beni necessari per la vita in carcere soprattutto delle detenute, anche beni per l’igiene personale che spesso scarseggiano.
E così in poco tempo arriva a creare altre due sedi, una a Roma e una a Napoli.
Sbarre di Zucchero intende dare voce a quelle situazioni dove la quotidianità delle persone in carcere ha bisogno di cura, a partire dalle piccole cose come un prodotto per l’igiene fino ad arrivare alle tematiche più delicate come la genitorialità, l’istruzione o il reinserimento lavorativo. Perché la quotidianità lì dentro può diventare un mostro se non si riescono a costruire delle prospettive concrete per ricominciare.
Sbarre di Zucchero lavora per il sostegno fisico, sanitario e psicologico guardando soprattutto il bisogno delle detenute e dei ragazzi di minore età, costruendo ponti solidi per il reinserimento sociale in un momento della vita in cui tutto è fragile, per non vedere solo vuoto e buio, ma concrete possibilità di riscatto, di realizzazione di sé, nel rispetto dei diritti umani. Lavora per creare conoscenza di ciò che rappresenta vivere nella realtà carceraria in cui spesso viene a mancare il soddisfacimento dei bisogni essenziali per il corpo e per la mente.
Lavora per creare comunità per formare reti di sostegno e azione concreta fuori e dentro i muri della prigione affinché i propri pensieri non diventino anch’essi muri insormontabili.
Lavora per creare prospettive per educare al miglioramento e predisponendo alla progettualità di una vita nella legalità.
Sbarre di Zucchero scrive e agisce, attraverso le mani di ex detenuti, avvocati, giornalisti e sindacalisti, testimonianze di esperienze di detenzione. Per fare luce per chi sta fuori e per chi sta ancora dentro.
Sbarre di Zucchero è una realtà che personalmente desidero conoscere più da vicino, così come un’altra realtà tutta milanese che interviene nel carcere di San Vittore e di cui scriverò, per chi vorrà leggermi, nel prossimo articolo.
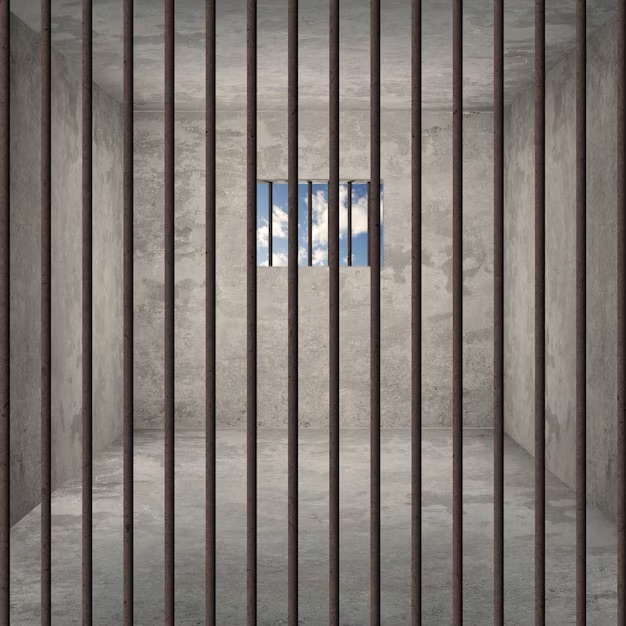
SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr.1

di Fabio Fumagalli
S’ciao bèlla gent. Me presenti: sont el Fabio e da parecchi anni insegno lingua milanese, la sua grammatica, le sue canzoni, la storia, modi di dire, ma anche indovinelli, attualità e curiosità… insomma tutt el bèll che el meneghin el gh’ha.
Scuola di Milanese, nata nel 1989, ha Sede nella Casa delle Associazioni (piazza Stovani) del Municipio 7. Una passione ereditata dai miei genitori Adriano e AnnaMaria che per anni, con i loro amici, portavano i loro spettacoli la domenica pomeriggio nelle Case di Riposo e inevitabilmente da me assorbita. Quando mi è stato proposto di scrivere qualche articolo milanese su “Nuove Cronache”, son staa pròppi content e speri che la rubrichètta la sia de vòster gradiment.
Parlarèmm de tanti ròbb in maniera semplice, dirètta come se fa tra amis. Ringrazi la Direzion che la me da quèsta possibilità e se avete qualche suggerimento, qualche argomento che vi piacerebbe approfondire, cercherò di accontentarvi nello spazio riservatomi. L’invito è anche di seguirmi sui social.
Ve spètti el mes che ven chì su “Nuove Cronache” e ve saludi cont ona vignètta.

E-mail: Fabio.Desdott@gmail.com
Youtube: Scuola di milanese di Fabio Fumagalli
Instagram e Facebook: Scuola di Milanese

LA DOMENICA IN ALBIS

di Luigi Filipetto
Volgarmente è Domenica in bianco. Il celebrante però l’ha spiegata meglio. È la prima domenica
dopo Pasqua. Bisogna andare ai primi tempi del cristianesimo. In quel giorno gli adulti deponevano
le vesti bianche indossate in occasione del loro battesimo.
Prima però merita uno sguardo la chiesa già mezza piena per il battesimo di quattro lattanti. È
presente anche l’osservatore per un legame di parentela con uno di questi quattro. Un vocio
generale riempie la chiesa. Il vocio si intensifica con l’arrivo dei ritardatari – attesi dai presenti girati
verso l’uscita – che aggiornano sullo stato di salute della famiglia, dei parenti e dei vicini. I fedeli
hanno l’età lucana o giù di lì, un bel gruppetto anche di bambini. Assente la fascia della ragione
critica. Comincia il viceparroco a chiedere silenzio, poi si arrende. Ci prova anche il cerimoniere e
intona un canto sperando che funzioni ma canta solo lui. Il cero sull’altare non si accende, il
viceparroco solleva il camice dai piedi e prende dalla tasca l’accendino. Ci prova anche il
sacrestano. Niente. Il parroco parla all’orecchio del vice e il cero viene portato dietro l’altare e
ritorna con la fiammella che danza la vita.
Il celebrante si rivela subito un abile comunicatore con parole e gesticolazione delle mani. Sorvola
sul come e il perché gli infanti abbiano preso il posto degli adulti per il battesimo.
“A che cosa rinunciate?”, chiede il parroco ai lattanti. Al peccato, rispondono i parenti, le madrine e
i padrini. “Che cosa chiedete?”, insiste. Il battesimo rispondono. E allora il battesimo. Finito il rito,
il parroco consegna una candela ai papà. I quali la accendono dal cero. Ora spegnetela e portatela a
casa, dice loro. Poi dice ai lattanti: ora tornate a essere figli di Dio. Il solito critico vorrebbe sapere
che cosa erano prima.
La prima questione del salto generazionale il critico si riserva di approfondirla su internet. Rimane
la più grossa. Il parroco fa una croce sulla fronte di ognuno degli infanti, “Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”. E a questo punto affronta il mistero dei misteri: la Trinità, Dio uno e
trino. Lo Spirito Santo soffia la vita di Dio, dice. Il critico dal fondo della chiesa vorrebbe
intervenire: cioè? I gesuiti, trasferitisi nell’alto dei cieli, hanno sudato e scritto tomi infiniti per
spiegarci com’è il Dio trino. Hanno anche scritto che dopo la morte avremo la grazia di vedere il
volto di Dio, ma si sono fermati lì.
L’invito del celebrante di scambiarsi il segno della pace annuncia che siamo verso la fine. La fila
davanti si sta girando verso il critico, che pronto si gira verso il banco dietro di sé. Vuoto.

SCAPIGLIATURA CHE MODA!

di Giorgio Righetti
In fondo alla strettoia della Passione, dalle parti del quartiere Monforte esisteva un ampio terreno noto come “l’Ortaglia di via Vivaio”, era né più né meno l’ortaglia di Casa Cicogna sulla quale fu in seguito costruito l’Istituto dei ciechi. Tutto il quartiere Monforte prima del 1870 era ricco di orti e giardini e la pace che vi regnava lo rendevano caro a molti artisti che vi avevano la casa e lo studio, costoro alla sera e in certe ore del giorno si radunavano all’osteria della Polpetta, che era all’angolo fra via Monforte e via Conservatorio, ideale punto di ritrovo per gli allegri e squattrinati artisti del movimento artistico e letterario della Scapigliatura, erano i contestatori dell’epoca con ampia opposizione alle decisioni altrui, ma con grande convinzione della loro superiorità intellettuale, particolarmente animati da spirito di ribellione e anticonformismo. L’ambiente più che dalle noiose discussioni sui problemi esistenziali era dominato dallo spirito e dalle burla dal gruppetto dalla fertile fantasia. La denominazione “Scapigliatura milanese”, era di Cletto Arrighi il milanese Carlo Righetti (1830-1906), giornalista, drammaturgo, lessicografo e soprattutto patron della letteratura lombarda e del rinnovato teatro dialettale milanese, che contendeva a Giuseppe Rovani la guida del movimento. Chi erano gli altri scapigliati: Iginio Tarchetti, Emilio Praga, Arrigo Boito, gli scultori Giuseppe Grandi, e Pietro Magni, il musicista Alfredo Catalani, il pittore Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni, Giovanni Carnovali detto “Il Piccio”, un nutrito gruppo di artisti tutto genio e sregolatezza che caraterizzò venti anni di vita milanese (1860-1880). Il Rovani primeggiava, sua era la battuta sulla statua di Leonardo Da Vinci su bozzetto dell’amico Magni inaugurata nel 1872: “Téll chì el tò monument: on liter in quàtter”. A sua volta subiva l’ironia di un brumista che lo incrociava, quello in carrozza e lo scrittore a piedi: “Mi fóo ona gran brutta vita, ma anca lù, scior Rovani…”. Autentici contestatori emarginati da ogni operante contatto con la società, sregolati per natura, gli scapigliati finirono in gran parte rovinati dal loro stesso temperamento: ll pittore Tranquillo Cremona morto per avvelenamento, causato dai subdoli solventi e dai colori che usava mescolare sul braccio. Giuseppe Rovani, rovinato da una vita sempre più sregolata e autodistruttiva, alcol e assenzio, Emilio Praga uno dei più alti esponenti della scapigliatura, morto in condizioni di miseria ucciso dagli abusi di assenzio, Giovanni Carnovali, annegato facendo il bagno nel Po, Alfredo Catalani e Iginio Tarchetti falciati dalla tisi, il pittore Federico Faruffini, suicida col cianuro, Daniele Ranzoni internato in un manicomio, Cletto Arrighi rovinato dal vizio del gioco. Rifiutando l’egemonia borghese, confondendo l’arte con la vita, gli scapigliati pagarono a caro prezzo la loro ricerca di autenticità, in quella Milano perbenista di fine ottocento.

LA CASA COMUNE EUROPEA

di Alessandro Bocci
Sconfitto il nazifascismo, il sogno di libertà, pace e solidarietà di De Gasperi, Adenauer e Schuman trovò un riscontro nel Trattato di Roma che, con la sottoscrizione di sei paesi, portò alla nascita della Comunità economica europea. Nel corso degli anni, altri stati entrarono a far parte della Cee e con il crollo del Muro di Berlino e la disgregazione dell’Unione sovietica poterono finalmente aderire anche le nazioni dell’Est europeo. A Maastricht si definirono i parametri necessari all’introduzione dell’euro e a Lisbona vennero stabilite le competenze dell’Unione europea, dei paesi membri e quelle condivise.
In un recente ed importante documento della diocesi di Milano si sottolinea che l’Europa non può essere solo uno spazio economico, che occorre rilanciare il dialogo ecumenico e che l’esercizio del diritto-dovere del voto è espressione dell’impegno dei credenti verso la casa comune europea. In gioco c’è l’idea di Europa che si desidera per il futuro.
Nonostante l’impegno della Chiesa (e di numerose associazioni laiche), continuano ad arrivare segnali di affanno dell’idea europeista e il fatto che cresca il numero di coloro che si oppongono ad una maggiore integrazione è sintomo di disagio diffuso. Esistono indubbiamente vari problemi, ma a crearli sono proprio quelli che li denunciano sguaiatamente, nazionalisti e xenofobi in primis. Per contrastare costoro occorre favorire il consolidamento e l’allargamento di quel demos, di quel popolo cioè che si riconosce in comuni diritti e doveri, che rappresenta il presupposto dell’unità europea.
Tante sono le sfide che l’Ue dovrà affrontare nei prossimi anni. I migranti dovranno essere accolti ed integrati, per arrivare ad usufruire delle nostre medesime opportunità. La triste e vergognosa pagina di un Mediterraneo trasformato in cimitero per uomini e donne che hanno avuto l’accadimento di nascere in luoghi devastati da guerre e cambiamenti climatici deve terminare per sempre.
L’Ue deve essere protagonista nel campo dei diritti, nel campo della politica internazionale, nel campo della sicurezza. In questo senso occorre favorire l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue, e nelle altre organizzazioni internazionali cui desidera far parte, e non lasciarla in balia dell’aggressore russo, come è stato fatto finora con un supporto oltremodo modesto. Putin sta compiendo in quel paese i massacri che aveva già dimostrato di saper fare in Cecenia. Lo si è visto, per esempio, a Mariupol e a Bucha. In favore dell’Ucraina occorre uno sforzo straordinario per arrivare ad una pace giusta, che non può corrispondere ad un suo smembramento e finlandizzazione, come ci ha ricordato tante volte il presidente Mattarella.
Per la realizzazione piena degli ideali posti a fondamento del Trattato di Roma, occorre dunque pensare la politica europea con un approccio sovranazionale. È lì la grande frontiera della pace e di quella libertà che, come ripeteva Dahrendorf, “non è mai un soffice cuscino sul quale ci si possa adagiare”.

LA SOLIDARIETÀ

di Giorgio Righetti
Più se ne parla e più il termine si fa equivoco. Non si tratta solo dell’evidente e odiosa ipocrisia con cui fanno sfoggio alcuni moralisti da acquasantiera, soprattutto perché assistono impotenti al dramma dell’immigrazione. Essere solidali per questi personaggi significa esprimere un sentimento benevolo, un sentimento che si esaurisce con qualche parola o tuttalpiù in qualche gesto caritatevole. Ben altro è l’insegnamento evangelico del farsi prossimo, di non poter esistere in se stessi se non in relazione con gli altri “io sono insufficiente e tu sei un necessario della vita”. Essere solidali non vuol dire esserlo a messaggi pubblicitari. Non essere solidali significa rompere le relazioni tra le persone, di qualsiasi etnia essi appartengano, di ogni estrazione sociale di cui siamo costituiti, un insieme di persone di menti, cui a volte vogliamo sfuggire. Se afferrassimo questo si moltiplicherebbero davvero le opere di solidarietà. Oltre che la vaccinazione contro il Covid, oggi ci vorrebbe una grande vaccinazione contro l’intolleranza e contro ogni forma di odio.

COMPLESSO ARCHITETTONICO DI VIA ASTESANI 39-45, MILANO. LE RAGIONI PER UNA TUTELA

di Maurizio Boriani e Fulvia Premoli
Premessa.
Sulla piattaforma URBANFILE del 27 marzo u.s. è stato pubblicato l’articolo: “Milano | Affori –
Nuovo destino per il ‘tamburello’ di via Astesani 47” (autore Roberto Arsuffi), che illustra il
progetto di trasformazione del ‘tamburello’ di via Astesani in una torre residenziale di 10 piani.
L’edificio fa parte di un complesso ormai storico del quartiere, di cui motiviamo qui di seguito la
nostra viva contrarietà all’intervento.
A nostro avviso, se da un lato è ragionevole concentrare l’edificato urbano attorno a un hub di
servizi pubblici per la mobilità quale il vicinissimo nodo di interscambio tra la MM linea gialla e le
FNM attestato alla stazione di Affori Nord, appare più che evidente che le alte volumetrie già
costruite nei dintorni in questi anni, cui si aggiungono le imponenti e massive torri in via di
completamento proprio a ridosso della ferrovia, sono un contributo più che consistente alla
logica di potenziamento immobiliare di tale posizione strategica.
La trasformazione del ‘tamburello’ nell’ennesima torre infierisce sul paesaggio urbano,
prendendo a prestito ed esautorando un brano di quartiere nato con una logica diversa, che ha
tuttora ragion d’essere. Ovvero: la costituzione di un sistema integrato di residenza e servizi
rivolto ai cittadini del quartiere.
Il fatto che il ‘tamburello’, nato con la finalità sopra citata, sia stato adibito a sede bancaria, poi
dismesso per 20 anni durante i quali fu anche temporaneamente occupato come “centro
sociale”, non ne motiva la trasformazione in residenza, laddove di questa esiste un’offerta già
esuberante – peraltro con il suo inevitabile corollario di traffico automobilistico.
Semmai dovrebbe essere, per l’amministrazione della città, Municipio 9 incluso, uno stimolo a
cercare partners per soluzioni di carattere socio-economico a favore del quartiere.
Le recenti note vicende del Comune di Milano rispetto alle modalità di concessione di permessi
di costruire senza un preventivo controllo del loro impatto sul contesto urbano tramite un piano
attuativo, rafforzano inoltre questa nostra valutazione critica.
La strategia inaugurata dal Comune di Milano per la Rigenerazione urbana, in particolare rivolta
alle periferie, potrebbe invece essere lo strumento con cui il ‘tamburello’ torni a essere un centro
di aggregazione sociale e di servizi pubblici.
Alleghiamo una relazione da noi inviata alla Sopraintendenza ai Beni architettonici e Ambientali,
a Italia Nostra e per conoscenza al Municipio 9 , con la quale motiviamo anche l’opportunità che
il complesso di via Astesani venga riconosciuto per il suo valore culturale, che giustifichi
ampiamente l’opportunità di una sua tutela.
Relazione per una proposta di vincolo.
Il Complesso di via Astesani 39-45 (Milano) viene progettato nel 1961 a nord del centro storico
di Affori in una porzione di territorio di estrema periferia, subito a sud del punto in cui l’antica
strada per Como incrociava a raso la linea ferroviaria, attraverso un passaggio a livello. A breve
distanza pedonale, ad ovest, si trovava la stazione ferroviaria di Affori.
Qui, in direzione est, si sviluppava la via Vincenzo da Seregno, una strada prevista dal PRG del
1934, che collega Affori con Bruzzano. La via, che costituiva anche il terminale della tramvia di
Limbiate, ha visto un intenso sviluppo edilizio negli anni ’50-‘60, con edifici di civile abitazione di
altezze comprese tra i 3 e gli 8 piani.
Complessivamente si trattava di un comparto urbano di scarsa qualità ambientale,
caratterizzato da condomini di modesto valore architettonico, privo di attività commerciali di una
qualche rilevanza, ma, al contempo, di grande accessibilità al trasporto pubblico.
I progettisti colsero l’occasione di realizzare un grande edificio porticato (9 piani fuori terra) che
venne a costituire lo sfondo della via Vincenzo da Seregno per chi entrava in Affori da est. Con
uno sfalsamento del corpo di fabbrica principale venne ricavata una piccola piazza, definita, a
nord da un edificio a pianta esagonale di 3 piani (il “Tamburello”).
Lo spazio del portico, pubblico, si sviluppa a zig-zag per circa 200 m. ed è previsto per ospitare
attività commerciali su due livelli a servizio dell’intero quartiere di Affori e non solo per attività di
vicinato. Per il Tamburello era originariamente prevista una destinazione commerciale
(“emporio”) di notevole dimensione (circa 2.000 mq., su tre livelli e garage sotterraneo). Una
variante del 1970 proponeva uno spazio commerciale integrato ad una “scuola” (di non definito
livello). Successivamente venne adibito a sede della Banca Nazionale del Lavoro. La piazza
prevedeva alberature d’alto fusto, sedute e pavimentazione in pietra.
L’ intervento testimonia la qualità di due delle figure più rappresentative del professionismo colto
milanese: Vito Latis è membro del Movimento di Studi per l’Architettura (MSA) dall’anno della
sua fondazione (1945), Gustavo, più giovane, risulta iscritto dal 1951. Vito ne è stato anche
presidente nel 1952. Per conto del MSA i due fratelli hanno partecipato alle commissioni per il
Piano Regolatore di Milano del 1953, occupandosi in particolare del regolamento edilizio e
sostenendo la necessità che si limitassero le densità volumetriche e si lasciasse adeguato
spazio al verde pubblico e agli spazi collettivi. Su questi temi i due fratelli pubblicarono anche
due relazioni in occasione dei Convegni sullo sviluppo di Milano (1959 e 1961: quest’ultimo è
proprio l’anno di avvio del progetto per il complesso di via Astesani).
Negli anni della Ricostruzione, il MSA ha svolto una importante politica culturale nel campo
dell’Architettura e dell’Urbanistica, promuovendo una valutazione critica di come il Movimento
Moderno stesse tradendo le sue origini riducendosi ad uno dei tanti stili architettonici
acriticamente adottati a livello internazionale (“International Style”) e divenuto supporto di una
edilizia speculativa che ne aveva cinicamente adottato i vantaggi economici della semplicità di
linguaggio e il disimpegno nel rapporto con il contesto storico ed ambientale.
Il grande contributo degli architetti milanesi associati nell’MSA e sotto la guida di E.N.Rogers e
della Rivista Casabella-Continuità, fu proprio quello di rapportarsi con la tradizione costruttiva
italiana e milanese in particolare. Celebri furono la polemica sollevata nel 1959 da Reyner
Banham (la “ritirata” e il “tradimento” degli italiani nei confronti del Movimento Moderno) e le
risposte degli architetti del MSA, non solo dal punto di vista teorico ma anche di quello
progettuale.
Proprio il complesso di via Astesani si caratterizza per un ricercato recupero della tradizione
costruttiva delle cascine del milanese (la struttura a vista) e per la contestuale attenzione per
difendere la necessità che l’architettura si confronti sempre, con il suo ruolo “civile”, sociale e
collettivo.
Qui i progettisti hanno saputo esprimere questo ruolo anche in un intervento di edilizia privata,
creando un centro di servizi e di aggregazione piuttosto raro nella periferia milanese dei primi
anni ’60, sulla linea di quegli interventi che venivano programmati dall’INA-Casa per l’edilizia
sociale e incentrati sul concetto di unità di vicinato e di stretta integrazione tra spazio
residenziale privato e spazio per i servizi collettivi e l’aggregazione sociale. Su questi temi i
fratelli Latis erano stati attivi, come ad esempio nel progetto per il concorso INA-Casa di Parma
(1953) e per il quartiere INA-Casa di Vialba (1957-59). Nell’intervento in via Astesani a Milano
hanno però certamente raggiunto uno dei punti più alti di queste loro sperimentazioni, ancor più
rilevante perché si tratta di edilizia di iniziativa privata. I disegni di progetto e i particolari
costruttivi studiati per lo spazio pubblico e per il “Tamburello” sono testimonianza dell’attenzione
che i Latis ponevano sulla qualità dello spazio pubblico.
In aggiunta alla bibliografia di riferimento pubblicata nella scheda di “Architettura in Lombardia
dal 1945 ad oggi” si veda: M.Baffa, C.Morandi, S.Protasoni, A.Rossari, Il Movimento di Studi per l’Architettura, Laterza, Bari, 1995.
Cliccando sul seguente link, è possibile consultare le foto del progetto originale e il rendering della nuova torre: https://blog.urbanfile.org/2024/03/27/milano-affori-nuovo-destino-per-il-tamburello-di-via-astesani-47/


VOLARE SULLA MOTO: UNA TERAPIA FUORI DALLE RIGHE

di Aurora Marella
Non è cosa usuale vedere una motocicletta in una corsia di un ospedale. Potrebbe sembrare un’invasione oppure un semplice spettacolo. Invece si chiama mototerapia.
In sella c’è Vanni Oddera.
Ma non è solo: tra le braccia porta un bambino ricoverato in ospedale e precisamente all’ospedale Gaslini di Genova.
Vanni Oddera è l’inventore della mototerapia.
Tutta la sua storia inizia in Russia nel 2008 dopo aver partecipato ad una gara di acrobazie con la motocicletta.
Trofeo ottenuto, lo aspetta la festa serale e per raggiungere la festa prende un taxi.
Nel taxi, un forte odore lo colpisce, si sporge in avanti per capirne l’origine e si accorge che l’autista non ha le gambe.
Da quel momento tutto cambia. Cambiano le prospettive, cambiano le idee, cambiano le priorità, cambia il senso di responsabilità, cambia la considerazione della vita e delle fortune che porta o toglie.
Quella sera, Vanni non andrà alla festa ma inizierà a creare quello che sarebbe diventato un importantissimo movimento di solidarietà e di attenzione verso il prossimo che si traduce nella mototerapia.
La mototerapia è una pratica e una tecnica dove si uniscono la capacità di governare perfettamente il mezzo in totale sicurezza e la possibilità di utilizzare questo mezzo per donare sensazioni uniche per quelle persone che sulla moto altrimenti non ci potrebbero andare.
Per sentire l’aria sulla faccia anche quando non c’è.
Da un episodio che sarebbe potuto giacere sterile in un angolo di ricordi collaterali fino a dissolversi, è, al contrario, nato un progetto di vita grazie alla scelta di non essere indifferenti, di voler contraccambiare la vita stessa delle opportunità che dona.
Vanni adesso ha una squadra che lavora con lui con l’obiettivo di portare sorrisi ed esperienze davvero a 360 gradi per tutti. Ha guidato la sua moto con a bordo piccoli pazienti nell’ospedale Gaslini e in tanti altri eventi di solidarietà e inclusione sociale.
Pratica la mototerapia in tutta l’Italia ma non si è fermato qui perché altri nuclei di motociclisti che si dedicano al comporre esperienze che superino ogni barriera esistono in tutto il mondo, come in Messico.
Numerosi sono i progetti in essere, studiati per arrivare da tutti. A casa, negli ospedali, in vacanza. Per portare avanti le iniziative, la squadra sta lavorando per creare una Fondazione.
Esperienze come queste, in grado di fare tanto bene e di coinvolgere molte persone, necessitano di una base legislativa. Per la tutela della gratuità del progetto. E per fornire corrette impostazioni e regole, impedendo cosìpossibili emulazioni.
In Parlamento c’è ora una proposta di legge che chiede il riconoscimento e la promozione della mototerapia o FMX Therapy (acronimo di Freestyle Motocross Therapy).
Si vogliono formalizzare le linee guida di questa pratica, renderle chiare e diffuse, sottese allo stesso principio di solidarietà.
L’equipe medica del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino ha pubblicato uno studio sull’European Journal of Integrative Medicine nel 2020: si afferma che grazie a questa terapia vengono ridotti la percezione del dolore e il livello di stress nei pazienti e in generale essa porta un aumento di emozioni positive.
Dove la moto può arrivare, il team di Vanni Oddera la porterà e, dove non può arrivare, la squadra troverà un modo. Un salto dopo l’altro.
Ringrazio Dario, assistente di Vanni Oddera, per il tempo dedicatomi per la preparazione di questo scritto.

L’INFLUENZA TRASFORMATIVA DELLA MUSICA NEL SOCIALE: UN VIAGGIO NEL TEMPO

di Giorgio Caporale
La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella società, riflettendo i cambiamenti culturali, sociali e politici.
Dagli anni 60 agli anni 90 , in particolare, sono stati periodi intensi per la musica di protesta, con grandi concerti e musicisti che usavano le loro voci per denunciare gli abusi di potere e le atrocità delle guerre.
Questi decenni hanno visto nascere icone come Bob Dylan, John Lennon e Bob Marley, che con le loro canzoni hanno sfidato l’establishment e hanno ispirato generazioni a lottare per un mondo migliore. Le loro parole e melodie sono diventate inno di resistenza, un modo per unire le persone e sollevare questioni importanti.
Tuttavia, nel corso degli anni, la relazione tra musica e protesta sembra essersi affievolita. Nonostante ci siano ancora guerre e ingiustizie nel mondo, la musica contemporanea sembra aver perso quel legame stretto con la realtà sociale.
Molti artisti di oggi sembrano indifferenti alle questioni globali, concentrando la loro attenzione su temi più personali o superficiali.
Questa distanza tra musica e attivismo può essere attribuita a vari fattori, tra cui l’evoluzione dell’industria musicale, la cultura delle celebrità e l’accesso illimitato alla musica attraverso piattaforme digitali.
Tuttavia, è importante riconoscere l’importanza di ristabilire questo legame, di utilizzare la musica come mezzo per sensibilizzare e ispirare il cambiamento.
Gli artisti hanno una piattaforma potente e influente che può essere utilizzata per portare avanti cause importanti e dare voce a chi non ha voce.
In un mondo sempre più connesso, la musica ha il potere di attraversare confini e unire le persone di diverse culture e background.
L’ascolto della musica ha subito profonde trasformazioni nel corso degli anni, riflettendo le mutevoli tendenze culturali e sociali. Nei decenni passati, molti generi musicali erano intrisi di messaggi di protesta e critica sociale. Il rock, il folk e il reggae, per citare alcuni, erano piattaforme per denunciare disuguaglianze, e ingiustizie in tutto il mondo.
Tuttavia, con l’avvento della musica digitale e l’esplosione delle piattaforme streaming, l’ascolto della musica è diventato sempre più frammentato e personalizzato. Mentre ciò ha permesso una maggiore accessibilità e diversità musicale, ha anche portato a una diluizione dei messaggi di protesta nei confronti delle ingiustizie sociali.
Oggi, la musica mainstream spesso riflette una cultura più orientata al divertimento, con temi dominanti come l’amore, la festa e il successo personale.
Anche se esistono ancora artisti che affrontano temi sociali, politici e ambientali, sono diventati una minoranza rispetto ai tempi passati.
La violenza contro le donne, i bambini e le popolazioni vulnerabili, così come le guerre e i conflitti, sono questioni urgenti che meritano attenzione e denuncia. Tuttavia, la loro rappresentazione nella musica contemporanea è spesso superficiale o assente, lasciando un vuoto nel panorama musicale in termini di advocacy e consapevolezza.
Nonostante ciò, esiste ancora speranza. Con l’aumento della consapevolezza globale su questioni cruciali come l’uguaglianza di genere, i diritti umani e la pace, c’è un crescente bisogno di artisti che utilizzino la loro piattaforma per educare, ispirare e catalizzare il cambiamento.
Guardando al futuro, speriamo che gli artisti riscoprano il potere trasformativo della musica e lo utilizzino per affrontare le sfide globali che ci attendono. La musica ha il potere di cambiare il mondo, e ora più che mai, abbiamo bisogno di voci coraggiose e impegnate che ci guidino verso un futuro migliore per tutti.
In conclusione, l’ascolto musicale ha subito una trasformazione significativa nel corso degli anni, ma la potenza della musica come mezzo di espressione e cambiamento sociale rimane inalterata.
Speriamo si possa riportare in primo piano le questioni sociali urgenti e utilizzare la loro arte per creare un impatto positivo sul mondo che ci circonda.

I LUPI NELLA MAFIA

di Carmine Pizzino
La licantropia è un concetto legato al folclore e alla mitologia, che si riferisce alla trasformazione di un essere umano in lupo o in una creatura simile a un lupo, nota come licantropo. Si tratta di un tema ricorrente nelle tradizioni di molte culture in tutto il mondo e ha ispirato numerosi racconti, leggende, opere letterarie e cinematografiche.
Nel folclore europeo, la licantropia è spesso associata a credenze e superstizioni riguardanti la capacità di determinate persone di trasformarsi in lupi, solitamente durante le notti di luna piena. I licantropi sarebbero in grado di assumere questa forma per attaccare e divorare le loro vittime.
La licantropia è stata ampiamente utilizzata anche nella letteratura e nel cinema horror, dove spesso è stata raffigurata come una condizione maledetta o come una forma di malattia mentale.
Gli uomini-lupo esistono davvero? c’è qualcosa di vero o è solo leggenda se non fantascienza? Può aiutarci la moderna scienza medica a darci una spiegazione?
Da una parte fa riferimento ad una ben definita sindrome genetica, nota come ipertricosi, che giustificherebbe la folta peluria di intere famiglie, dall’altra si pone l’accento più sugli aspetti comportamentali, talvolta gravemente psicopatologici, connotando una vera e propria malattia psichiatrica.
Ad oggi questa malattia è considerata rara, poco più di un centinaio di casi in tutto il mondo, e trova probabili spiegazioni in inserzioni cromosomiche a carico del cromosoma X (Pavone, 2015).
In medicina, il termine “licantropia clinica” può essere utilizzato per descrivere un disturbo psichiatrico raro in cui una persona crede di trasformarsi in un animale, compreso un lupo, o di essere diventata un animale.
Un’analisi globale della fenomenologia licantropica suggerisce dunque una genesi quanto mai varia che spazia dalla genetica alla malattia mentale in un continuum che va da forme attribuibili a disturbi della personalità fino alla psicosi maniaco-depressiva.
Ci sono alcuni casi storici documentati di persone che hanno sofferto di disturbi psichiatrici in cui credono di essere diventate licantropi o di trasformarsi in animali.
Peter Stumpp: Conosciuto anche come “Il lupo mannaro di Bedburg” è uno dei casi più noti di presunto licantropo. Nel 1589, a Bedburg, in Germania, Stumpp fu accusato di aver commesso una serie di omicidi e aggressioni, affermando di essersi trasformato in un lupo. Fu arrestato, torturato e giustiziato.
Jean Grenier: Un caso documentato risale al 1603 in Francia, quando un giovane pastore di nome Jean Grenier fu arrestato e processato per omicidio. Grenier affermò di essere stato morsicato da un lupo mannaro e di trasformarsi in un lupo durante la notte. Fu giustiziato per i suoi crimini.
Più recente e dei nostri tempi è il caso di Benedetto Santapaola, noto anche come Nitto, temuto boss mafioso considerato tra i più influenti e spietati di Cosa Nostra.
Nato il 4 giugno 1938 a Catania, è soprannominato “il Licantropo” a causa della sua rara condizione psichiatrica, la licantropia clinica. La licantropia clinica è una patologia che, secondo la leggenda, trasforma gli individui in licantropi, creature mitologiche che si tramutano in lupi durante le notti di luna piena.
La storia di Benedetto Santapaola è segnata da violenza, omicidi e una scalata al potere all’interno della mafia siciliana. Il suo soprannome, “il Licantropo”, evoca immagini oscure e misteriose, simili a quelle del leggendario lupo mannaro. Come un licantropo, Santapaola sembrava capace di mutare la sua natura da uomo a predatore spietato, lasciando dietro di sé una scia di sangue e terrore.

TRANQUILLO CREMONA E IL TEMPO DELLA SCAPIGLIATURA

di Giorgio Righetti
Era nato nel 1837 a Pavia da un padre funzionario dello Stato, ormai anziano. Un amico di famiglia il pittore bergamasco Giacomo Trécourt gli diede le prime lezioni di disegno e, dato che prometteva bene fu mandato all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 1859 venne a Milano e si iscrisse all’Accademia di Brera. A Milano abitava in via Arciboldi, ma poi avendo conosciuto altri pittori e scultori del movimento della SCAPIGLIATURA si trasferì in via Conservatorio per essere vicino a quegli artisti. Gli Scapigliati si riunivano solitamente all’Osteria del Polpetta all’ortaglia di via Vivaio, a quel tempo una strada campestre, dove tra una bevuta e l’altra decantavano versi e preparavano la loro rivoluzione culturale. Che Tranquillo Cremona fosse spiritoso per natura bastava leggere il cartello che aveva appeso all’ingresso del suo appartamento: “Gli amici sono pregati di lasciare tranquillo Cremona”. Tranquillo Cremona giocava spesso col suo nome, diceva: “Fossi ricoverato in manicomio mi assegnerebbero al Reparto Tranquilli”. Udendo una sua barzelletta un tale disse al pittore: “Incoeu te sett pussé, stupid del solit“. (Oggi sei più stupido del solito). E il Cremona di rimando: “L’è per podè, famm capì de tì” (È per farmi capire da tè). Dalla via Conservatorio fu sfrattato per inadempienze sul pagamento dell’affitto. Allora Cremona organizzò un trasloco, su un carro trainato da buoi che portava sopra degli strani tipi seduti su una catasta di mobili sgangherati, erano i suoi amici della SCAPIGLIATURA con barba e zazzera arruffata, che suonavano trombe, tamburi e grancasse. Era successo che Tranquillo Cremona volesse dare una lezione al padrone di casa il quale andava dicendo in giro che il pittore gli doveva un anno di affitto e che intendesse sloggiare di notte in punta di piedi. Cremona per smentirlo pagò fino all’ultimo centesimo (grazie a una colletta tra amici), poi organizzò un trasloco in pieno sole con tanto di accompagnamento di orchestra. Il nuovo studio fu in corso di Porta Nuova e li conobbe la studentessa di canto Carlotta Cagnoli che finì per sposare. Condizione di lei per il matrimonio una casa vera. Il Cremona la trovò in via Solferino con annesso studio. La sua avanguardia pittorica respinta dagli accademici conquistò le anime semplici. Molta gente corse da lui per farsi fare il ritratto. Cremona era ormai famoso disegnava perfino figurini di moda per testate di giornali (quella del Guerin Meschino notissima). Povero Cremona, morì ucciso dagli stessi colori che usava per i suoi quadri: invece che spalmarli su una tavolozza, lo faceva sulla mano e sull’avambraccio. I colori a base di piombo avvelenarono il suo sangue. I medici chiamarono questo saturnismo. Ma chi era Tranquillo Cremona, l’uomo che era morto perché le tinte di quei colori meravigliosi gli erano entrati nel sangue. Era stato un grande pittore, qualcuno disse addirittura il più grande pittore di Milano.

QUEGLI ANNI E LA MORTE INTORNO

di Luigi Filipetto
Il gioco delle biglie era il nostro passatempo. Le biglie più belle erano blu e lucide, però costavano. Due erano le tecniche del gioco per centrare la biglia avversaria o la buca, stringere la biglia fra il dito medio e il pollice e lanciarla con forza, oppure piegare l’indice, appoggiare la biglia e lanciarla con il pollice. Che rabbia quando la pallina si fermava sul ciglio della buca e il tuo compagno gridava brusega! Senza andare in bottega, ci si arrangiava con i gessi di scuola. Portarne a casa un pezzetto non era una grande impresa. Poi si tagliava un quadratino e lo si faceva girare sulla bocca dei bossoli di mitragliatrice già sparati fino a creare una pallina rotonda. Anche la caccia ai bossoli non era difficile. Ognuno ne teneva uno in tasca. Tua madre lo aveva trovato nella tua tasca insieme alla fionda quando arrivasti in casa senza il resto delle dieci lire spese per la farina e perduto per strada. Ci aveva pensato poi il parroco alla messa della domenica a reperire chi l’aveva trovato.
Tuo fratello scendeva di nascosto dal monte Cansiglio per cambiarsi e il suo mitra stava appoggiato sul davanzale della finestra. Quando poi non tornava da solo i mitra erano sulle sedie, sul comò, sul tavolo. Uno dei suoi compagni si chiamava Tigre. Lo seguivi con gli occhi incantati al mattino mentre si vestiva e spostava la tendina della finestra per vedere se fuori c’era calma. Tigre doveva essere immortale, ma poi ti venne la voce che era stato ucciso. Quell’altro invece era un prepotente e quando veniva in casa ti sbaraccava dal letto con la canna del mitra perché ci doveva dormire lui. Poi naturalmente cambiò bandiera.
Dove vai?, chiedeva il camerata a tua sorella con la canna del mitra puntata contro. Dove sei andata?, le chiedeva un altro con la stessa canna puntata, mentre tornava dalle parti del bosco, dove ogni tanto si sentiva di rastrellamenti. Lei non aveva bigliettini nascosti, riportava ai capi della resistenza messaggi vocali. Fermati!, aveva gridato un camerata nella piazza a uno che andava in bicicletta, puntandogli il mitra. Ma quello aveva continuato a pedalare. Il camerata lo aveva inseguito, ma in un cortile gli si era piantato contro un cane antifascista che non smetteva di abbaiargli addosso. Lo aveva steso con una mitragliata. Il prete l’aveva detto chiaro: si sentono forti perché hanno il mitra tra le mani.
Poi andavi a scuola, ma non passavi dalla piazza perché era pericoloso. Attraversavi il brolo dei vicini. Anche per andare dai nonni. Poi ti rimandavano a casa da scuola due a due, non tutti insieme, con la consegna di camminare spediti ma non correre. Tra l’altro era in agguato Pippo, quell’aereo che veniva dalle parti del Friuli e che buttava giù le bombe. Ti avevano detto che quando cadevano le bombe ti dovevi inginocchiare e posare la testa a terra coprendola con le mani e intanto muovere la schiena senza mai fermarti. Tu facevi così e piangevi con la puzza della bomba lì vicino. Se Pippo veniva di sera si spegnevano anche le candele.
Come si lanciavano le bombe a mano lo aveva fatto vedere quelloche abitava nella villa dei più ricchi del paese. Con i denti strappava la sicura e lanciava la bomba sul prato. Noi ci mettevamo le mani sulle orecchie. Gli altri bambini ti dicevano di informare tuo fratello che in quella casa c’erano i fascisti. Come se i partigiani non lo sapessero.
La morte vera ti era entrata dentro il 6 aprile del ’45 davanti a sei paesani fucilati dai fascisti fuori di casa tua. Il 25 di quel mese un ragazzo in bicicletta gridava che la guerra era finita, che eravamo liberi. Il peso della morte ti era uscito fuori, era come se i tuoipiedi non poggiassero per terra.

FINALE DI PARTITA

di Alessandro Bocci
Con una popolazione che andrà incontro a dimezzamenti successivi, dato che da due persone ne nasce mediamente poco più di una, e che a fine secolo è stimata essere circa 30 milioni, sarebbe stato logico aspettarsi che il Pnrr affrontasse il problema demografico italiano. Non essendo stato così, si deve concludere che nelle aule parlamentari non c’è la minima coscienza delle prospettive morenti della nostra popolazione. L’Italia, infatti, sarà fra i primi paesi al mondo a sperimentare il tramonto di una grande popolazione moderna.
Pubblicata nel 2021, un’indagine Istat disegna quello che sarà il nostro paese nel 2070. Pur considerando l’arrivo di 6,5 milioni di immigrati, i residenti scenderanno a 47 milioni. Il Nord (che beneficia dei flussi migratori provenienti dal Mezzogiorno) perderà il 12% dei suoi abitanti, il Centro il 18%, il Sud il 33%. Con un tale spopolamento il Meridione, che ha una natalità che scende a ritmi più sostenuti rispetto alle altre aree geografiche del paese, è destinato a spegnersi demograficamente. Sempre nel 2070, a fronte di un indice di vecchiaia del paese pari a 300 (3 persone sopra i 65 anni per ogni bambino con meno di 14 anni), nel Sud tale indice schizzera’ a 500, con punte di 600 nelle aree interne. A spaccare l’Italia non sarà l’autonomia differenziata (ammesso che venga approvata), ma la demografia.
Già nel 2040, le famiglie costituite da una sola persona o senza figli saranno il 61% del totale. I bambini che nasceranno ben difficilmente avranno fratelli, cugini o zii. Nella società verticale i bambini avranno solo nonni. Poi, nell’ipotesi che quei bambini non abbiano figli, le reti parentali si dissolveranno completamente.
Tra le tante altre cose, la glaciazione demografica metterà fine all’idea, decisamente naif, che piccolo è bello. Non saranno certo lo smart working e l’aria pura ad impedire il devastante tracollo, per altro già iniziato, dei piccoli comuni appenninici, con conseguente degrado fisico e ambientale.
Siamo ancora in tempo a sfuggire al nostro destino?
Qualche demografo particolarmente ottimista ritiene che per arrivare al punto di non ritorno debbano trascorrere una decina di anni. Ma siccome la società civile e il legislatore non hanno consapevolezza del fatto che il numero di coppie in età fertile è irrisorio e che continuerà ad abbassarsi nei prossimi trent’anni, possiamo concludere che non saranno approvate misure eccezionali a sostegno delle coppie che decidono di avere figli. In più, le valutazioni meramente economicistiche non sono quasi mai esatte. Non è affatto detto che il tracollo delle nascite sia causato da soli fattori economici. Potrebbe essere che nel nostro progetto di vita i figli non siano così importanti. Forse non li facciamo semplicemente perché non li vogliamo.
“La terra era deserta e disadorna”, è una citazione della Genesi apparsa in un saggio dedicato a queste problematiche. In demografia, il too big to fail non vale e il finale di partita della nazione italiana è, in tutta probabilità, già scritto.

STUDIARE MUSICA NEI CONSERVATORI vs CRESCERE PER STRADA: UN CONFRONTO GENERAZIONALE

di Giorgio Caporale
Nel mondo della musica, due percorsi distinti hanno sempre coesistito: quello accademico, tipico dei conservatori, e quello autodidatta, basato sull’apprendimento per strada. Mentre entrambi hanno prodotto talenti straordinari, l’approccio e le influenze che caratterizzano questi due percorsi sono profondamente diversi.
IL PERCORSO ACCADEMICO: CONSERVATORI E FORMAZIONE FORMALIZZATA
Nei conservatori di musica, gli studenti seguono un percorso strutturato che copre teoria musicale, lettura della partitura, storia della musica e tecniche strumentali. Questo approccio offre una solida base teorica e tecnica, permettendo agli studenti di affrontare una vasta gamma di stili musicali con competenza.
In questo ambiente, gli studenti hanno accesso a maestri esperti e risorse di alta qualità, che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità musicali. Tuttavia, il focus sull’apprendimento formale può a volte limitare la creatività e la spontaneità, poiché gli studenti sono spesso guidati da regole e convenzioni.
IL PERCORSO AUTODIDATTA: CRESCERE SUONANDO PER STRADA
Al contrario, molti musicisti cresciuti suonando per strada hanno sviluppato le loro abilità attraverso l’ascolto attento e l’emulazione degli artisti che ammirano. Questo approccio è spesso caratterizzato da una profonda passione per la musica e da un desiderio di esplorare e sperimentare nuovi suoni.
Artisti come Santana, Eric Clapton, Sting e Miles Davis sono cresciuti in un’epoca in cui la musica era meno accessibile, e l’ascolto di dischi era un modo principale per scoprire nuovi stili e tecniche. Questi musicisti hanno affinato le loro abilità suonando ad orecchio, imparando direttamente dalle registrazioni e dal vivo, sviluppando un orecchio musicale eccezionale e un senso intuitivo per la performance.
LA CONVERGENZA DEI DUE MONDI
Negli ultimi anni, con l’avvento della tecnologia e l’accesso illimitato alla musica attraverso piattaforme streaming e social media, i confini tra il mondo accademico e quello autodidatta si sono sfumati. Molti musicisti moderni, pur avendo una formazione accademica, hanno anche una profonda conoscenza e rispetto per i musicisti che sono cresciuti per strada.
Questa fusione di stili e approcci ha portato a una nuova generazione di musicisti che combinano la precisione e la tecnica dei conservatori con la creatività e l’innovazione dei musicisti autodidatti. Artisti come John Mayer, Jacob Collier e Esperanza Spalding sono esempi di musicisti che hanno abbracciato entrambi i mondi, creando un suono unico e distintivo che riflette la diversità e la ricchezza della musica contemporanea.
In conclusione, sia lo studio accademico che l’apprendimento per strada offrono opportunità uniche per gli aspiranti musicisti. Mentre i conservatori forniscono una solida formazione teorica e tecnica, la strada offre una scuola di vita musicale che insegna l’importanza della passione, dell’ascolto attento e della sperimentazione. L’importante è trovare il proprio percorso e abbracciare le diverse influenze che rendono ogni musicista unico.

IL GENE DEL SERIAL KILLER: REALTÀ O IRREALTÀ?

di Carmine Pizzino
Nel vasto panorama della genetica e della criminologia, il concetto del “gene del serial killer” ha suscitato un’ampia gamma di reazioni, alimentando dibattiti accesi e speculazioni sensazionalistiche. Ma quanto c’è di vero dietro questa idea? È possibile che alcuni individui siano predisposti geneticamente a commettere atti di violenza e omicidio in serie? In questo articolo, esploreremo il tema del gene del serial killer, analizzando le evidenze scientifiche e offrendo qualche riflessione personale su questa delicata questione.
Da un punto di vista scientifico, non esiste un “gene del serial killer” ben definito o identificato. La criminalità è un fenomeno complesso determinato da una vasta gamma di fattori, tra cui l’ambiente, l’ereditarietà, la psicologia individuale e le esperienze di vita. Mentre alcuni studi hanno suggerito una possibile associazione tra determinati geni e comportamenti antisociali, la relazione tra genetica e criminalità è estremamente complessa e non può essere ridotta a una singola variabile genetica.
Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che varianti genetiche associate a disturbi psichiatrici come la psicopatia o la schizofrenia potrebbero aumentare il rischio di comportamenti violenti, compresi gli omicidi in serie.
Scrive la dottoressa Silvia Pellegrini (Laboratorio di Biologia Molecolare, Dipartimento di Patologia Sperimentale, Biotecnologie Mediche, Infettivologia ed Epidemiologia, Università degli Studi di Pisa): “Interessante è il caso del gene che codifica l’enzima mono-amino ossidasi A (MAO-A) – enzima centrale nel metabolismo della serotonina, un importante neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione del tono dell’umore e nella modulazione del comportamento. Questo gene esiste in ben quattro varianti alleliche, due che comportano una maggiore espressione del gene stesso e quindi una maggiore attività enzimatica e due che invece hanno una ridotta espressione e quindi una ridotta attività dell’enzima. Si è visto che la tendenza a sviluppare comportamenti violenti è scarsa sia per gli individui che hanno un’alta attività enzimatica sia per gli individui che hanno un’attività enzimatica ridotta, se l’ambiente in cui sono cresciuti è un ambiente psico-sociale sano e protettivo. Se invece questi individui sono cresciuti in un ambiente malsano, che li ha esposti ad abusi e maltrattamenti fin dall’età infantile, ebbene i soggetti con la variante del gene che codifica per l’enzima a bassa attività mostrano una frequenza di comportamenti violenti significativamente maggiore degli individui con normale attività enzimatica. Dunque, possedere la variante allelica a bassa attività di per sé non determina lo sviluppo di un comportamento aberrante ma costituisce un fattore di maggior vulnerabilità ad eventi esterni avversi che può risultare nello sviluppo di un comportamento anormale”.
La cosa interessante del gene MAO-A è che esso è collocato sul cromosoma X. Pertanto, i maschi ne possiedono solo una copia, mentre le donne ne hanno due. Se dunque un maschio ha un allele del gene MAO-A che è correlato alla violenza, non ce n’è un altro che possa fare da contrappeso.
Le femmine invece possiedono due copie e quindi se anche possiedono un allele a rischio, ne hanno un altro che può compensarlo. Questa è la ragione per cui la maggioranza delle ricerche su MAOA si è concentrata sui maschi, e del fatto che gli effetti di MAOA sono stati rilevati in generale solo nei maschi.
Tuttavia, è importante sottolineare che la maggior parte delle persone affette da tali disturbi non diventa serial killer, e molti serial killer non presentano alcuna diagnosi psichiatrica.
Personalmente, ritengo che sia pericoloso e ingiusto generalizzare eccessivamente il ruolo della genetica nei comportamenti criminali. Mentre è importante comprendere il contributo della genetica alla predisposizione individuale, dobbiamo evitare di cadere nella trappola della determinazione genetica, che potrebbe portare a una stigmatizzazione e discriminazione ingiustificate di determinate persone o gruppi.
Inoltre, concentrarsi esclusivamente sulla genetica potrebbe distrarre dall’importanza di altri fattori cruciali, come l’ambiente sociale, l’accesso alle risorse, la salute mentale e il sostegno comunitario, che giocano un ruolo significativo nella prevenzione della criminalità e nella riabilitazione dei criminali.
In conclusione, mentre la ricerca sulla genetica della criminalità continua a progredire, dobbiamo affrontare la questione del gene del serial killer con una prospettiva equilibrata e scientifica. Dobbiamo evitare sensazionalismi e semplificazioni e lavorare insieme per comprendere e affrontare le complesse cause della criminalità, con l’obiettivo ultimo di creare società più sicure e giuste per tutti.
CHARLES MANSON: “La mia filosofia è: non pensare”.

UN QUARTO… NON UN BUON AFFARE

di Slobodan Fazlagic
In questi giorni è impossibile non notare un aspetto che si impone prepotentemente sui media: le elezioni. Non importa a quale livello. Arrivano a scadenze prestabilite. Sono, visti tecnicamente, sempre un appuntamento consueto, con leggere variazioni locali. Si parla di due possibili modelli, proporzionale e maggioritario, che implicano la traduzione delle preferenze dell’elettorato in una forma in cui si può arrivare a governare.
Soffermiamoci su due termini di sopra: “elettorato” e “governare”. Entrambi i termini sono così abituali che li diamo per scontati. Però…
Parto dal secondo termine. “Governare” nel vocabolario Treccani è definito come «reggere il timone» – 1. Manovrare un bastimento per dirigerlo secondo la rotta prestabilita, mediante l’impiego del timone… 2. Dirigere, guidare, condurre in genere: uno stato o reggere le sorti di uno stato, esercitando i diritti e le attribuzioni proprie del potere esecutivo… 3. Reggersi, provvedere a se stesso, comportarsi, regolarsi… 4. Custodire, curare, provvedere al necessario, al benessere, al mantenimento di persona e più spesso di animali o cose…
Ecco, credo che i politici da noi “designati” non rispecchino in pieno quella definizione, direi sacrosanta per quello che intendiamo come democrazia. Si limitanoprincipalmente alla prima parte del punto 2. – “guidare uno stato”, ma non completano la frase con “i diritti e le attribuzioni proprie del potere esecutivo”. Esecutivo! Una volta saliti al potere si sentono al timone e pensano di guidare una propria nave, non di seguire la traiettoria determinata dal popolo. Invece, sono gli esecutori, o dovrebbero esserlo, non i sovrani. Bisogna dire che la colpa non è solo loro; cavalcano il fatto che la gente continua con quel riflesso di sottomissione al potere ereditato dai secoli di monarchia sulle spalle… Dunque, gli esecutori, non igovernatori, ricordiamolo per concludere.
Invece, l’altro termine “elettorato” nel vocabolario occupa meno di una riga, due sole semplici parole: “Corpo elettorale”. E basta. Siamo sicuri che proprio sia “basta così”? Un corpo? Intero o alcune sue parti? Un organismo difficilmente funziona se il corpo non è integro. Per non parlare se mancano le parti importanti. Tuttavia, il nostro corpo elettorale, noi, lo diamo per scontato come non mutilato, non frantumato, anche se sappiamo che in realtà non è così. Lo riteniamo sempre un corpo.
Già da anni il nostro corpo si presenta alle urne camminando a stento, trascinando le gambe rotte e, tremando, usa una mano sola per scarabocchiare il segno sulla scheda. È sempre meno giovane. Si presenta a dare le direttive agli esecutori più o meno la metà del nostro intero organismo. Poi, si verifica che per motivi da chiarire, ma immagino per effetto dell’inerzia sociale e la quasi inevitabile rassegnazione dei delusi dopo il giro del voto precedente, le preferenze si assestino quasi a metà tra due principali schieramenti politici, tra i cosiddetti progressisti e i conservatori. Chiamati con nomi di partiti fantasiosi e/o ingannevoli, distribuiti a ventaglio tra cosiddette destre e sinistre senza poter capire bene a quali fondamenti sociali si riferiscano, perché in sostanza la nostra nave continua a galleggiare con compiaciuti capitani al timone. Cambiano le divise, però la ruota rimane ambigua. Supponendo che siano bravi, sulla base del mandato di quanti di noi? La metà di una metà, cioè un quarto. Un quarto? Già…
La democrazia, che vuol dire un paese guidato dalle indicazioni date dalla maggioranza dei cittadini, si è ridotta alla volontà di un quarto. Al tavolo dove siamo venuti a mangiare in quattro, uno solo decide il menù. Ma, poi paghiamo tutti. Ci siamo svenduti proprio male…

IL DISCORSO DI SCURATI SUL 25 APRILE E LA CENSURA RAI

di Francesco Maraia
“Il 25 aprile ci ricorda come anche le cose che oggi ci sembrano più scontate, in realtà, siano state combattute con coraggio e forza. Buona festa della Liberazione!”
Nell’arco della mia vita ho sempre fortemente condiviso i valori della Resistenza e dell’Antifascismo grazie all’educazione ricevuta della mia famiglia ed agli studi di Diritto Costituzionale tenuti durante il mio percorso universitario.
Quei valori sono alla base della Costituzione che garantisce i principi fondamentali del nostro Paese, come il Principio di uguaglianza, di democraticità ecc..
Quei principi sono vivi più che mai ma necessitano di un’attenta conoscenza e di una profonda condivisione.
Se penso alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione, considero un atto di estrema violenza la censura perpetrata nei confronti di Antonio Scurati.
Per tale ragione ho deciso di condividere il suo discorso sul nostro giornale dando il contributo ad un dibattito democratico con cui ci opponiamo ad ogni forma di censura del pensiero altrui.
«Lo attesero sotto casa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini»: così inizia il testo di Antonio Scurati cancellato dal palinsesto Rai, con un ricordo drammatico dell’omicidio Matteotti, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla morte.
«L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l’ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole. Si batté fino all’ultimo, come aveva lottato per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere. Lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro una fossa scavata malamente con una lima da fabbro. Mussolini fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell’infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito. Mentre giurava, il Duce del fascismo teneva i documenti insanguinati della vittima nel cassetto della sua scrivania.
In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l’omicidio politico di Matteotti; si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche, con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani, nel 1944. Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto. Sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due concomitanti ricorrenze luttuose – primavera del ’24, primavera del ’44 – proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica – non soltanto alla fine o occasionalmente – un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista. Lo riconosceranno, una buona volta, gli eredi di quella storia? Tutto, purtroppo, lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell’ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neo-fascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. Dopo aver evitato l’argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza: ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime (la persecuzione degli ebrei) senza mai ripudiare nel suo insieme l’esperienza fascista, ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini, infine ha disconosciuto il ruolo fondamentale della Resistenza nella rinascita italiana (fino al punto di non nominare mai la parola “antifascismo” in occasione del 25 aprile 2023)».
Conclude Scurati: «Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana».
Ricordiamo ai vertici Rai le parole citate da Pertini (falsamente attribuite a Voltaire) con cui riusciamo a spiegare a tutti il concetto di libertà di espressione: “Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente”.
Ricordiamo loro che la Resistenza, mediante forme diverse di lotta, attraverso la difesa della Costituzione ed il riconoscimento dei suoi principi fondamentali non è mai morta e che saremo sempre attenti affinché i suoi Principi fondamentali vengano rispettati ed attuati.
Buon 25 Aprile a tutti.

CONVIVENZA DI QUARTIERE

di Luigi Filipetto
Esistono a Milano più di un centinaio di gruppi social street. Già il nome dovrebbe aprire il cuore a una visione davvero social. A sognare una città effervescente, in cui vive la politica. Poi leggi nelle dichiarazioni di alcuni di questi gruppi che “il nostro gruppo non fa politica”. Qui casca l’asino. Purtroppo i partiti ci hanno fatto una testa così identificandosi con la politica. Sulle origini di questa parola non disturbiamo la storia, è un fatto comunque che essa ci dovrebbe movimentare non poco.
Noi siamo politica nella misura in cui viviamo e operiamo per amore della città. Un amore operativo che non ha nulla a che fare con il vogliamoci tutti bene. Che non è un soffio di aspirazioni, bensì uno sporcarci le mani e i piedi dietro ai valori che la gente si porta dietro. Si dice: non abbiamo gli strumenti per operare e poi nessuno ci ascolta. E’ tutto vero, anche perché bisognerebbe spendere un sacco di energie e spesso anche di soldini. Però non è il caso di fasciarsi la testa prima che sia rotta. Basta misurare le proprie forze e operare di conseguenza, l’importante è operare.
Certo, sarebbe bello un coinvolgimento reale da parte delle istituzioni con questi gruppi e in genere con i cittadini. Cosa che spesso e volentieri lascia a desiderare. Vedi il problema del verde, di San Siro, delle case popolari, dei mezzi di trasporto. Se in un quartiere un rudere di cinema deturpa la città per trent’anni, non solo raccogli firme ma chiedi che la nuova proprietà, che finalmente avvia la ricostruzione, riservi come riparazione allo sfregio uno spazio a uso del quartiere e della città, presagendo che alla fine ti trovi con un pugno di mosche. Ancora, se per esempio in un quartiere opera un mercato contadino, ci metti il naso perché sia davvero contadino e non una cosa a metà. Che venda prodotti di stagione, con prezzi non da gioielleria. Se non è così, fai notare l’incongruenza.
Gli immigrati sono la prova del fuoco del nostro livello sociale. Al massimo si guardano con gentilezza. E’ troppo fare il salto di qualità. Eppure sono come noi che ci riteniamo a casa nostra. Hanno gli stessi sentimenti, la stessa intelligenza, lo stesso cuore ma restano loro. Il salto di qualità è passare al noi nei fatti. Se ti capita di affrontare con loro l’abc della lingua italiana perché si possano sentire meglio a casa loro è come se avvertissi di crescere insieme. Se poi ti chiedono quattro mura o un letto allora ti scopri nudo.

“EL TOMBON DE SAN MARC”

di Giorgio Righetti
Dove l’acqua del Naviglio presentava profondità diverse e correnti d’acqua, o era alimentata da altri canali, si verificavano pericolosi gorghi e mulinelli, che risucchiavano qualsiasi cosa o persona che cadesse al suo interno, i milanesi chiamavano “tombon”. Due erano a Milano i “tombon” più famosi, uno era quello di S. Marco, dove l’acqua formava malefici gorghi, un’altro era quello di Viarenna, (via Arena), sotto il bastione della Porta Ticinese. Il “Tombon de San Marc” era considerato il più spaventoso, era qui che i milanesi stanchi della vita andavano un giorno a cercar pace e riposo sperando in un mondo migliore, era qui che il Naviglio restituiva talvolta i cadaveri di suicidi e vittime di delitti, mentre altri candidati suicidi abitanti dall’altra parte della città ricorrevano per comodità loro al Tombone di Viarenna. La Martesana proveniente da Gorla, percorreva l’attuale via Melchiorre Gioia e dopo una serie di semicerchi nella città, passava sotto il Bastione dei Gonzaga (attuale Bastione di Porta Nuova), in questo punto preciso era “El Tombon de San Marc”, era qui che il Naviglio dette origine a assurde leggende, c’è ancora chi sostiene che aver coperto il Tombone non sia servito a placare gli ospiti dell’antico cimitero presente un tempo nella zona. Poco oltre questo tratto si trovava (e si trova tuttora), la “Conca dell’Incoronata”, che prende il nome della vicina chiesa e che fu nota anche come “conca delle gabelle” perché in quel punto adibito all’ingresso di merci in città si riscuoteva il pagamento delle tasse sui trasporti. Riccardo Bacchelli scrisse: “Ragazze tradite e uomini disperati venivano ad annegare nelle acque del Tombone le pene d’amore e della disperazione”. Tuttavia oggi sono in molti a credere erroneamente che il “tombon de San Marc” fosse in corrispondenza tra le attuali vie S. Marco e Montebello, punto in cui vi era l’accesso delle acque del Naviglio Martesana a Milano e il collegamento di queste con il sistema della cerchia interna. Chi sa però a quel tempo quanti infelici avrebbero cambiato idea se invece di trovarsi sottomano il falso Tombone avrebbero dovuto andare a cercare il vero Tombone tanto più lontano per il loro insano proposito. Sarebbe stato utile collocare un cartello con tanto di freccia che indicasse che l’autentico tradizionale Tombone fosse molto più indietro, nel punto che ispirò a Filippo Turati la sua poesia “Il Tombone di San Marco”: “Sul gorgo viscido / chiazzato e putrido / sghignazza un cinico raggio di sol…”.

LA STAZIONE CENTRALE DI JR

di Giulia Farinella
Durante la Design Week appena trascorsa, la Stazione di Milano Centrale si è trasformata in un’inedita vetrina di arte accessibile a tutti con due installazioni: “La Nascita” di JR, visibile fino al 1° maggio, e la mostra “An Invitation To Dream”, aperta al pubblico solo durante la settimana del Fuorisalone. Le iniziative hanno ridefinito gli spazi della stazione: a viaggiatori affannati e orari scanditi si sono uniti cittadini incuriositi in grado di farsi coinvolgere da un paesaggio inaspettato e insolito.
In Piazza Duca D’Aosta è possibile ammirare l’opera di JR, artista francese diventato famoso in tutto il mondo grazie alle sue suggestive installazioni artistiche a metà strada tra arte urbana e fotografia. Palazzo Strozzi a Firenze e Palazzo Farnese a Roma sono gli edifici italiani che JR ha già fatto “vibrare” grazie alle sue potenti illusioni ottiche. Con “La Nascita”, l’artista parigino crea un’installazione stampata direttamente su pannelli di alluminio che, attraverso uno squarcio surreale, apre la facciata della stazione catturando gli spettatori e invitandoli a interagire con l’opera.
L’installazione, come spiegato dallo stesso street artist in un’intervista a Vanity Fair, richiama il Traforo ferroviario del Sempione e quindi il tema delle connessioni e della natura. Il traforo divenne un importante snodo di merci e persone e permise di collegare direttamente la capitale francese con Milano.
In seguito all’apertura del tunnel iniziarono i lavori per costruire la nuova stazione ferroviaria milanese. La prima pietra fu posata il 29 aprile del 1906 in occasione dell’Esposizione Internazionale di Milano: anche allora la città meneghina si preparava ad accogliere visitatori da tutta Europa, accorsi per visitare più di 220 edifici provvisori (dei quali è rimasto in piedi solo quello dell’acquario civico) che ospitavano padiglioni italiani e stranieri sul tema del trasporto, del progresso e della velocità.
Se all’esterno è possibile dialogare con l’opera d’arte di JR, domandandosi dove porti quel tunnel che divide in due parti Stazione Centrale, all’interno le suggestioni proseguono con il progetto “An Invitation To Dream”, realizzato da Moncler e curato da Jefferson Hack, che esplora il tema del sogno e ci invita a sognare insieme a figure di spicco della cultura contemporanea internazionale. Attraverso cartelloni e schermi pubblicitari collegati, la mostra crea un paesaggio virtuale animato da immagini e citazioni, in cui testi e ritratti si mescolano al rumore costante della stazione, evocando un’atmosfera di viaggio e sogno.
Insomma, al centro c’è la Milano del Fuorisalone, metropoli internazionale del design, che per una settimana ha dato spazio a idee, creatività e visioni del futuro grazie a un susseguirsi di eventi, mostre e dibattiti.

PIC PRONTO INTERVENTO CLOWN

di Aurora Marella
Non sono ancora riuscita a visitare la scuola di clown questa settimana ma penso che lo farò molto presto. Questa scuola si trova nel quartiere Isola, uno dei nuovi cuori della città di Milano. Qui la vita scorre frenetica come un flusso sanguigno dopo una folle corsa. Ma in questa scuola si impara a contrastare questa fretta che spesso ci fa perdere di vista i riferimenti importanti: questa scuola insegna a percorrere la vita con una filosofia con cui poter conferire un’impronta benevola alle esperienze, in tutto il loro aspetto umano, lento, attento, sensibile. D’altronde, un clown non può andare di fretta.
Non sono ancora riuscita a visitare la scuola di clown ma ho potuto assistere ad un gruppo di clown all’opera, da lontano, da un angolo della strada in Piazza Tito Minniti, sempre nel quartiere Isola. Piccoli e grandi omini con la tuta bianca e la faccia dipinta difendevano l’area dal parcheggio selvaggio. La difendevano a colpi di naso rosso, sferzate di frasi di quelle che ti lasciano a bocca aperta e non sai cosa dire e frecciatine impertinenti che non possono non far sorridere chi osserva e soprattutto obbligano alla riflessione pur mascherandosi da battute comiche. Il tutto accompagnato da numeri di giocoleria, clowneria e acrobatica.
Questi sono i PIC, Pronto Intervento Clown.
I PIC operano a cuore aperto in una Milano che ha bisogno di aggregazione sana in cui lo stupore torni ad insegnare. Giocano sui contrasti della vita, sulle macchiette umane, sul senso civico da tenere a mente, sulla gioia di vivere, sulla gioia di dare.
Un po’ di storia dei PIC. Anzi, un po’ di Storia, perché i PIC che per primi ebbero la geniale intuizione che un clown è in realtà un supereroe furono Dario Fo e Leo Bassi che, insieme a Maurizio Accattato, nel 1993, al Piccolo Teatro di Milano diedero inizio a questo percorso.
Oggi Maurizio Accattato, in arte Morris, l’ideatore dei PIC, è il Direttore Artistico del Milano Clown Festival dal 2006, anno della prima manifestazione che da allora si tiene ogni febbraio colorando Milano di tendoni a strisce e oltre cento spettacoli dislocati in più punti della città, dal centro alle periferie.
Morris è sempre presente nella scuola di arti circensi e clowneriasituata nel quartiere Isola. Insegna e impara insieme ai clownallievi a ridere della vita affrontandola con la coscienza di chi la vuole indagare profondamente dentro di sé per portare la propria energia fuori da sé.
La pedagogia a cui si riferisce il clown Morris è questa: scavare i propri pensieri per scoprire il clown interiore, quello capace di trasformare ed equilibrare le forme della vita in qualcosa che doni un pezzo di se stessi, contribuendo al percorso di qualcun altro.
Vari sono i progetti che la scuola porta avanti. Oltre al Milano Clown Festival che arriva puntuale ogni febbraio per scaldare l’inverno, c’è, per esempio, la festa del circo Tagadà-Tagadà-Tagadà (in piena estate): il tendone colorato appare nei giardini dei quartieri periferici cittadini con parate, trapezi e giochi per otto pomeriggi e spettacolo finale di tutti gli allievi. E in primavera viene organizzata la festa del nuovo circo.
Ogni momento dell’anno è accompagnato dai colori e dall’allegria dei PIC.
Poi la scuola organizza corsi di arti circensi per operatori sanitari. Questa attività inizia a Bellinzona in una casa per anziani nel 2002per poi diffondersi in altri centri. Portare sorrisi per sostenere, la clownterapia.
Il clown risponde alle dinamiche nuove della società che va di fretta, che trascura e si desensibilizza proponendo formule magiche fatte di ironia, gioia, attenzione. Una missione per diffondere pace e allegria e colori.
La scuola è per tutti e le materie di studio sono clowneria, arti circensi, acrobatica, giocoleria. Per imparare a costruire un equilibrio nuovo e rinnovato tra tutti i mondi interiori che ci appartengono e il Mondo che ci accoglie fatto di mani, voci, pensieri e tutti i sorrisi che si possono donare.

IL METEOROLOGO DI SARAJEVO – di Libera Iannetta e Slobodan Fazlagic

di Simona Dolci
Questa storia parla di una città e dei suoi abitanti, di vicende collettive che si intrecciano ai ricordi di un suo cittadino. La città può sembrare solo uno sfondo, ma è in realtà uno dei tanti cuori pulsanti di questo intenso romanzo; potremmo definirlo come il primo cuore, quello all’origine di tutto.
“Sarajevo, ljubavi moja – amore mio.” La radio la trasmetteva senza sosta in quel giorno d’aprile, il giorno in cui quel cuore si è trovato nel filo spinato, stordito da un odio che mai gli era appartenuto. É in questa cornice stravolta dal conflitto che si muovono i ricordi del protagonista, tra le strade e gli angoli di quel cuore originario, nella “città più bella del mondo, dove il cuore del mondo arde senza però estinguersi”’, citando una lettera di una ragazzina piena di amore e nostalgia per la sua città lontana e perduta.
Questo cuore che arde senza estinguersi, proprio come la “fiamma eterna” in via Maresciallo Tito, è lo stesso di Boban, il meteorologo protagonista di questo racconto. Un cuore gemello e in ascolto quello di Anna, presenza discreta e fondamentale. Tanti altri cuori, tanti altri volti ed un’unica, viva Sarajevo trovano spazio in queste pagine. Pagine sincere, nate dal lucido ricordo di chi ha attraversato quel tempo oscuro e non si è lasciato trascinare nel fango, ma ha cercato riflesse nelle pozzanghere nei buchi lasciati dalle granate frammenti di stelle, come il ragazzo innamorato e mai vinto celebrato e ritratto dal poeta Tony Harrison in “The Bright Lights of Sarajevo”.
Chi ama questa città non può che essere rapito da questo racconto forte ed allo stesso tempo gentile di un uomo che affida i suoi ricordi allo spazio bianco e discreto delle lettere, agli occhi limpidi e sinceri di chi le saprà leggere e portare nel mondo. Attraverso lo sguardo mediato da Anna il lettore arriva al cuore della storia, al suo messaggio universale di convivenza pacifica, alla comprensione delle profonde ragioni che spingono l’uomo a non arrendersi alla violenza e alla paura e a cercare riparo nella dignità, nella condivisione e nell’intima essenza di ciò che significa davvero essere umani.
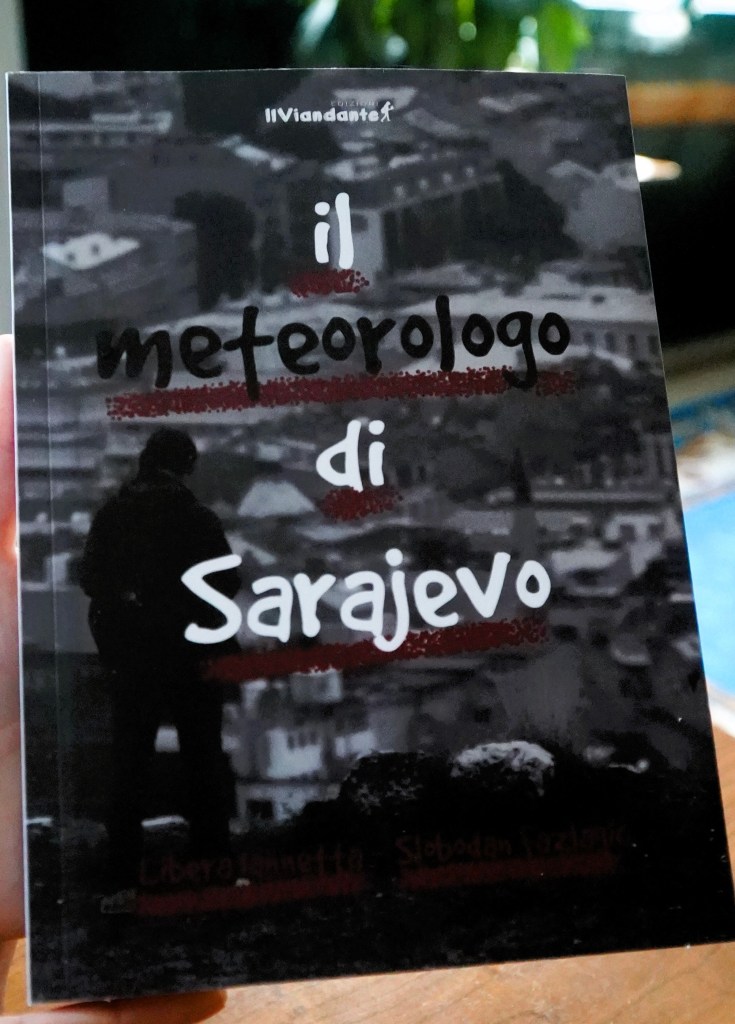
TRICKLE DOWN ECONOMICS
di Alessandro Bocci
L’economia del gocciolamento, secondo la quale l’acqua che viene versata sulla cima di un albero scende verso il basso beneficiando tutti, continua ad avere convinti sostenitori.
Ma procediamo con ordine.
Adamo Smith, nella sua Glasgow, ad uno stato che tassava e spendeva molto ne preferiva uno che tassava e spendeva poco. La mano invisibile, regolando l’economia, avrebbe risolto ogni problema. Negli anni trenta del secolo scorso, dopo la Grande Depressione, sulla base delle idee di Keynes, il livello di tassazione, che in quel periodo si basava sul reddito complessivo, iniziò ad aumentare. Verso la fine degli anni settanta nelle socialdemocrazie europee, le aliquote più elevate raggiunsero, nello scaglione finale, il novanta per cento. Ciò equivaleva, evidentemente, ad una sostanziale espropriazione della parte più alta del reddito. Poi, negli anni ottanta, negli Stati Uniti, Reagan si impose stravincendo le presidenziali contro i candidati democratici Carter e Mondale. Su un tovagliolo di un ristorante di Washington, ora conservato presso il National Museum of American History, Arthur Laffer, che insegnava nelle università californiane, tracciò la sua nota curva, una parabola con concavità rivolta verso il basso, secondo la quale, ad un certo punto, se si aumentano le aliquote fiscali il gettito diminuisce in quanto viene meno la propensione a lavorare e a guadagnare. Nasceva così la supply side economics (o trickle down economics). Durante la presidenza Reagan l’economia volava, ma probabilmente ciò non era legato alla diminuzione delle imposte nel frattempo introdotta. Ad ogni modo, negli Stati Uniti l’aliquota più elevata scese in modo considerevole fino ad attestarsi intorno al 37 per cento. Partendo dal Nordamerica la riduzione delle aliquote fiscali si estese anche all’Europa. In più, la tassazione complessiva del reddito venne sostituita con un modello, il dual tax income, che prevedeva aliquote ridotte per i redditi da capitale. L’azimut della trickle down economics è oggi rappresentato dalla flat tax, la tassa piatta uguale per tutti, adottata anche da alcuni paesi europei e sostenuta in Italia da alcune formazioni politiche di ideologia sovranista.
Ma tutto ciò funziona davvero?
Sembrerebbe proprio di no.
Chiarito che livelli di tassazione troppo elevati, come quelli in vigore verso la fine degli anni settanta, sono probabilmente dannosi per l’andamento economico generale, il Fondo monetario internazionale sostiene che non vi siano evidenze empiriche che il tagliare le tasse ai ceti più abbienti abbia effetti positivi sulla crescita dell’economia, sui conti pubblici e sulla qualità di vita dei più poveri.
Perché allora se le disuguaglianze aumentano e il gocciolamento è inconsistente si continuano a sostenere queste teorie?
In un suo libro, l’economista Carlo Cottarelli riferisce di un’ipotesi in base alla quale, attraverso attività di lobbying e di accesso ai mass media, gli individui più ricchi riescono ad assicurarsi una forte influenza politica. In sostanza, se ben finanziate e remunerate certe teorie possono trovare le loro infrastrutture, i famosi think tank, di intellettuali ed esperti. Difficile non essere d’accordo con quanto riportato da Cottarelli, la natura umana la conosciamo tutti.

LA DIASPORA KURDA IN ITALIA
di Nurgul Cokgezici
La diaspora kurda in Italia ha origine negli anni ’90, soprattutto tra i Kurdi di Bakur, con la maggioranza proveniente da Pazarcık. Questa comunità ha subito discriminazioni e oppressioni da parte del governo turco, tanto che alcuni sono diventati riluttanti a discutere della politica turca nei confronti dei Kurdi. Alcuni si sono addirittura alleati con istituzioni turche come DITIP (L’Unione turco-islamica per gli affari religiosi è una delle più grandi organizzazioni islamiche) o Consolati, forse a causa di una forma di sindrome di Stoccolma sviluppata come meccanismo di sopravvivenza psicologica.
La diaspora kurda in Italia conta circa 6000 persone, molte delle quali sono lavoratori instancabili e alcuni sono diventati importanti imprenditori. Hanno una forte presenza nel settore del Kebap, controllando sia la produzione in fabbrica che la gestione dei ristoranti. Dal punto di vista economico, si tratta di una comunità benestante.
Nonostante non siano assimilati, potrebbero essere considerati una comunità estranea alla propria realtà a causa della costante paura e intimidazione che subiscono.
È interessante notare che, nonostante non si assimilino completamente e non possano essere se stessi, i Kurdi conducevano una vita relativamente autonoma nei villaggi di montagna, nonostante le difficoltà causate dalla mancanza di contatti con la città e il governo. Il loro relativo successo è davvero ammirevole.
Per le giovani generazioni, non voler accedere alla vita accademica, rimane un grave ostacolo. Tuttavia, per loro, l’Italia rappresenta un’opportunità significativa. La similitudine linguistica e culturale ha contribuito a superare più facilmente il trauma della migrazione o a ridurne l’impatto.
Inizialmente, sono stati principalmente giovani uomini coraggiosi a raggiungere l’Italia, poiché non avevano le risorse economiche per emigrare nel nord Europa. Le famiglie hanno cominciato ad arrivare nella metà degli anni ’90. Durante quegli anni, Milano contava diverse decine di bambini di origine kurda.
Col passare degli anni, la comunità kurda è cresciuta e si è consolidata, ma rimane molto chiusa e poco conosciuta al di fuori di essa. La principale ragione del suo distacco dalla vita politica è la presenza attiva dei servizi segreti turchi in Europa. Spesso i Kurdi investono nella loro terra d’origine, Bakur, possedendo case e terreni e mantenendo stretti legami familiari. La paura di essere perseguitati li costringe a negare la propria identità kurda, persino in Italia.

SUL CONCETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA
di Melissa Idonia
Esiste un dato evidente e indiscutibile con cui ogni scuola e ogni didattica devono necessariamente fare i conti quando intraprendono un percorso inclusivo. Questo dato è rappresentato dal fatto che gli studenti sono tutti diversi: diverse le forme di disabilità, differenti i quozienti intellettivi, le specificità del carattere, le appartenenze familiari, etniche e culturali. Tali manifestazioni differenti della diversità hanno evidenziato nel corso degli anni l’inadeguatezza del modello di istruzione standard basato sull’idea di “non fare differenze”, aprendo invece la strada al processo di personalizzazione. In base a quest’ultimo, non trattare tutti allo stesso modo è l’unica scelta per garantire a ciascuno studente gli stessi diritti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la didattica, sia sul piano teorico sia sul piano metodologico.
Non fare differenze significa, in un certo senso, puntare alla normalizzazione delle diversità, appianare le divergenze; personalizzare significa invece accogliere le differenze, partire da esse per trasmettere l’unicità preziosa e irripetibile di ciascuno.
In questo senso, il concetto di inclusione viene a coincidere con l’allargamento di ogni orizzonte di senso statico e immutabile. Se il rapporto intersoggettivo è un rapporto tra storie che non possono in linea di principio essere identiche, favorire l’incontro e l’inclusione significa favorire uno spazio in cui è possibile ascoltare e accogliere l’alterità.
La filosofia ha dato un importante contributo teorico al concetto di inclusione: da Husserl a Gadamer, passando per Heidegger, il tema dell’alterità come condizione di possibilità per ristrutturare significati all’interno di progetti di esistenza, è stato un tratto dominante. Il filo conduttore di quella che potremmo chiamare la filosofia dell’inclusione, è l’idea che incontriamo gli altri solo a partire dai nostri pregiudizi. Tuttavia questi ultimi non solo non costituiscono la parola ultima dell’incontro, ma sono qualcosa che deve costantemente essere messo alla prova.
La scuola rappresenta il luogo privilegiato per comprendere tutto questo. Quotidianamente gli studenti fanno esperienza delle loro diversità, si scontrano e si incontrano con modi fare, agire ed essere differenti. Alla luce di ciò il ruolo dell’insegnante non può che essere quello di creare un terreno fertile affinché queste differenze si trasformino da muro invalicabile a occasione di crescita. Certamente l’inclusione scolastica è anche l’esperienza di un urto, il luogo in cui l’incontro con un’alterità contrapposta a me apre una ferita, genera un taglio, crea un vuoto, ma tutto questo offre al soggetto la possibilità di una nuova esperienza. Se non permetto a questa esperienza di realizzarsi, qualunque possibilità di dialogo, di incontro e di crescita svanisce. Ecco perché una scuola inclusiva deve necessariamente fare spazio alle differenze e valorizzarle, come occasione preziosa che riposiziona l’identità permettendo al legame intersoggettivo di esistere.

LA CONVERGENZA TRA MUSICISTI E INFLUENCER: QUANDO IL PALCOSCENICO SI TRASFORMA IN UN FEED DIGITALE
LA NUOVA ERA DELLA MUSICA: DALLA PERFORMANCE LIVE AL COINVOLGIMENTO ONLINE
di Giorgio Caporale
Nell’era digitale in cui viviamo, i confini tra diversi settori sembrano sempre più sfumati. Un esempio lampante di questa convergenza è rappresentato dall’unione tra il mondo della musica e quello degli influencer. Oggi, sempre più spesso, i musicisti non sono solamente artisti sul palco, ma anche figure influenti sui social media, capaci di raggiungere un vasto pubblico e di plasmare tendenze culturali.
I social media hanno rivoluzionato il modo in cui la musica viene prodotta, promossa e consumata. Piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube offrono agli artisti un palcoscenico virtuale senza confini geografici, consentendo loro di raggiungere un pubblico globale con una facilità senza precedenti. Non è raro vedere musicisti che utilizzano queste piattaforme non solo per condividere la propria musica, ma anche per mostrare il dietro le quinte della loro vita, interagire con i fan e collaborare con altri artisti e influencer.
La natura visiva dei social media ha aperto nuove opportunità per i musicisti di esprimersi creativamente al di là della loro musica. Video musicali innovativi, performance dal vivo in streaming e contenuti di dietro le quinte sono diventati parte integrante della strategia di marketing degli artisti, consentendo loro di costruire un legame più forte con il loro pubblico e di mantenere un costante coinvolgimento online.
Inoltre, la collaborazione con influencer di diversi settori è diventata una prassi comune nel mondo della musica. Gli artisti non solo si avvalgono dell’influenza degli altri per promuovere la propria musica, ma spesso partecipano attivamente a campagne di marketing cross-promotion, collaborando con influencer per creare contenuti originali che possano essere condivisi su entrambe le piattaforme.
Tuttavia, questa convergenza tra musica e influencer non è priva di critiche. Alcuni sostengono che l’attenzione sempre maggiore sui social media e sulla promozione online possa distogliere l’attenzione dalla qualità della musica stessa, riducendo gli artisti a semplici figure di marketing. Altri temono che l’eccessiva commercializzazione possa compromettere l’autenticità degli artisti e delle loro opere.
Nonostante queste critiche, è innegabile che i social media abbiano aperto nuove strade per i musicisti di raggiungere il successo e di connettersi con i loro fan in modi mai visti prima. L’unione tra musica e influencer sembra essere solo all’inizio di un’evoluzione che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui concepiamo e consumiamo la musica nel XXI secolo.

MOLCE ATELIER, STORIE DI RINASCITA
di Aurora Marella
Nel quartiere di Niguarda, a Milano, esiste un luogo dove la parola più importante è il verbo “molcere”. Significa lenire, alleviare, addolcire.
In questo luogo viene praticata l’attività della sartoria, un mestiere antico fatto con le mani, con la creatività e con una formazione artigianale.
Viene praticato anche e soprattutto il sostegno alla persona.
Ecco gli ingredienti di questo luogo, la sartoria sociale Molce Atelier, definita “la sartoria che cura”.
Questa attività nasce nel 2021 grazie ad un bando della Scuola dei Quartieri del Comune di Milano e della Comunità Europea.
Nel 2021 un’equipe tutta al femminile propone il progetto di attuare corsi di formazione sartoriale gratuiti affiancati da uno sportello psicologico di sostegno, ascolto e accoglienza per le donne vittime di violenze a cui viene data l’opportunità di apprendere un mestiere garantendosi l’indipendenza economica e ricostruire la propria vita.
E, mentre si creano prodotti artigianali e si impara a tradurre con la stoffa il linguaggio del riscatto emotivo, un punto dopo l’altro, un filo colorato dopo l’altro, si ricuce una storia, si riconosce il proprio valore, ci si riappropria del tempo. E non si è sole.
Nella sartoria sociale operano tre donne volte a portare avanti questa attività di accompagnamento per la rinascita emotiva, psicologica ed economica delle donne che si rivolgono a Molce Atelier attraverso la produzione artigianale di abiti e accessori che si inseriscono in un circuito economico virtuoso.
C’è Paola, la psicologa, Fernanda, la responsabile della sartoria e Adriana, la stilista. Tre percorsi, tre anime, tre indirizzi che sono convogliati in un progetto che unisce la creazione, l’arte, la sostenibilità e il sostegno.
Molce Atelier è stato a Fa’ la cosa giusta negli stand della Critical Fashion e ha fatto parlare di sé un anno fa quando ha presentato il film Primadonna. Ha ricevuto attenzione da parte di diverse riviste e di quotidiani ottenendo importanti riconoscimenti.
Molce Atelier è un tocco delicato ma deciso, non solo su stoffe colorate ma soprattutto sulle vite, grazie al potere terapeutico del lavoro manuale, della creatività, del supporto di un gruppo di donne unite.
L’attività economica di produzione sartoriale di Molce Atelier si rivolge sia ai privati che alle aziende e propone collezioni giocose dalle linee semplici e originali di abiti, accessori per la casa, per la persona, per i bambini e bomboniere per tutte le occasioni. Le donne che hanno incontrato MolceAtelier lavorano per questa produzione, assunte o indirizzate per acquisire l’autonomia economica e, con essa,la possibilità di compiere scelte libere con cuore rinnovato.
Grazie a Paola, la quale mi ha dedicato il proprio tempo, trai mille preparativi della fiera Fa’ la cosa giusta, per raccontarmi di questa attività che si distingue e naviga nel mare della moda con un ritmo lento, manuale, unico e importante, il ritmo delle parole e del passo.

“TREDESIN DE MARZ”. SAN BARNABA E I TREDICI SEGNI
di Giorgio Righetti
Era il 13 di marzo ed era l’anno 51, secondo la tradizione quel giorno San Barnaba era arrivato a Milano per diffondere il cristianesimo, era partito da Antiochia con una sacca a tracolla, una scodella per attingere l’acqua alle sorgenti e un bastone nodoso su cui era allacciata di traverso una rozza croce, si fermò a riposare in una boscaglia al di fuori della Porta Argentea, in seguito porta Orientale (attuale Porta Venezia), pronto a iniziare la sua missione. Con fatica aveva infisso la croce in una grossa pietra, non prima di aver tracciato tredici piccoli solchi a raggiera che partivano dalla base della croce fino al bordo del sasso. Per passare dalla Porta Argentea, si era obbligati a sacrificare alle statue degli dei pagani posti agli ingressi di Milano. Confidando nel Signore e fatti i primi proseliti Barnaba entrò in città e, al suo passare tutte le statue delle divinità pagane caddero a terra e si frantumarono, sebbene ancora in Inverno le piante fiorirono come in un bel giorno di primavera. Non si fermò molto Barnaba a Milano, forse nemmeno un anno, ma a ricordare il suo arrivo in città si tenne per secoli una bellissima fiera di fiori detta “del Tredesin de Marz”, perché si teneva precisamente il giorno 13 di marzo, si allargava con i suoi profumati e multicolori prodotti lungo i bastioni sino a Porta Romana, era molto frequentata perché era la prima fiera di fiori dell’anno e suggellava la fine dell’inverno. Oggi la fiera è ridotta ad una misera rappresentazione di quella antica, è stata spostata in via Crema e adiacenze, ha mutato il suo carattere, ha perduto poesia, ai fiori sono state aggiunte altre mercanzie, è diventata una delle fiere-mercato come tante altre. Malinconie di fine Ottocento queste parole di Emilio De Marchi: (E le giornate del tredici di marzo? C’era la fiera tutta in lunga fila, giù fino al dazio, coi banchetti di viole, e di gerani, le prime rose, e tra guardare, annusare e toccare si andava via col cuor come un giardino, pensando al bel faccin di Carolina che sott’al cappellino alla Pamela e con la rosellina sopra il seno ti sembrava anche lei la Primavera). Ma malgrado tutto a testimoniare del passaggio di Barnaba a Milano esiste ancora la pietra dove secondo la leggenda S. Barnaba infisse la croce fuori dalla Porta Argentea in un giorno lontano di duemila anni fa, la pietra fu trasportata nella Chiesa di Santa Maria al Paradiso a Porta Vigentina, dove la si venera tuttora e porta incisi tredici segni a ricordare il giorno in cui il santo arrivò a Milano.

ECOCIDIO IN UCRAINA: A RIMETTERCI SARÀ TUTTO IL PIANETA
di Olga Boiko
“Papà, un mio compagno di classe dice che la cosa più importante che abbiamo sono i soldi.”
“E tu che ne pensi?”.
“Secondo me, la cosa più preziosa che abbiamo noi umani sono gli alberi.”
“???”.
“Gli alberi forniscono ossigeno.”
Come misurare i danni dei crimini di ecocidio che produce la Russia in Ucraina?
L’Ucraina possiede preziose risorse naturalistiche, contando il 35% della biodiversità europea, è casa di circa un quarto del čornozem, oltreché di centinaia di aree protette e parchi nazionali che sono attualmente colpiti dalla guerra in corso. La devastazione ecologica causata dalla guerra in Ucraina ha pochi precedenti nella storia.
E a rimetterci sarà tutto il pianeta.
L’impatto su flora e fauna dei bombardamenti e dei combattimenti è gravissimo, così come gravissime sono le conseguenze sull’agricoltura.
La guerra nel mio Paese è prima di tutto una tragedia umanitaria, ma anche ambientale. E le due cose non vanno separate, dal momento che i danni ecologici di oggi sono la minaccia per ulteriori catastrofi umanitarie di domani.
Con ogni attacco missilistico, la Russia prende di mira persone, animali, foreste e campi. Sembra che stiano mirando al nostro pianeta stesso, tentando di distruggere tutto ciò che lo circonda. E non capiscono che distruggendo casa nostra, distruggono anche casa loro.
Ma è possibile nel 2024?

CARLO DONAT-CATTIN
di Alessandro Bocci
Non sono mancate, negli anni, occasioni di riflessioni e di approfondimenti su Carlo Donat-Cattin, scomparso nel ‘91. A fronte della pochezza della stragrande maggioranza dei nominati nelle legislature della seconda repubblica, vale la pena richiamare, anche se in modo frammentario e parziale, una figura dallo spessore umano, politico e culturale come quella dello statista democristiano.
Donat-Cattin aveva studiato Maritain e altri autori cattolici francesi; su quelle basi definì la sua formazione ideale e si iscrisse all’Azione cattolica nel 1934. Dopo essere stato partigiano, partecipò con Giulio Pastore alla fondazione Cisl. Eletto parlamentare nel ‘58, fu Ministro del Lavoro, promuovendo l’approvazione dello Statuto dei lavoratori e “portando la Costituzione nelle fabbriche”.
Visse con particolare angoscia il sequestro dell’amico Aldo Moro, da parte delle Brigate rosse, sostenendo con grande sofferenza la linea della fermezza, che escludeva ogni trattativa. Nel momento in cui il terrorismo colpiva al cuore lo stato non era possibile concedere ad esso alcun riconoscimento.
Come leader della componente democristiana di Forze Nuove, la sinistra sociale di quel partito, promosse nel febbraio ‘80 il “preambolo”, un documento che escludeva ogni possibilità di collaborazione governativa fra la Dc e il Pci. Strenuo oppositore della segreteria De Mita, venne da quest’ultimo esiliato al Ministero della sanità. Donat-Cattin assunse posizioni ferme su tematiche come l’aborto e la bioetica che gli valsero, da ministro, mozioni di sfiducia da parte delle minoranze parlamentari. “Voi stabilite – fu la sua risposta- che un cattolico non possa fare il ministro della Sanità, né in Italia né in alcun altro paese, e quindi stabilite una discriminazione che va rigettata”.
Convinto democratico, si schierò senza esitazioni al fianco di Solidarnosc, il sindacato polacco che lottava per la libertà. “Ragionando come voi avremmo lasciato vincere i nazisti”, rispondeva ai pacifisti che criticavano la posizione assunta dall’Italia nella guerra del Golfo. Strenuo difensore del sistema proporzionale e delle preferenze, considerava l’uninominale uno strumento che i ceti dominanti avrebbero cercato di introdurre per comprimere le istanze popolari.
La sua vita fu segnata dalla vicenda del figlio Marco, appartenente ad un gruppo terroristico di sinistra, arrestato nel dicembre ‘80 dopo qualche mese di latitanza, che aveva partecipato all’omicidio del giudice Alessandrini. Il direttore di Repubblica, Scalfari, scrisse un editoriale rancoroso, nel quale attribuì al padre le colpe del figlio. Dopo aver scontato parte della pena, Marco Donat-Cattin morirà travolto da un’auto, in mezzo alla nebbia, mentre cercava di salvare le persone rimaste a bordo di una vettura coinvolta nel tamponamento.
Partigiano, antifascista, sindacalista torinese che non abbassò mai il capo di fronte alla Fiat, cristiano scomodo, riformista ed europeista, filoccidentale e mai terzomondista, parlamentare e ministro integerrimo.
Si possono avere opinioni diverse su Donat-Cattin e Bertinotti, allora leader di Rifondazione comunista, ammise che si poteva “essere anticomunisti e di sinistra allo stesso tempo”. In ogni caso, si dovrebbe concordare sul fatto che gli attuali leader dei partiti politici, se paragonati a lui, appaiono, fatta salva qualche eccezione, del tutto inconsistenti. Volendo usare una frase da “Nostromo”, lo pseudonimo che Donat-Cattin utilizzava su Terzafase, una delle riviste da lui fondate e dirette, si potrebbe dire, pensando sempre ai politici di oggi, che quando l’ombra dei pigmei si allunga volge il tramonto.

LE BELLE STORIE CI CATTURANO
di Libera Iannetta
È un segreto che si tramanda dalla notte dei tempi: le belle storie ci catturano perché siamo menti narrative, pronte ad inseguire un racconto avvincente che può dipanarsi attraverso immagini, suoni o, più semplicemente, parole. Il paese dei poeti e dei navigatori è ricchissimo di queste storie che, insieme, formano un patrimonio culturale spesso inesplorato.
È in tale contesto che si colloca la pubblicazione, dopo ultradecennali ricerche in biblioteche pubbliche e private e presso collezionisti, del romanzo “Verso il destino” di Clelia Romano Pellicano, pubblicato in appendice al giornale “La Tribuna” tra il 1906 e il 1907 e presentato, per la prima volta in volume unico, dalla DEA Edizioni di Baronissi.
Il romanzo, ambientato nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, racconta le vicende familiari, finanziarie e sentimentali della famiglia Limosano, che dalla quiete di Roccella, “villaggio” della provincia calabra “piccioletto e bruno”, che si specchia in una fascia dello Ionio pulita e cristallina, giunge a “la gran curva del Golfo di Napoli col Vesuvio placido come un dio, tracciante nel cielo terso il ghirigoro del suo pennacchio; a destra quella meno sinuosa del Golfo di Pozzuoli, dove Baia e Cuma sfumavano in trasparenze latee e Nisida guatava cupa, come oppressa dal dolore umano che porta sul verde dorso.” Qui la famiglia incontra e si scontra con un mondo, quello della variopinta capitale partenopea, popolato da personaggi ritratti magistralmente e impietosamente dalla voce narrante con ironico distacco, nelle proprie viltà e nel proprio parassitismo, quali membri di una società corrotta, piegata dalle apparenze e dal danaro e sulla quale regna, incontrastato, l’intrigo.
Clelia Romano Pellicano, nata a Napoli nel 1873 e morta a Castellammare di Stabia a soli cinquant’anni, è stata una scrittrice e giornalista, pioniera del femminismo italiano. Al suo sconosciuto romanzo, “Verso il destino”, che risente degli influssi verghiani e presenta accenni a motivi pirandelliani, faranno seguito la ristampa delle “Novelle calabresi” e “La vita in due”, proposti dalla stessa casa editrice. Belle storie che ci catturano.

“20 GIORNI A MARIUPOL”
di Olga Boiko
Il film “20 giorni a Mariupol” ha vinto il premio BAFTA nella categoria “Miglior documentario”. ⠀
Mstislav Chernov, il fotografo Evgen Maloletka e la produttrice Vasilisa Stepanenko sono arrivati a Mariupol un’ora prima che la città fosse iniziata a essere distrutta dalle forze armate russe. Sono rimasti gli unici giornalisti internazionali nella città assediata e hanno documentato tutto ciò che vi accadeva: la catastrofe umanitaria causata dall’assedio russo, i crimini di guerra, le sepolture di massa dei civili, il lavoro dei medici che disperatamente registravano le morti dei bambini, dai ragazzi ai neonati. ⠀
Grazie a Chernov e al suo team, il mondo ha visto per la prima volta molte delle famose e commoventi foto di Mariupol, comprese le conseguenze del bombardamento del reparto ostetrico n. 3.
Chernov e Maloletka inviavano le loro foto e video nascondendosi sotto le scale vicino al negozio di alimentari distrutto, l’unico luogo a Mariupol dove c’era una connessione. ⠀
“La mancanza di informazioni in condizioni di blocco ha due obiettivi. Il primo è il caos. Le persone non capiscono cosa sta succedendo e vanno nel panico. Il secondo è l’impunità”, dice Chernov. ⠀
“Senza immagini di edifici distrutti e di bambini che muoiono, le forze armate russe avrebbero potuto fare ciò che volevano. Se non fosse stato per noi, non ci sarebbero state tali immagini. Ecco perché abbiamo corso il rischio di mostrare al mondo ciò che abbiamo visto”. ⠀
Dal 2014, Mstislav Chernov ha lavorato in molte aree calde, documentando proteste a Istanbul, gli eventi della Rivoluzione della Dignità in cui è stato ferito. Tuttavia, Mariupol è stato “assolutamente il momento più spaventoso e difficile” della sua vita e di quella del suo team. ⠀
Secondo lui, non aveva mai visto tanta crudeltà da nessun’altra parte. Inizialmente, come giornalista, Chernov viveva in un hotel e poi, come centinaia di migliaia di residenti, cercava di procurarsi le cose essenziali – trovare acqua, gas, un posto dove ricaricare telefoni e fotocamere. È persino stato costretto a cercare un nuovo rifugio e insieme al suo team, ai medici e ai feriti ha dormito per terra in ospedale. ⠀
“Mstislav Chernov ha fatto la cosa più preziosa che un giornalista possa fare in tali circostanze: si è trovato lì, con la telecamera, proprio dove e quando una delle più grandi tragedie del mondo contemporaneo stava influenzando la vita di una persona specifica”, racconta la corrispondente della BBC Zhanna Bezpyatchuk, descrivendo le impressioni di “20 giorni a Mariupol”. ⠀
Osservando la disperazione di una donna che ha perso i contatti con sua figlia e non sa come proteggersi dai bombardamenti, Chernov cerca di calmarla dietro la telecamera, dicendole che le forze armate russe non sparerebbero ai civili, racconta la corrispondente della BBC.
Questo film è necessario per gli ucraini, affinché possano riconoscere in profondità e completamente le loro ferite da guerra e avere così la possibilità di liberarsi dalla loro influenza in futuro. Ed è necessario per il mondo per vedere come 20 giorni di assedio russo di una città ucraina mostrino contro cosa si sta combattendo e per cosa sta lottando un intero paese per il secondo anno consecutivo.

IN VIAGGIO VERSO LA LIBERTÀ: IL VIAGGIO DI ROGER
IN DIFESA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE
di Milena Ruffini
Incontro Roger nel 2014. Riconosco subito che è un tipo che sa distinguersi. Occhi profondi e intensi che rivelano intelligenza e sensibilità. È francofono, parla inglese e conosce anche lo spagnolo. Forse l’italiano è l’unica lingua che ancora non sa.
Mi spiega di avere la doppia cittadinanza: ivoriana e ghanese.
Ultimo di dieci figli e unico maschio ha vissuto fino al 2010 in Costa d’Avorio con i genitori, per poi nel 2011 essere costretto, a causa della guerra civile, a trasferirsi in un campo profughi al confine tra Costa d’Avorio e Ghana. Questo non gli ha impedito di concludere gli studi e di laurearsi in economia.
A causa dell’instabilità politica e della precarietà economica, ha quindi deciso di abbandonare il suo paese.
Il suo sogno sarebbe stato quello di trasferirsi a Parigi, ove anni prima si erano stabiliti la sorella e alcuni cugini. Era stato a Parigi alcune volte per brevi periodi di vacanza. Quella città lo affascinava da sempre, sentiva di appartenervi. Doveva lasciare l’Africa. Roger avvertiva il bisogno di libertà, di modernità, di internazionalità… di aprire la sua mente.
Un suo connazionale, che aveva ottenuto protezione, gli aveva suggerito di raggiungere prima l’Italia. Lì, gli aveva detto, operava il suo avvocato, esperto in diritti umani, che avrebbe potuto aiutare anche lui. Poi, una volta regolarizzato avrebbe potuto raggiungere la Francia.
E così Roger arriva a me e mi chiede di aiutarlo a conquistare l’agognata libertà e realizzare il suo sogno.
Presentiamo richiesta di protezione internazionale con tutta la documentazione necessaria.
Nel frattempo, lui impara con una velocità strabiliante la lingua italiana, trova un lavoro come commerciale presso una nota azienda lombarda e prende un’abitazione in affitto.
Diventa parte della mia famiglia… la sua gentilezza e i suoi modi conquistano tutti.
C’è sempre per noi e noi per lui. Ad ogni compleanno si presenta con palloncini e regali sfoggiando il suo meraviglioso sorriso. La tavola di Natale non sarebbe tanto chic senza il suo contributo artistico …
Per ben otto anni trascorre tutte le feste con noi… Otto anni … il tempo necessario per realizzare il suo sogno.
Ottenere i documenti, infatti, non è così semplice. Roger inizialmente presenta istanza volta all’ottenimento della protezione internazionale nella forma della protezione umanitaria. Tale forma di protezione rientra nella categoria generale delle figure del diritto di asilo, riconosciuto dall’art. 10 della Costituzione che al comma 4 recita: “… lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni previste dalla legge …”.
La protezione umanitaria, per la precisione, abolita dalla L. 113/2018 che ha ulteriormente stretto le maglie del diritto al soggiorno di cittadini extracomunitari in Italia, veniva concessa ai cittadini stranieri in stato di vulnerabilità nei cui confronti sussistevano gravi motivi umanitari.
La domanda di Roger viene in prima battuta rigettata dalla Commissione Territoriale per il Diritto di Asilo che non lo ritiene credibile.
Il Tribunale – Sez. Specializzata Immigrazione, adito nel ricorso promosso avverso il diniego, accoglie le sue richieste sulla scorta della grave crisi politica del suo paese d’origine e del suo documentato livello di integrazione nel tessuto sociale nazionale.
Dopo tre anni, dunque, Roger riesce ad ottenere i documenti in Italia.
Ma l’odissea non è ancora terminata! Per trasferirsi in Francia e poter convertire il titolo di soggiorno italiano deve ottenere la carta per soggiornanti di lungo periodo per cui è richiesta la regolare permanenza sul territorio per almeno cinque anni.
Nonostante tutte le difficoltà e la fatica non perde mai la sua proverbiale allegria.
E finalmente nel 2023, decorso il termine previsto ottiene la tanto agognata carta di soggiorno UE che gli apre le frontiere francesi.
A Capodanno del 2024 siamo tutti quanti a brindare a Parigi per festeggiare questo meraviglioso traguardo.
Un sogno che si realizza … o meglio, un progetto che prende forma con costanza, tenacia e determinazione. Nel rispetto di una normativa complessa e cavillosa.
Ed innumerevoli, quasi all’ordine del giorno, gli atti discriminatori che Roger ha dovuto subire durante il suo soggiorno in Italia, esclusivamente per via del colore della sua pelle.
Come quella volta in cui in una famosa boutique della città, di cui poi sarebbe diventato abituale cliente, lo stavano per scortare all’uscita…
Ma Rogy, con la sua intelligenza e l’ironia ha saputo sempre andare oltre.
Una repubblica democratica la nostra, che fonda, tra gli altri, sul principio di uguaglianza e di libertà …
Con la speranza che in Italia si compia il miracolo di una rivoluzione culturale e confidando in una modifica radicale del diritto dell’immigrazione auguriamo a Roger un futuro radioso.

VIVERE PERICOLOSAMENTE… LAVORARE A SCUOLA
di Slobodan Fazlagic
L’altro giorno apro un quotidiano e tra le notizie nelle pagine della cronaca, mista con le curiosità, leggo: “Preside pestato dai genitori di un’alunna”. Il luogo e la scuola non importano. Tanto, succede ovunque in Italia e a qualunque lavoratore della scuola: docenti, collaboratori, dirigenti. Sono stato sorpreso? No, ugualmente come non lo sarete voi che darete uno sguardo a queste righe.
Assistiamo ad un degrado sociale quasi nascosto, sorvolato e taciuto dalle autorità dell’educazione pubblica. Invece, essendo una subdola crepa interna al sistema scolastico, minaccia, anzi già lo fa, l’abbassamento culturale e formativo delle future generazioni, dei futuri protagonisti in veste di futuri genitori. Entriamo in un circuito chiuso che può finire solo dentro una spirale risucchiante verso un fondo di cui, sinceramente, ho paura.
A che mondo appartiene un genitore che va fisicamente ad aggredire uno che si occupa di formazione, educazione e crescita sociale del proprio figlio? È un mondo a rovescio, in cui lui supera ogni limite nell’animalesca protezione del proprio figlio, negandogli la possibilità di crescere, di confrontarsi con le difficoltà della vita reale, di misurarsi con, volendo, anche delle ingiustizie e divieti. Lo mantiene all’infinito custodito nel proprio nido. Istintivamente, tira indietro la ruota dello sviluppo sociale, si attribuisce il diritto di giudizio fuori dalle proprie competenze e, spesso, anche conoscenze. Lasciamo stare l’aspetto della maleducazione, è una cosa periferica che accompagna l’atto della violenza. Pensiamo ai motivi e alle origini di tale comportamento deformato, decisamente in crescita.
Non sono uno sociologo e non pretendo di fare un’analisi scientifica, fuori dalle mie competenze. Provo a fare un’osservazione con il diritto di appartenenza ad una società, pari merito a qualunque altra persona dell’ambiente. Per i lunghi anni precedenti, nello stadio meno ricamato dei fili internettiani, senza la tanto discussa globalizzazione, l’autorevolezza di un insegnante era il pilastro della società. Si dice spesso che in un paese di modeste dimensioni, o in un quartiere cittadino, tre personaggi locali rappresentavano le colonne portanti: il prete, il medico e il maestro di scuola. Oggi, i primi due in un certo senso, pure in evoluzione, ancora tengono la loro posizione. Il povero maestro/docente ha completamente perso valore e peso pubblico. È diventato un’appendice secondaria nel percorso formativo delle nuove generazioni. Tanto marginale da poter essere disciplinato se non si comporta secondo il piacere dei genitori di futuri costruttori della società.
Non tanto tempo fa, il primo a strigliare un ragazzino che portava brutti voti a casa era il papà o la mamma. Oggi, la colpa è dell’insegnante, del dirigente… Come mai siamo arrivati a questo punto? Un atteggiamento irrazionale, una fede incondizionata nelle parole di un adolescente? O si nasconde a se stessi la propria debolezza, l’incertezza nel proprio operato educativo, nelle basi che abbiamo dato ai nostri figli? Proteggendo un figlio che va male a scuola proteggiamo noi che abbiamo fallito nel dargli uno slancio positivo, il rispetto delle autorità scolastiche e la consapevolezza che solo la buona formazione garantisca una velocità iniziale sufficiente per lanciarsi nella gara per una vita migliore. Per i ragazzi disorientati, i social offrono uno specchio distorto della vita, mettono in evidenza i successi senza competenze da acquisire e illudono tutti che si può diventare ricchi senza lo studio. Certo che si può e che succede. Ma succede a pochi, tanti pochi che è come giocare al Lotto, nel senso che le probabilità sono le stesse.
Da dove vengono i genitori mutati di oggi? Fermiamoci un attimo prima di dare tutta la colpa a loro. Da sempre, una buona educazione comprende la simbiosi tra il nucleo famigliare e la scuola. Adesso, quel gancio sembra perso. Solo per colpa dei genitori diventati maleducati? Se ragioniamo bene, la maggior parte di questi genitori di oggi sono gli studenti di vent’anni, trent’anni fa o simile… Il seme possiamo cercarlo là. Non è che con le costanti e interminabili riforme del sistema scolastico regolarmente avviate con ogni nuovo governo in carica non abbiamo, pezzo per pezzo, spostato la responsabilità del non-studiare (dell’insuccesso formativo) dalla coppia studente/famiglia a noi, alla scuola stessa?
Se un ex-studente di allora, oggi un genitore, viene a picchiare il responsabile, come lo vede lui, per il voto brutto di suo figlio e lo fa dentro una scuola, perché stupirci?
Quella vita pericolosa l’abbiamo scelto come sistema, direi. Non saprei come si può uscire da questa spirale negativa. È una domanda per tutti noi. E decisamente non parlo delle distorsioni sociali come quelle delle scuole americane dove i quasi regolari massacri da parte degli studenti a spese di tutti i malcapitati dentro appartiene ad una matrice completamente diversa, per fortuna…

PRECARI DELLA SCUOLA, LA MAGISTRATURA È CON VOI!
di Francesco Maraia
La scuola rappresenta l’istituzione più importante di una società civile, capace di promuovere valori e di tramandare sapere, attenta alle esigenze di tutti ed orientata a ciò che rappresenta un paradigma più che un concetto, ovvero l’inclusione.
Quest’istituzione è sorretta da donne e uomini che hanno fatto dell’educazione, della pedagogia e della cultura vere e proprie ragioni di vita. Tra questi, oltre un milione il personale scolastico, troviamo una categoria fondamentale per l’intero apparato educativo scolastico italiano: i precari.
I precari nella scuola italiana sono oltre 200.000 e provengono in gran parte dal Sud Italia. Donne e uomini con un ruolo sociale fondamentale, sorretti da anni di studio e grandi passioni, spesso costretti a fare grandi sacrifici per realizzare il proprio sogno. Un sogno che trova numerosi ostacoli durante il cammino e che spesso viene compromesso da difficoltà comuni a molti di loro. Le difficoltà sono le più disparate e spesso trovano cause in gravi discriminazioni contrattuali e salariali. Il Ministero dell’Istruzione, ad oggi, non ha affrontato mai la questione anzi, l’ha complicata in un valzer di riforme e nuovi riferimenti normativi.
In questo contesto i precari italiani trovano il più prezioso alleato nella Magistratura attenta ad intervenire colmando le lacune normative, eliminando le situazioni di discriminazione salariale e contrattuale, tutelando di fatto una categoria abbandonata a se stessa. L’intervento dei giudici, negli ultimi anni, è stato utile a ribadire che non vi è alcuna differenza contrattuale tra i docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli precari, tanto da estendere anche a questi ultimi il Bonus Docente, misura di sostegno alla formazione del personale scolastico, del valore di 500€, attribuita dalla Legge 107/2015 ai soli docenti a tempo indeterminato.
Questa vertenza è stata trattata dai Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte di Cassazione i quali hanno ribadito, concordemente, l’uguaglianza sostanziale e formale tra docenti con contratto a tempo indeterminato e precari. Solo per questa fattispecie sono stati presentati oltre 30.000 ricorsi, tutti vinti, da parte dei docenti precari che chiedevano la corresponsione del beneficio alla luce delle prima citate pronunce.
Eppure questo non è l’unico caso in cui i precari del mondo scuola sono costretti a chiedere l’intervento della magistratura. La scuola, che spesso abusa nell’utilizzo di docenti con contratto a tempo determinato, non pone le stesse tutele contrattuali tra i prof titolari di cattedra e quelli precari. A titolo esemplificativo, i docenti assunti per una supplenza breve vedranno una busta paga più leggera che non prevede la relativa voce di retribuzione professionale docenti (RPD) pari a 175,50€ circa per ogni mese di servizio. I docenti precari costretti ad accettare queste forme contrattuali sono i più svantaggiati. Costretti ad affittare alloggi senza la certezza di un rinnovo che, per i più fortunati, viene comunicato il giorno della scadenza del contratto. Docenti che ricevono lo stipendio, sensibilmente ridotto, solo dopo mesi di lavoro. E ancora, la differenza contrattuale è percepibile osservando tante altre fattispecie come ad esempio quella dei permessi, retribuiti per i titolari di cattedra e non retribuiti per i precari.
Queste storture normative aggravano quella che è una situazione paradossale tutta italiana, condannata dalla stessa Unione Europea che più volte ha ribadito il divieto della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
I precari della scuola, ad oggi, non hanno il diritto a sognare un futuro stabile, a fare un mutuo ed una famiglia, a realizzare i propri obiettivi costretti ad anni di instabilità, continue modifiche normative e spese infinite di formazione che delineano il futuro della classe docente tra chi potrà permettersi di fare il docente e chi, non avendo possibilità economiche, resterà fuori.
A queste donne ed uomini che tanto mi hanno insegnato, grazie all’esempio dei loro sacrifici e della loro tenacia, va la nostra gratitudine per l’etica e l’abnegazione con cui portano avanti la propria missione pedagogica nonostante una paradossale situazione di sfruttamento e discriminazione da parte di chi dovrebbe garantire il ruolo sociale ed istituzionale di questi lavoratori, nella speranza che l’opera del Ministero dell’Istruzione tenga conto del forte intervento da parte dei Giudici europei ed italiani.

SANREMO: LA SFIDA DI RITROVARE LA GRANDEZZA MUSICALE NELL’ERA DELLO SPETTACOLO
di Giorgio Caporale
Il Festival di Sanremo, da decenni custode della ricchezza e della diversità musicale italiana, si trova oggi a una svolta cruciale che solleva domande fondamentali sulla sua identità e missione. Nonostante il suo impatto persistente nel panorama musicale globale, emerge sempre più chiaramente la mancanza di artisti di spicco a livello internazionale e di autentica competenza musicale all’interno delle sue mura.
In epoche passate, il Festival di Sanremo si distingueva per aver accolto e celebrato star di fama mondiale, contribuendo al prestigio dell’evento e alla sua influenza nel contesto musicale internazionale. Tuttavia, un’analisi attenta degli ultimi anni rivela una tendenza crescente a privilegiare aspetti spettacolari e elementi di intrattenimento a discapito della qualità artistica.
Questo spostamento di focus ha scatenato una discussione profonda sulla direzione intrapresa dal Festival. Il rischio imminente è quello di perdere la sua risonanza globale, trasformandosi da celebrazione autentica dell’eccellenza musicale a mero spettacolo di intrattenimento. La necessità di una riflessione critica è chiara, e forse il titolo stesso del festival potrebbe diventare il punto di partenza per tale riflessione.
SANREMO: UNA RINNOVATA ODISSEA MUSICALE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO
Questo richiede un esame approfondito delle scelte artistiche e organizzative, spingendo verso un ritorno all’essenza che ha reso il Festival di Sanremo un pilastro nella storia della musica italiana. Il ripristino della centralità della competenza musicale e una selezione oculata di talenti di levatura internazionale sono essenziali per garantire la continuità della sua eredità.
Solo attraverso un impegno rinnovato nella ricerca e nell’accoglienza di talenti musicalmente preparati, il Festival di Sanremo potrà sperare di affrontare la sfida attuale e di mantenersi come faro di eccellenza musicale, non solo nel contesto italiano ma nell’intero panorama globale della musica.

BREVE STORIA DI UN TEATRO COMUNE
di Aurora Marella
Peppa possiede lo sguardo di chi ha compiuto tante esperienze mentre mi parla nella videochiamata. Racconta con toccante passione la storia di un gruppo di teatro che si è originato nel 1963, nel quartiere della Bovisa.
Il nucleo originario vedeva una compagnia di persone principalmente del quartiere e ciò ha costituito un importante punto di riferimento di socialità e di aggregazione tanto che ha resistito per moltissimo tempo, anche al lockdown.
Dopo molti anni di sperimentazioni a più voci e a più mani, nel 2001 è nato, da quel gruppo originario, Bovisa Teatro, nome con cui è conosciuto oggi ormai ben fuori dal quartiere Bovisa.
Bovisa Teatro nasce per ricordare e per tener viva l’eredità scenica e personale di uno dei riferimenti storici di questo gruppo, Luigi Mazzari, mancato l’anno precedente. Per questa occasione era stato inscenato uno spettacolo contro la guerra, “L’interrogatorio di Lucullo”, di Brecht.
Il gruppo si occupa di mettere in scena opere teatrali che vertono su tematiche sociali e criticità condivise quali la migrazione, la guerra, il femminicidio, la politica, la nuova povertà su cui propone un laboratorio, e collabora strettamente con tante realtà del quartiere vicino e del territorio più lontano e le ramificazioni e le connessioni spaziano in continuo movimento ed evoluzione.
Bovisa Teatro è un gruppo di persone che non seguono la società e i suoi eventi ma la partecipano con strutturata passione.
In questo momento, racconta Peppa, Bovisa Teatro sta lavorando a due copioni: “Zakhor”, uno spettacolo sui migranti e “Ferite a morte”, uno spettacolo che tocca il tema del femminicidio, tratto da un libro di Serena Dandini.
Bovisa Teatro però non si ferma al palcoscenico: numerosissime sono le connessioni con il territorio. Sono vive le collaborazioni con la Casa della Memoria di Milano nel quartiere Isola, con il centro multiculturale La Tenda, un’associazione nata nel 2000 che si occupa della migrazione e delle persone straniere, i loro bisogni, le loro ricchezze, la loro letteratura.
Peppa, coinvolta anche nell’associazione Naga, anch’essa relativa all’integrazione dei migranti, racconta con orgoglio di aver portato avanti dei corsi di italiano per stranieri.
Bovisa Teatro inoltre propone, nel cuore del quartiere Bovisa, nell’istituto Marelli, delle letture multiculturali in collaborazione con l’associazione La Tenda e la Rete di scuole senza permesso (di soggiorno).
Bovisa Teatro è una realtà dinamica e ricca. Opera guardando negli occhi gli spettatori, guardando negli occhi chi si propone di partecipare, guardando negli occhi chi annuncia, anche senza usare il linguaggio delle parole, un bisogno. Bovisa Teatro risponde.
Ringrazio di cuore Peppa Silicati per avere dedicato il proprio tempo per condividere il racconto di un filo rosso che lega mani, cuori, persone, quartieri, lingue diverse, all’interno della cornice di questa città con tante necessità e tanti volti. Bovisa Teatro rappresenta una risposta importante.

L’INVERNO DEMOGRAFICO
di Alessandro Bocci
Il nostro declino demografico nasce negli anni ‘70, quando l’indice di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, scese al di sotto di quel 2,1 che garantisce il ricambio generazionale. Purtroppo in quegli anni si scatenò una forte battaglia ideologica contro le famiglie, ritenendo che i figli ostacolassero le prospettive di carriera lavorativa delle donne. Il risultato fu che l’indice di fecondità continuò a scendere, assestandosi intorno a 1,2 e facendo dell’Italia uno dei paesi con la natalità più bassa al mondo. In sostanza, da due persone ne nasce una sola e ciò comporta, come è facile intuire, dimezzamenti successivi di popolazione.
In Francia, le cose sono andate diversamente. Lo stato era intervenuto garantendo il trasferimento di consistenti risorse dirette, cioè denaro, alle famiglie con figli e ciò ha permesso a quel paese di avere un indice di fecondità prossimo a 2,1; cosa che tra l’altro non ha certo danneggiato l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, che è di oltre sette punti maggiore di quello italiano.
Come ha notato l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), il nostro paese dovrebbe seguire l’esempio transalpino, avendo gli interventi indiretti, ad esempio gli aumenti del periodo di congedo pre e post parto, un impatto sulle nascite piuttosto limitato. La piramide delle età ci dice, però, che tutto ciò non basta più. Il numero di persone in età fertile è esiguo e anche se, magicamente, l’indice di fecondità balzasse ad un inverosimile 3 il numero dei nati rimarrebbe inconsistente. Per ristabilire un equilibrio demografico occorrono, infatti, generazioni.
Dobbiamo dunque accogliere più immigrati, che vanno formati ed inseriti nel mondo del lavoro e che devono godere dei nostri identici diritti. Non solo perché è giusto farlo, non solo perché i fatti di Cutro rappresentano una macchia indelebile, ma perché, egoisticamente, ne abbiamo un disperato bisogno.
Il devastante costo della desertificazione demografica, nel nostro paese nascono meno di 400.000 bambini all’anno, è economicamente insostenibile e si tradurrà in tagli al welfare e in ulteriori aumenti dell’età pensionistica. Ciò impattera’ maggiormente sui ceti più deboli, aumentando le disuguaglianze. È allora compito di tutti gli attori politici, economici e sociali intervenire nel senso indicato. Tempo da perdere, proprio, non ne abbiamo più.

È ARRIVATO IL TEMPO DI PENSARE AL TEMPO?
di Slobodan Fazlagic
Siamo o forse non siamo, dipende, i testimoni di quanto quello che conosciamo come il tempo inteso come comportamento dell’atmosfera stia rapidamente variando. Come succede spesso, purtroppo, i cambiamenti tendono a cadere verso il lato negativo rispetto alle aspettative. Con le aspettative intendo quello che ciascuno di noi sente come clima, come il viso scoperto della natura in cui siamo inseriti e ci muoviamo quotidianamente.
Il fatto, non negabile anche dai più aspri combattenti tra le falangi di complottisti, è che il clima stia cambiando. Poi, in merito alle cause, si può aprire un campo di discussione, nonostante che lo squilibrio tra gli scienziati che vedono l’uomo come il principale colpevole e gli altri che credono in una deviazione naturale somigli, per dire, al risultato di una partita di pallacanestro a livello dilettantistico, 95:05. Però, rimane ancora un po’ di dubbio che fa rumore, sufficiente a dare voce ai negazionisti che diffondono nei social qualche “prova certa” delle loro convinzioni.
Parlando seriamente, le vere prove stanno da tutt’altra parte. I metodi scientifici per la ricostruzione dei comportamenti atmosferici nella storia sono progrediti così tanto che oggi siamo in grado di tornare centinaia di migliaia di anni indietro, di scavare dentro quello che il tempo ha depositato nei ghiacci polari, nei fossili e nella rocce terrestri. E i risultati dicono una cosa certa: la presenza dei gas atmosferici responsabili della cattura del calore si può ricostruire con precisione nella scala temporale. Arrivo al punto: se la fai scaldare, bollendo l’acqua in una pentola, che fai se vuoi che quell’acqua dentro rimanga calda più a lungo possibile? Copri la pentola con dei panni, non la lasci all’aria aperta, certo. È quello che fanno i due gas responsabili della cattura del calore terrestre che altrimenti andrebbe perso nell’universo circostante. Anidride carbonica e vapore acqueo sono i panni atmosferici e per questo sono chiamati gas serra. Sto parlando di fatti che, credo, conoscano tutti.
Che cosa ci ha fatto capire quella ricostruzione storica che risale a tempi antecedenti rispetto alla comparsa dell’uomo? Ha confermato che la temperatura globale e la concentrazione di anidride carbonica si seguono molto fedelmente; sono due curve praticamente parallele. Aumenta una, segue l’altra. Ebbene, l’anidride carbonica, per lunghi millenni, oscillava tra due numeri significativi, tra 200 e 300 ppm. Però, dall’inizio dell’era industriale, ha cominciato a salire e continua a farlo, quasi linearmente. La causa è ovvia: l’incremento della combustione dei carburanti fossili. Oggi abbiamo lasciato molto indietro i picchi storici e abbiamo superato 400 ppm (siamo a oltre 420). Che vuol dire che la temperatura ha seguito lo stesso percorso? Che siamo a livelli mai raggiunti prima. È difficile capire perché questi fatti, tanto semplici, debbano essere ancora spiegati alla popolazione. Pure, dobbiamo farlo.
Se supponiamo che abbiamo convinto la maggioranza in buona fede che sta succedendo davvero un cambiamento epocale nella natura attorno a noi, bisogna ragionare su che cosa significa e dove ci porta tutto ciò. È una cosa seria, troppo seria per lasciarla solo ai politici di turno. E si arriva alla domanda iniziale, che sembrava banale e retorica: chi deve pensare a proteggere la natura dal riscaldamento fuori misura?
L’atmosfera, con l’energia accumulata sopra il livello ordinario, si comporta come un animale selvatico stracolmo di forza superflua. Sappiamo che fa una tigre arrabbiata: si dimena in modo incontrollabile dentro la gabbia. Ultimamente il tempo ci presenta una scena simile sferzandoci sempre più intensamente con alluvioni, uragani, onde di calore o nevicate storiche. Questo ci tocca indistintamente. La risposta sta lì: dobbiamo occuparcene proprio tutti. Non si può attribuire la responsabilità di ciò ad altri e scaricare tutto sui soli leader, di qualsiasi livello essi siano, produttivo o politico. La responsabilità di diminuire il rilascio di anidride carbonica cade su ciascuno di noi, in tutte le ore e in tutte le attività della nostra giornata. Il risparmio energetico è l’unica risposta che ci porta verso un traguardo di salvezza. Risparmio a tutti i livelli possibili, dalla nostra cucina ai sistemi industriali, ai trasporti globali. Dunque, i calcoli dicono che siamo ancora in tempo a prevenire uno scenario catastrofico, ma non siamo molto lontani a toccare la soglia di non ritorno. La differenza è minuscola e bisognerebbe camminare avanti tastando con cautela il terreno sotto i piedi. Per questo è arrivato il momento giusto di pensare al tempo, a quello che per esso possiamo noi tutti fare. E agire di conseguenza. Ascoltando la scienza, per una volta senza “ragionevoli dubbi”. Perché non sono ragionevoli.

IL TEMPO, ETERNAMENTE GALANTUOMO
di Andrea Martelli
Io credo che, alla fine, non ci sia poi tanta differenza tra la carriera di un calciatore e quella di uno studente.
Mi spiego meglio.
Non è detto che, chi dovesse diplomarsi o laurearsi in ritardo, un domani non possa essere ad esempio un buon medico o un buon avvocato. Prendete Luca Toni: è vero che ha messo piede nel “calcio che conta” solo a 26/27 anni, ma da lì in poi non ha mai smesso di segnare e ha anche vinto il Mondiale del 2006 con l’Italia da protagonista.
Al contrario, non è detto che, chi dovesse diplomarsi o laurearsi in tempo o addirittura in anticipo, un domani sarà sicuramente un eccellente ingegnere. Prendete Mario Balotelli: non aveva neanche 18 anni quando fece il suo esordio in una grande squadra come l’Inter e sembrava davvero un predestinato, ma alla fine non ha avuto e non sta avendo la carriera che senza dubbio meritava.
E ancora: durante il percorso scolastico o universitario può capitare che non si superi qualche compito od esame, ma ciò non vuol dire che non si è un bravo studente. D’altronde anche Roberto Baggio, ad USA ’94, sbagliò un rigore decisivo nella finale col Brasile, eppure nessuno ha mai dubitato che sia stato uno dei calciatori più forti di sempre.
Certo, l’ideale sarebbe diplomarsi e laurearsi nei tempi ed avere poi una lunga e brillante carriera. Ma il bello del calcio — e della vita — è che accanto ai vari Messi e Cristiano Ronaldo, cioè giocatori dal talento innato e dal ricco palmares, ci siano anche i vari Gattuso e Pippo Inzaghi: ovvero calciatori tecnicamente non dotatissimi ed esplosi non proprio subito; ma che alla fine, grazie al sacrificio, alla perseveranza e ad un grande cuore, dopo anni di gavetta sono comunque riusciti ad imporsi e a vincere tanto quanto i primi.

LA FORZA DELLA PAROLA
di Libera Iannetta
“Non c’è linguaggio senza inganno”, scrive Calvino ne “Le città invisibili”, un’insidia che tutti i regimi sfruttano a fini propagandistici, per poter illustrare con continuità la propria linea politica specialmente nelle situazioni gravi, tra conflitti e crisi internazionali, al fine di ottenere il consenso delle masse. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, distorce i fatti di Acca Larentia del 7 gennaio 2024, quando facinorosi hanno celebrato le commemorazioni per la strage del 1978 con il saluto romano e il rito del “presente”. La Zakharova, sostenendo che l’Occidente sostenga Kiev in quanto in Ucraina sono saliti al potere i neonazisti, sfrutta quanto accaduto ad Acca Larentia per rinvigorire la propaganda russa dopo la brutale aggressione del febbraio 2022 e l’inizio della cosiddetta operazione militare speciale per la denazificazione di un paese indipendente dal 1991. “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi è cosa, in mezzo all’inferno, e farlo durare, e dargli spazio”, fa dire Calvino a Marco Polo a conclusione de “Le città invisibili”, rivolgendosi a Kublai Kan. Italo Calvino e Marco Polo, di cui, tra l’altro, ricorrono quest’anno i settecento anni dalla morte. Due “esploratori” che osano immaginare, entrambi, imprese smisurate.

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
di Alessia Perazzo
I disturbi alimentari, anche detti del comportamento alimentare, sono disagi e patologie di natura psicologica. In passato si pensava colpissero maggiormente i soggetti in età adolescenziale e donne vicino all’età della menopausa; con il passare del tempo queste patologie si stanno riscontrando ugualmente anche nelle età restanti, diventando sempre più gravi.
I DCA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5% della popolazione: l’8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia.
Una persona anoressica, pur essendo visibilmente magra, non riesce a convivere con un corpo che ai suoi occhi sembra eccessivamente grasso, il problema del peso diventa ingestibile e importante, talmente ingestibile che la spinge ad abusare di medicinali a causa dei pasti saltati.
Personalmente non ho mai sofferto per mia fortuna di DCA, ma spesso venivo presa di mira poichè ero molto magra, soprattutto nell’età 10-14, nonostante io fossi come tutte le altre, o quasi.
Lo confesso perchè una delle motivazioni dei DCA è proprio il bullismo, che personalmente ho subito durante tutta la mia adolescenza, ma che proveniva già dal periodo di scuola elementare.
Quanti insulti per il mio corpo? Quante minacce da parte di compagne di classe? Per non parlare dei messaggi che arrivavano con le faccine del maiale…
Sono arrivata anche io a vedermi grassa in un corpo di circa 46 kg, la paura di prendere anche solamente 1 kg c’era, ma era più grande la paura che gli altri se ne potessero accorgere.
Per loro sfortuna ho sempre avuto lunghe, profonde e aperte conversazioni con la mia famiglia, di fatto coloro che umiliavano hanno fatto silenzio; la possibilità di dialogare con i propri cari purtroppo però non la possiedono tutti, altro motivo per la quale tante vittime dei DCA rimangono in silenzio, privandosi dell’opportunità di uscire da quel mondo buio.
Pesarsi la mattina e vedere un numero che non ti piace, con quel chilo di troppo, diventa come una specie di routine, faticosa da affrontare e difficile da ingerire.
Non pensiamo più al chilo in più… mangiamo tanto al pranzo di Natale, compriamo le caramelle che tanto ci piacciono, e accettiamo quel dannato cioccolatino che infondo sappiamo di voler mangiare.

UN METRO SOPRA LE NUVOLE: BAD BUNNY
di Andrea Bevilacqua
EGEMONIA LATINA
L’industria musicale dal 2020 ad oggi si può riassumere con un solo nome: Bad Bunny. L’artista portoricano ha stravolto il mondo con il suo blend di Reggaeton e Trap latina, contribuendo alla supremazia commerciale della musica sudamericana negli ultimi anni. Con “Un Verano Sin Ti”, album uscito nell’estate del 2022, Bad Bunny ha asfaltato record dopo record ottenendo il primato di disco più ascoltato di sempre su Spotify.
NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MANANA
Dalla sua posizione troneggiante il nativo di Puerto Rico si è mosso in maniera inaspettata, il suo nuovo album “nadie sabe lo que va a pasar manana” è quasi interamente un progetto Trap sperimentale, che fonde le origini artistiche di Bad Bunny ad un bagaglio tecnico e creativo acquisito nel corso degli anni. La presenza estremamente limitata di brani Reggaeton simboleggia uno status al di sopra delle regole di mercato, la possibilità di staccarsi da un’identità così imponente.
INGRESSO IN POMPA MAGNA
Le intenzioni di Bad Bunny sono chiare sin dai primi istanti del suo nuovo progetto. Con toni e sonorità solenni viene introdotta un’esperienza di ascolto estremamente rara nel mondo della musica commerciale; nel corso della sua durata estenuante “Nadie sabe lo que va a pasar manana” presenta uno stile che si appresta a regnare sull’industria, lanciato con forza e autorità dall’artista più riconoscibile degli ultimi tempi.
UNA NUOVA ALBA?
Per decifrare l’impatto di un album dalla portata così ampia non ci si può fermare alle prime impressioni, sarà solo il tempo infatti a dimostrare se la virata stilistica di Bad Bunny avrà il successo delle sue opere precedenti o meno. Tale verdetto non è da sottovalutarsi in quanto esso è lo specchio di un comportamento di massa, quello del consumatore medio, la colonna portante dell’industria musicale.
DOVE PENDE LA BILANCIA
“Nadie sabe lo que va a pasar manana” non è un album impeccabile, ma eccelle nel dimostrare che il successo commerciale sia una piattaforma di espansione artistica, un concetto terribilmente ignoto a troppi interpreti in giro per il mondo. Il nuovo album di Bad Bunny saprà svelare molto sulla concezione comune della musica sperimentale: serve un grande nome per portare il cambiamento? o ha più importanza la qualità della musica? oppure non accettiamo la rivoluzione neanche quando viene dall’alto?
“Nadie sabe lo que va a pasar manana” di Bad Bunny è un album solenne ed unico, riuscirà ancora una volta a cambiare il mondo?

LA SFIDA DI ELLY
di Alessandro Bocci
Un nuovo Pd. È questo il tentativo portato avanti dalla Schlein. Un partito democratico determinato ad uscire dalle ztl per radicarsi nelle periferie, che sostituisca la vocazione maggioritaria di Veltroni e l’agenda Draghi di Letta con le piazze della Cgil di Landini. Un partito che il cattolico democratico Fioroni non considera più la sua casa e nel quale torna a riconoscersi Cofferati. Un partito progressista, femminista, pacifista, ambientalista, che abbraccia la comunità lgbtqia+.
In politica, i ragionamenti per essere corretti devono essere illustrati con estrema chiarezza. E la Schlein è una donna di evidente onestà intellettuale. Quando Renzi aveva attuato politiche di centro introducendo il Jobs Act, lei era uscita dal partito. È rientrata e ha vinto le primarie con una piattaforma politica di sinistra. Ha il diritto-dovere di attuarla. E lo sta facendo, cercando di ottenere l’unità del partito su una linea precisa e ben delineata.
Quando un politico raffinato come D’Alema, per contrastare Berlusconi, aveva provato ad allargare i confini del partito democratico, Moretti lanciò il celebre: “dì qualcosa di sinistra!”. La sostanza è tutta qui. In Italia, come ha notato Cuperlo, la classe operaia vota a destra da oltre trent’anni, in Francia sostiene la Le Pen e in Germania è schierata con i neonazisti dell’Afd. Schlein ritiene che recuperare l’elettorato che era stato di sinistra sia la cosa fondamentale, senza dimenticare che per il Pci la classe operaia non era solo un bacino di consenso, ma anche un soggetto politico con l’ambizione di indicare una guida generale per il paese. In più, le terzietà nei quadri maggioritari non sono mai convincenti e un centro così litigioso, frammentato e poco attrattivo favorisce la linea dell’attuale segretaria del Pd.
Riuscirà la Schlein a sconfiggere il centrodestra? Di sicuro parte con uno svantaggio enorme, difficile da recuperare. Il fatto di “bucare” poco lo schermo non gioca a suo favore, ma nella società liquida disegnata da Bauman tutto può accadere e negli ultimi anni l’elettorato italiano si è dimostrato particolarmente volatile. Le elezioni europee sono alle porte e un risultato deludente del Pd potrebbe essere predittivo sugli esiti delle prossime elezioni politiche e indicativo della bontà delle scelte operate dalla Schlein e dalle persone a lei vicine.
Saranno gli elettori, con il loro voto, a decidere. Come sempre.

BUON NATALE A CHI SOFFRE, A CHI LOTTA E A CHI SPERA
di Francesco Maraia
Ogni anno, il Natale avvolge le nostre vite in un’atmosfera di magia e calore, portando con sé emozioni, tradizioni e speranze. È una festa universalmente celebrata che unisce le persone, indipendentemente dalle loro diversità culturali e credenze religiose. Tuttavia, il Natale non è solo luci scintillanti, regali sotto l’albero e festeggiamenti.
Le stesse luci che decorano le strade illuminano la speranza negli occhi dei piccoli eroi nei reparti di oncologia pediatrica, intenti a festeggiare un altro Natale. Questi bambini, nonostante la giovane età, danno un senso profondo a questa festività. Il loro Natale sarà caratterizzato dall’amore dei genitori, dalle amorevoli cure degli operatori sanitari e dalla vicinanza a chi lotta per la vita, una giovane vita. A questi coraggiosi guerrieri va il nostro affetto e la nostra vicinanza. Nonostante siano così piccoli, dimostrano di conoscere il senso della vita, di apprezzare il suo valore attraverso gli sforzi compiuti per difenderla. Mostrano a tutti noi l’amore che cerca di prevalere sul male.
Tuttavia, il male spesso prevale sull’amore, come nel caso delle donne vittime di violenza di genere. Anche per loro è Natale, e anche quest’anno sognano una vita serena, libera da soprusi familiari, nella speranza che l’amore non si trasformi in manipolazione e violenza. Il loro pensiero, come anche il nostro, va a coloro che non festeggeranno più il Natale.
La speranza che accompagna questo periodo è condivisa da chi fatica ad arrivare a fine mese e lotta strenuamente per garantire dignità alla propria famiglia. La stessa dignità è ricercata da chi non ha una dimora fissa e spera di essere considerato nonostante la sua situazione, non solo per qualche moneta, ma per il rispetto della propria umanità, nonostante la società lo abbia messo all’angolo.
Tutti loro conferiscono un significato profondo al Natale, andando oltre i cliché per sottolineare i valori del rispetto per la vita, della considerazione per la persona, della dignità e della solidarietà. Questi valori rappresentano la più profonda essenza dell’amore.
Le luci si spegneranno, le tavole verranno sparecchiate e i regali saranno aperti, ma questi valori rimarranno nel cuore di molti.
Auguro un sereno Natale a chi lotta per la vita, a chi soffre e spera in un cambiamento. Auguro un felice Natale a coloro che sognano la pace, auspicando che questa cominci dentro di loro, non in una relazione malsana. Buon Natale a chi cerca dignità e affronta coraggiosamente le difficoltà della vita, buon Natale a chi si sente solo, a chi è senza dimora e si sente escluso, con l’augurio che possano ritrovare se stessi e la strada verso casa.
A tutti voi lettori di Nuove Cronache, va il mio augurio di buone feste con l’auspicio di una società salubre, inclusiva, tollerante e pacifica.

LA PRIMA SCALIGERA E IL MITO VERDIANO
di Libera Iannetta
“Se la cassetta risponderà agli applausi tanto meglio”, scriveva Verdi in un telegramma all’impresario Fedrisio nel 1874, col suo noto senso pratico. E la prima scaligera del 7 dicembre 2023, che ha visto in scena il Don Carlo del maestro di Busseto, ha inaugurato la stagione del teatro più importante del mondo con il sold out anche per le rappresentazioni successive. Più che per i tredici minuti di applausi, per la discussa regia di Lluìs Pasqual, per l’eccezionale resa musicale che ha avuto nella direzione di Riccardo Chailly il suo punto di forza e nella superba Elina Garanca la sua punta di diamante, la serata sarà ricordata per le polemiche legate alla presenza della senatrice Liliana Segre accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa nel palco reale e al “Viva l’Italia antifascista” del giornalista Marco Vizzardelli, identificato dalla Digos. Malgrado la censura austriaca non esista da quasi due secoli, certe consuetudini, evidentemente, rimangono dure a cadere e riacquistano vigore quando ad occupare lo scranno più alto del Senato c’è chi sembra dimenticare l’antifascismo su cui si basa la Costituzione della Repubblica. D’altra parte, la potenza simbolica e culturale del messaggio verdiano, pur superando la natura politica dello stesso, scuote gli animi inducendoli a sentimenti intensi e il Don Carlo, con i suoi personaggi dilaniati, i toni cupi, le atmosfere dense, segna una tappa importante nell’itinerario di un compositore che, al di là delle sue stesse intenzioni, ha visto la propria musica quale motore dell’azione di uomini e donne del proprio tempo e la sua immagine assurta a mito. La presenza di Vizzardelli alla prima scaligera e di tutti coloro che lo hanno applaudito incarna quegli ideali di libertà che, nell’opera del maestro emiliano, trovano espressione in Rodrigo, il marchese di Posa, l’intimo amico di Don Carlo, il baritono interpretato da Luca Salsi, il personaggio che finisce condannato a morte, proditoriamente ucciso dai sicari del Santo Uffizio. Ma in questo caso e per fortuna, si sa, siamo nel campo della finzione letteraria.

STORIA DI UNA MEDIATRICE CULTURALE
di Nurgul Cokgezici
L’abbiamo incontrata a Londra, nel quartiere di Hackney. È una signora con un caschetto bianco e un volto dolcissimo. Ne ha viste di cose, incontrate di persone, ascoltate di storie difficili e dolorose. Zilan è la prima mediatrice culturale curda a Londra. “Dedico questa intervista a tutte le persone che accolgono la diversità colcuore”, dice. “Anche Rumi Zilan”, continua, “nella descrizione del Ney che piange per essere stato strappato dalle proprie origini, sottolinea che la maggior parte degli stranieri piange per essere stata separatadalle proprie origini”. Abbiamo parlato di tutto, restando per tre ore in un bar della City. Non si è trattato neanche di un’intervista ma di un grande cuore, il suo,che parlava e di uno più piccino, il mio, che ascoltava. “Sono venuta a Londra nel ‘76, ero una giovane rivoluzionaria, scappata via dal proprio paese. La prima cosa che ho fatto è stata chiedere l’asilo politico, poi mi sono messa a a studiare inglese. Ho iniziato a fare la mediatrice culturale con quelli che arrivavano qui per i miei stessi motivi. Mi piaceva aiutarli, rendermi utile, diventare la loro voce. L’obiettivo del mediatore linguistico culturale deve essere quello di prestare la voce a chi non ne ha. Non sei un’interprete, ma una mediatrice e c’è una grande differenza. Il mediatore culturale comunica con il cuore, mentre l’interprete usa la mente. E, quando fai un lavoro con il cuore, arrivi anche a non guadagnare nulla. Faccio il mio lavoro con amore. Pur di vedere riconosciuto il diritto di un profugo, sono pronta a tutto. Ho fatto anche lo sciopero della fame. Mi batto non per me ma per chi ha bisogno. Devi capire che sei la voce di chi è dovuto scappare via, o perché perseguitato o perché in fuga da un matrimonio combinato. E come si fa a tirarsi indietro e a non aiutare? Nessuno lascerebbe il proprio paese per un altro se non fosse costretto. Io sono andata via quaranta anni fa e, anche se l’Inghilterra mi dà tutto, anche se è un paese migliore del mio, non c’è giorno in cui il mio cuore non senta la nostalgia del mio piccolo villaggio. Non c’è prezzo per questo dolore. Se non capisco io le persone per cui faccio da mediatrice, chi può capirle?”.

IL FEMMINICIDIO È UN PROBLEMA SOCIALE
di Kateryna Semenchuk
Dal 1° gennaio al 3 dicembre 2023 sono stati registrati 109 casi di femminicidi, di cui 90 in ambito familiare e 58 per mano di partner o ex partner. Tutti conosciamo la tragica vicenda di Giulia Cecchettin, studentessa ventiduenne della provincia di Padova uccisa dal suo fidanzato. Lei, come altre 108 donne, ha pagato con la propria vita il prezzo del patriarcato che persiste nella nostra società. La storia di questa ragazza ha suscitato profonde riflessioni in molti di noi, ma non è semplice dare spiegazioni di alcune situazioni.
Da settimane sul web circolano notizie in cui si chiede di inserire all’interno delle scuole l’insegnamento dell’educazione sentimentale ed emotiva, con la speranza che possa ridurre la violenza che le donne subiscono sempre più spesso. Ma non è forse la famiglia a dover insegnare al bambino e alla bambina a rispettare il prossimo, specialmente del sesso opposto? Non dovrebbero essere, innanzitutto, gli adulti i primi a cambiare la loro mentalità? La morte di 109 donne in soli 12 mesi avvenuta per mano dei compagni o familiari non dovrebbe insegnarci qualcosa? Il femminicidio non dovrebbe essere un problema sociale e non soltanto delle donne?
Il femminicidio è un problema sociale e non una questione prettamente femminile!!!
Ritengo che sia difficile cambiare la mentalità di una comunità inserendo semplicemente l’insegnamento dell’educazione sentimentale ed emotiva all’interno delle scuole.. L’educazione dei bambini, maschi e femmine, senza alcuna distinzione, deve avvenire innanzitutto a casa, in famiglia e la scuola può e deve rappresentare un luogo di supporto, ma non può sostituire i genitori.
Gli adulti, in quanto tali, dovrebbero dare ai più piccoli l’esempio di come bisogna comportarsi, perché non bastano centinaia e centinaia di parole, i bambini e anche i ragazzi hanno bisogno dei fatti e gli adulti hanno un compito complesso che non può essere delegato: educare e dare l’esempio.
Però, non sono soltanto i bambini il “problema”. Nonostante ci troviamo nel 2023, quasi 2024, sono presenti ancora molteplici stereotipi sulle donne ed è presente una certa arretratezza culturale che non fa altro che fomentare il divario tra uomo e donna.
Per combattere il fenomeno del femminicidio e della disparità di genere che di fatto esistono ancora, dobbiamo impegnarci tutti affinché la società di domani diventi migliore di quella di ieri.

AFFIDO ETERO FAMILIARE: UN LEGAME OLTRE LA LEGGE
di Milena Ruffini
Arrivano di sera Marta e Stefano. Entrano, accompagnati, nella sala riunioni del mio studio legale e si accomodano sulle due sedie poste all’altro lato del tavolo di cristallo.
Percepisco il loro disagio … è la prima volta che vengono da un avvocato. Sono brave persone e non hanno mai avuto nessun problema legale, per fortuna!
Ora però hanno bisogno di aiuto.
“Da dove iniziamo avvocato?” Marta prende coraggio con un sospiro.
“ Da dove preferisce signora.” Io capirò …
Insegnante lei, industriale lui. Un matrimonio felice e tre figli stupendi. Due maschi ormai grandi e indipendenti e la piccola, ancora a casa dei genitori, sta terminando gli studi.
E poi lei, Francesca, che ora ha diciassette anni. La meravigliosa rosa che hanno cercato di addomesticare con cura, proprio come il Piccolo Principe, fin da quando all’età di tre anni è entrata nella loro casa grazie ad un affido disposto dal Tribunale per i Minorenni.
Francesca non ha mai avuto un carattere facile. Pur avendo una famiglia d’origine con cui ha sempre mantenuto i contatti, ha nell’anima il vissuto dell’abbandono. Si sente diversa e non riesce a colmare quel vuoto che avverte da sempre nello stomaco. La notte arrivano in sogno i mostri e un irrazionale senso di smarrimento ogni tanto la pervade all’improvviso e la rende irritabile e scontrosa soprattutto nei confronti delle persone che ama che certo prima o poi andrà a finire che la abbandoneranno a loro volta.
Sono sempre stati Marta e Stefano i bersagli delle sue ire. Li ha messi alla prova ogni giorno per quattordici anni. Ma mamma e papà, come li ha sempre chiamati lei, hanno saputo superare tutto con naturalezza.
Non è stato facile. Soprattutto quando Francesca tornava da casa della famiglia di origine (cosa che dopo i primi anni avveniva tutte le settimane). In quei momenti si chiudeva nel suo mutismo e non la si poteva toccare per almeno un paio di giorni.
L’adolescenza aveva accentuato ogni comportamento oppositivo e Francesca era diventata sempre più insofferente.
Per attirare l’attenzione aveva incominciato ad inventare storie e dire bugie ed i suoi genitori, da salvatori erano diventati orchi carcerieri.
Ma anche questa fase era stata affrontata da Marta e Stefano con amore, pazienza e comprensione. Si sentivano mossi da un’energia superiore, come fossero stati destinati a questa missione. Era per questo forse che nonostante le difficoltà non avevano mai avvertito la fatica.
Ora però la fatica era evidente, la si coglieva dai volti, dagli occhi, dal tono della voce.
Francesca tre mesi prima aveva chiesto ai Servizi Sociali di tornare a vivere dalla sua famiglia d’origine… lì le regole non erano così stringenti come quelle impartite da Marta e Stefano.
E la sua richiesta era stata incredibilmente accolta. I genitori biologici avevano fatto un percorso, alcune criticità personali e familiari erano state superate ed ora erano stati giudicati dal Tribunale idonei.
E così da un giorno all’altro il filo rosso che aveva unito questi genitori alla loro fragile rosa da accudire, si era spezzato con insindacabile giudizio delle istituzioni.
Il dolore inevitabile della lontananza si sarebbe attenuato se avessero saputo che Francesca stava bene, ed era finalmente serena.
Ma non successe questo.
Francesca aveva smesso di frequentare la scuola, aveva iniziato ad uscire tutte le sere con ragazzi deviati, rientrava a casa il mattino e spesso assumeva alcool o sostanze.
Il padre in più di un’occasione aveva chiesto l’intervento di Marta e Stefano oltre a qualche contributo economico…
La situazione era ben presto diventata insostenibile ed il Tribunale aveva deciso di trasferire Francesca in una comunità.
Ed ora?
Ora Marta e Stefano non hanno più alcun diritto né la possibilità di avere un contatto con Francesca che è ormai per loro come (anzi forse più) di una figlia. Né possono avere sue notizie tramite i genitori naturali a cui pure sono stati limitati gli incontri con la ragazza.
Le falle del sistema sono evidenti in casi come questo.
La L. 184 del 1983 “disciplina dell’adozione dell’affidamento dei minori” come modificata dalla L. 149 del 2001 regola l’istituto dell’affido eterofamiliare, istituito a tutela del minore, in casi di grave disagio familiare (maltrattamenti, abusi, trascuratezza dei bisogni di benessere fisico ed affettivo).
L’affido si distingue dall’adozione perché ha carattere temporaneo. Prevede cioè un allontanamento dalla famiglia d’origine e l’inserimento nel nuovo nucleo familiare per un lasso temporale determinato. Durante il periodo di distacco è previsto che sia i genitori naturali che il minore affrontino un percorso e mantengano la relazione, seppur sotto il controllo dei Servizi Sociali, affinchè possa poi esserci un rientro a casa.
Nei casi di disagio più grave, ove tuttavia si ritiene che non sia del tutto venuta meno la capacità genitoriale, proprio come quello della vicenda anzi narrata, è possibile che l’affido sia disposto dall’Autorità Giudiziaria sine die. È in sostanza il Giudice del Tribunale, in base alle relazioni dei Servizi Sociali che valuta se e quando è auspicabile che il minore rientri alla sua famiglia di origine.
Le valutazioni sono dunque demandate a professionisti che non sempre sono in grado di decifrare in modo corretto la personalità e le caratteristiche delle persone coinvolte e le dinamiche sottese ai vari rapporti in gioco. Spesso le risorse a disposizioni dei Servizi Sociali sono limitate e questo rende ancora più arduo gestire tutte le situazioni nel migliore dei modi, in particolare in questo periodo storico in cui i casi di disagio familiare sono in continuo aumento.
Non posso affidarmi a nessuna normativa a tutela delle ragioni di Marta e Stefano. Sulla carta non hanno alcun diritto. Ma il cuore mi impone di cercare una soluzione di buon senso che possa rispettare i diritti di tutte le parti coinvolte ma anche le dinamiche affettive in gioco.
E così intraprendo un dialogo aperto con i Servizi Sociali a cui formalmente Francesca è affidata appellandomi all’importanza della continuità affettiva del rapporto che per anni l’ha legata alla famiglia affidataria e chiedo che nel precipuo interesse della minore siano previsti incontri con Marta, Stefano e i Fratelli.
Francesca resterà in comunità seguita dai suoi educatori che la aiuteranno a proseguire nel suo percorso ma continuerà a vedere la sua famiglia affidataria e trascorreranno il Natale insieme.
Marta e Stefano, a prescindere dai decreti, resteranno per tutta la vita il suo punto di riferimento.

BOSNIA OGGI: COS’ABBIAMO IMPARATO?
di Slobodan Fazlagic
Suppongo che vi venga spontaneamente una reazione al titolo e ci si chieda: “Perché? Cosa avremmo dovuto imparare?” È lì che nasce ciò di cui vorrei parlarvi. Proviamo a fermarci un attimo e a riflettere.
Penso che la questione dovrebbe suonare familiare alle orecchie, venirci in mente, malgrado una memoria stracolma, sottoposta continuamente a nuovi stimoli.
Un residuo mnemonico, coperto dalla polvere della storia, sono le guerre balcaniche degli anni ’90 del secolo precedente. Trent’anni minuscoli per la storia, ma forse troppo lunghi per noi. Le guerre scoppiate subito dietro il nostro diretto confine alle quali abbiamo reagito in modo più che appropriato: ci siamo schierati con la parte offesa, con la parte innocente colpita dall’invasore barbarico. Abbiamo offerto l’empatia, la comprensione, il sostegno. Tanto quanto la coscienza evoluta di un popolo europeo consentiva di mettere in moto in un momento di crisi che travolgeva il prossimo. Siamo stati bravi e giusti. E poi ci siamo scordati di quella partita che ci sembrava finita. Sono subentrate nuove guerre qua e là, da cui la nostra consapevolezza viene costantemente sollecitata. Ma anche altri eventi eclatanti: la pandemia, i terremoti, i disastri crescenti dovuti ai cambiamenti climatici. La violenza privata nei rapporti personali si sta reimpostando fortemente sulla prima pagina della storia dell’umanità, la più primitiva.
Oggi? Un pensiero su come sia finita la partita bellica balcanica ci viene? È stata una pace vera o una guerra andata in letargo? Che cosa succede nelle zone a noi vicine? A parte l’ovvia devastazione materiale, quale altro segno una guerra lascia nel tessuto sociale, emotivo, cognitivo? In che modo se ne esce? Là sta crescendo una generazione postbellica con cui condividiamo il presente.
Una volta alcuni teorici consideravano la guerra come un taglio purificante, un’operazione chirurgica sul paziente socialmente malato, ma sinceramente non sono mai stato d’accordo con quel pensiero. Soprattutto per quanto riguarda i nostri vicini della spiaggia mediterranea. Non sono l’unico che ritiene il bacino mediterraneo il più significativo per l’umanità per lo spazio che occupa sul globo e nel corpo europeo. La storia antropologica lo mette nel nucleo del mondo pulsante. Ma perché non dire anche degli episodi relativi alle bruttissime cadute morali e alle violenze inaudite che hanno caratterizzato quelle terre? Quale impronta vitale hanno lascato le guerre avvenute nel cortile del vicino? Quali segnali ci vengono da là? È stata un’esperienza devastante, certo. Però, come vive oggi la gente in Bosnia, Croazia, Serbia, negli stati partoriti dalla disaggregazione, decisamente non pacifica, della ex Jugoslavia?
In breve, vive male. Peggio di quanto viveva prima. I politici odierni cantano di aver mandato nei rottami un sistema sbagliato o almeno obsoleto, di aver creato nuove democrazie, di aver portato la libertà a popoli che prima stavano soffrendo un regime non democratico. In definitiva, un traguardo storico importante. Ma se tutto è così latte e miele, come mai la gente vive impoverita, i giovani non vedono l’ora di scappare? La popolazione decresce con una percentuale mai vista prima. La discrepanza tra pochi ricchi e una maggioranza di poveri sta aumentando.
Nei Balcani le guerre hanno portato alla distruzione del tessuto industriale che all’epoca era a pari livello con i paesi più sviluppati a livello mondiale. Quando dico il sistema industriale penso anche alla mano d’opera specializzata e formata. Poi, finite le guerre, l’organismo industriale non è stato curato e salvato. È stato quasi completamente frantumato, svenduto agli oligarchi di tutto il mondo e trasformato in fonti istantanee per soldi facili. L’economia attuale si basa sui centri commerciali, il turismo, le scommesse. Insomma, sul riciclo del denaro, non sulla creazione.
Penso che ci dovrebbe interessare quell’esperienza e che dovremmo inserirla nel quadro generale. Perché là, per innescare lo scontro e preparare le basi per un attacco contro i vicini, hanno giocato molto con il nazionalismo, con l’odio etnico, con l’esclusività del domestico. Le conseguenze disastrose possono essere testimoniate oggi.
Non ci sarebbe da imparare da quel brutto esperimento sociale finito male e stare attenti alla xenofobia, all’insistenza sul favorire il ceto locale alle spese dei diversi decisamente in crescita in Italia ma anche nell’Europa intera? Si aggiungono il cosiddetto populismo, l’incremento delle informazioni dubbie e non confermate tramite le reti social, l’uso irruente della religione, il consumismo a minacciare il sistema in cui viviamo. Non è fuori da tutto questo anche il processo educativo che dovrebbe in primis fare da barriera verso le onde negative e creare la base per una società futura? Quanto siamo consapevoli e quanto abbiamo imparato dal destino dei nostri vicini sfortunati?

IL MITO CONTINUA: L’IMPATTO DURATURO DEI BEATLES SULLA MUSICA MODERNA
di Giorgio Caporale
Nella storia senza tempo della musica, i Beatles rimangono una presenza universale, un faro che continua a guidare generazioni attraverso le meraviglie della creatività musicale. In queste settimane l’attenzione si è concentrata su di loro, con l’uscita del loro ultimo brano, un’opera postuma di John Lennon “Now and then”, l’ultima canzone dei Beatles è il testamento delle quattro leggende, che ha catturato l’immaginazione di fan vecchi e nuovi.
I Beatles, con le loro melodie rivoluzionarie e testi che toccano corde universali, hanno plasmato il panorama musicale in modo unico. La loro influenza persiste, nonostante le sfide del tempo e le mutevoli tendenze musicali. La recente uscita del brano inedito scritto da John Lennon ha rinnovato l’interesse per la magia intramontabile della band.
Oltre a suscitare emozioni nostalgiche, questo evento solleva domande intriganti sul rapporto tra la musica dei Beatles e quella contemporanea. In un’epoca dominata da nuovi generi e stili, il perché della persistente risonanza dei Beatles diventa una riflessione importante. La risposta potrebbe risiedere nella loro abilità senza tempo di catturare l’anima umana attraverso la musica, superando barriere generazionali.
Il brano di Lennon, pubblicato dopo anni dalla sua scomparsa, aggiunge un capitolo significativo alla loro storia. La sua voce, ancorata nella nostalgia e permeata di sincerità, offre un’esperienza unica agli ascoltatori moderni, sottolineando come la musica dei Beatles possa ancora toccare profondamente le corde dell’umanità.
Questo evento sottolinea anche il ruolo cruciale della conservazione della musica storica nel contesto moderno. La riscoperta di opere dimenticate può arricchire il panorama musicale, collegando il passato al presente. La capacità della musica dei Beatles di adattarsi a nuovi contesti e parlare alle generazioni successive è un tributo alla loro genialità intramontabile.
In conclusione, mentre il mondo della musica si evolve incessantemente, i Beatles rimangono pilastri immutabili. L’uscita di questo brano “Now and then” è un promemoria affascinante del loro impatto indelebile sulla cultura musicale.
Il legame tra i Beatles e la contemporaneità persiste, dimostrando che la loro musica continua a vibrare nell’anima di chiunque ascolti con il cuore aperto.

COACH SKINNY: PLAYERS CLUB ’23
di Andrea Bevilacqua
L’ORACOLO DEL RAP GAME Il producer Night Skinny ha dimostrato nel corso degli anni un innato fiuto per gli artisti emergenti e nei suoi progetti ha da sempre riservato un grande spazio alle sue scommesse musicali. Coloro che si affidano alla supervisione del produttore molisano diventano suoi alunni e protetti, questa manovra si traduce in una preziosissima spinta verso l’alto per artisti in cerca del salto.
CYPHER MADE IN ITALY
Il “Players Club ’23” è un progetto che si ispira al “cypher”, un’esibizione rap dal vivo a cui prendono parte più interpreti cantando sulla stessa base l’uno dopo l’altro. Il format annuale comunicato dal nome stesso anticipa un prosieguo ispirato alla rivista di Hip-Hop statunitense XXL Magazine, portatrice del cypher periodico con i migliori emergenti del momento. Night Skinny ripropone l’ideale con una selezione di giovani esponenti provenienti da tutta Italia, accomunati da un senso rivoluzionario che apportano alla loro musica.
RISING STARS GAME
Nerissima Serpe, Artie 5ive, Tony Boy, Papa V, Low-Red, Digital Astro e Kid Yugi sono i sette protagonisti della nuova scena che si susseguono sul beat dello zio Skinny, un’opera dal suono distorto e sporco che personifica lo stretto legame del progetto con la strada. In 6 minuti si svolge uno spettacolo in cui i promettenti nomi mettono in mostra i loro immaginativi dando prova di carattere e stile innovativo; la voglia di splendere aleggia nella stanza.
LA NUOVA SCENA È UNA RETE
La chimica di squadra che il cypher di Night Skinny inietta nei suoi interpreti tesse per loro una rete interconnessa che li lega musicalmente e personalmente. Nei rispettivi progetti posteriori al “Players Club ’23” le strade dei sette si sono già intrecciate e continuano a collaborare attivamente, il sentimento che si è creato è quello di stima reciproca e di obiettivo condiviso, la ricetta perfetta per la prosperità.
IL FIUTO NON MENTE
Uno dopo l’altro i protagonisti del progetto stanno riscontrando positività nella scena rap, oltre alla rapida colonizzazione dei social network con canzoni e video che li ritraggono. Sembra che il fiuto di Night Skinny per i nuovi talenti sia ancora lo stesso che ha spinto Rkomi, Tedua, Ernia e molti altri ai tempi di “Pezzi”. La sua nuova squadra si sta imponendo in quello che sarà il futuro del genere in Italia, portando con se un’onda rivoluzionaria di cui presto vedremo gli effetti.
Night Skinny è stato il regista della scena rap per l’ultimo decennio, e lo sarà anche per il prossimo.

ARTICOLO 34
di Alessandro Bocci
L’Italia è un paese immobile. Chi nasce ricco muore ricco, chi nasce povero muore povero. Nulla è più profondamente immorale di ciò.
Pietro Calamandrei era convinto che la scuola avesse il compito di formare la classe dirigente, che doveva essere sempre aperta e rinnovata. Calamandrei riteneva poi che l’articolo più importante della Costituzione fosse il trentaquattresimo, per il quale i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, avevano il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Per tutta una serie di ragioni, le cose andarono diversamente. Verso la fine degli anni sessanta, parte del mondo intellettuale ritenne che la valorizzazione del merito implicasse una discriminazione nei confronti dei meno dotati. Fu la stagione delle occupazioni universitarie, del diciotto politico e degli esami di gruppo.
Per una curiosa eterogenesi dei fini, come conseguenza di quell’impostazione culturale, alla fine del percorso universitario si ripropongono oggi le condizioni di partenza e ciò non può che sfavorire i ceti più deboli. Ad avvantaggiarsi dell’inflazione dei titoli di studio sono infatti coloro che già dispongono di una fitta ed adeguata rete di relazioni sociali. La negazione del merito ha effetti devastanti proprio sul terreno del contrasto alle disuguaglianze.
La strada da seguire era dunque un’altra. Era la strada che ci veniva indicata dalla Costituzione. Invece, gli importi destinati alle borse di studio per gli studenti meritevoli e privi di mezzi continuano ad essere imbarazzanti. Occorre quindi che la Repubblica intervenga al più presto investendo risorse adeguate, che dovrebbero essere attribuite per concorso.
In più, occorrono maggiori investimenti per le scuole pubbliche, in modo da garantire pari opportunità a tutti gli studenti. In particolare, nell’istruzione primaria e secondaria, dovrebbero essere offerti robusti corsi pomeridiani ai ragazzi, sia per sostenere quelli in difficoltà sia per valorizzare le eccellenze. Nella scuola di don Milani, a Barbiana, il tempo scuola era di dieci ore giornaliere.
Recentemente un sondaggio di Demos & Pi, realizzato per il quotidiano “la Repubblica”, evidenzia come l’81% degli italiani sia favorevole alla valorizzazione del merito nel sistema scolastico e la percentuale rimane alta anche al variare di età, sesso, appartenenza politica ed estrazione sociale degli intervistati.
Se il legislatore saprà operare nel senso sopra indicato si ridurranno le disuguaglianze e si favorirà la mobilità sociale, raccogliendo in modo significativo quanto disposto dalla Carta costituzionale e richiesto dalla società civile.

QUANTO È PERICOLOSO ESSERE DONNA NEL 2023?
di Alessia Perazzo
Mi chiamo Alessia Perazzo, sono una ragazza di 18 anni, vivo in un quartiere piuttosto tranquillo, ma la sensazione di paura quando metto piede fuori casa non manca mai. Oramai nel momento in cui devo uscire, da sola o in compagnia, porto sempre nella mia borsetta uno spray al peperoncino, un oggetto di piccole dimensioni ma che nel 2023 mi fa sentire più sicura.
Purtroppo, i casi di omicidio non fanno che aumentare in maniera dismisurata; fino ad ora, nel 2023 sono state 104 le vittime di Femminicidio da parte di familiari, ex fidanzati oppure ex mariti.
Ogni volta che sento queste notizie al telegiornale, non vorrei fare altro che urlare al mondo intero che noi donne siamo altrettanto meritevoli di una vita libera e spensierata quanto loro.
Pochi giorni fa è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, una ragazza di 22 anni, precipitato in un canalone che si trova tra la zona del Lago di Barcis e Piancavallo. La giovane risultava scomparsa da una settimana assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta che, dopo aver aggredito la donna, ha abbandonato Giulia al bordo della strada e l’ha lasciata rotolare lungo un dirupo per una cinquantina di metri.
Giulia Cecchettin è stata uccisa da svariate coltellate che l’hanno colpita alla testa e al collo… la fine straziante di una vita che tutti noi, donne e uomini, meritiamo di vivere a pieno.
Abbiamo sperato tutti in un finale diverso per la cara Giulia, differente da quello che ormai questa società ci costringe a prevedere. Ci sembra assurdo il caso di una sola donna uccisa, e pensare che ce ne sono altre 103, che fin da piccole speravano di avere una vita normale come quella di tutti, che si svegliavano la mattina pensando di affrontare una giornata come le altre, che pensavano di aver trovato la loro dolce metà… e che invece sono state uccise da chi giorno dopo giorno le teneva per mano. Tutte donne che sono state molestate, picchiate, strangolate o accoltellate più e più volte, in nome di un amore che amore non era.
Vivo nella speranza che tutto ciò possa finire il prima possibile, che gli uomini smettano di togliere la vita a un essere umano che è nato con i suoi stessi diritti, che l’uomo accetti la distanza da una donna che probabilmente non è più innamorata di lui e che vuole cambiare vita e persona, non riuscendoci per timore delle conseguenze.
Essere una donna nel 2023 fa paura, e fa paura anche dirlo. Mi privo di uscire la sera se non sono in compagnia con amici maschi, ma anche in quel caso, come posso fidarmi e stare tranquilla dopo una serata passata davanti al telegiornale con i miei genitori, che ormai hanno paura anche di mandarmi a prendere un gelato con la mia amica, che non possono stare spensierati quando non sono a casa e si fanno mille domande, e che si preoccupano se non invio il messaggio “Mamma sono arrivata a scuola/casa”.
Inizia tutto da uno schiaffo “leggero”, da insulti dalla persona che si ama; questo non è amore, sono i primi segnali di una relazione tossica e soffocante, segnali che dovrebbero farci capire che la persona che ci picchia non è la stessa persona che abbiamo conosciuto e di cui ci siamo innamorate.
Oggi troppo spesso noi ragazze ci accontentiamo della persona che abbiamo accanto, perché abbiamo paura di lasciarla, di ricevere un “No” come risposta.
Oggi dobbiamo imparare ad accettarci per quello che siamo, ad amarci, a proteggerci da tutto e da tutti.
Oggi la morte di Giulia ci ricorda tutte le altre.
Oggi ci sentiamo più vuote e indifese di ieri.
Infine, da ragazza, prego per un futuro che non ci presenti tutta questa violenza, spero che la mia futura figlia possa svegliarsi la mattina e uscire con un ragazzo che la rispetti e che voglia solo il bene per lei.

MILANO CANTIERE VERDE
di Francesco Maraia
Milano, città in costante evoluzione, sta abbracciando una prospettiva di innovazione urbana attraverso due progetti chiave che plasmeranno il suo futuro: il piano di riqualificazione urbana Milano 2030 e l’iniziativa di piantumazione di alberi, Forestami.
Forestami è un progetto ambizioso supportato dalla Città metropolitana di Milano e da varie Istituzioni con cui si propone di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030. L’obiettivo di avere un albero per ogni abitante di Milano punta a creare un ambiente urbano più sano, favorire la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici. Ad oggi sono stati piantati circa 500.000 alberi. Oltre a migliorare la qualità dell’aria, Forestami aspira a diventare un polo rigenerativo, offrendo spazi verdi che arricchiscono la vita della comunità.
La trasformazione verde di Milano non riguarda solo l’aspetto estetico della città, ma ha un impatto significativo sulla salute e sul benessere dei suoi abitanti. Maggiore copertura vegetale significa aria più pulita, un clima più fresco e una migliore qualità della vita. Inoltre, la presenza di spazi verdi promuove uno stile di vita attivo, incoraggiando le attività all’aperto e la socializzazione.
Il piano Milano 2030, che opera in sinergia con Forestami, è il fulcro della trasformazione urbana della città. Questo progetto ha reso possibile riqualificare diverse aree dismesse in spazi moderni, multifunzionali e sostenibili. Esempi iconici di questa trasformazione includono l’area di Porta Nuova, una volta industriale, ora una zona pulsante con architetture innovative, parchi e spazi pubblici accoglienti. Questo piano punta a rinnovare quartieri, riqualificare il patrimonio edilizio e creare una rete integrata di spazi urbani più accessibili e inclusivi. La riqualificazione di numerosi quartieri di Milano è un elemento chiave del piano di sviluppo urbano.
L’armoniosa sinergia tra Forestami e Milano 2030 rappresenta l’unità di intenti per un futuro collettivo migliore. Mentre attraverso il progetto Forestami si cerca di generare spazi verdi e mitigare le sfide ambientali, con Milano 2030 ci si concentra sul rinnovamento degli spazi urbani, creando un tessuto sociale più solido e connesso. Questa combinazione di iniziative è il segnale di un impegno congiunto verso una Milano più sostenibile, resiliente e inclusiva, confermando l’intento di costruire una città all’avanguardia dell’innovazione e della sostenibilità urbana.

IL RISULTATO È DAVVERO L’UNICA COSA CHE CONTA?
di Andrea Martelli
Quando ero piccolo, avevo il brutto “vizio” di reputare una squadra di calcio come più forte di un’altra solo in base al diverso risultato che aveva ottenuto, rispetto a quella, contro una stessa compagine terza.
Se ad esempio nell’ottobre 2002 l’Inter aveva battuto la Juventus 3 a 0, mentre il Milan aveva sconfitto i bianconeri solo per un 1 a 0, ero portato a ritenere i nerazzurri più forti dei cugini milanisti soltanto perché loro, rispetto a quest’ultimi, si erano imposti sulla “Vecchia Signora” per l’appunto con due gol in più.
Nel tempo, però, ho capito che questo ragionamento era del tutto sbagliato, per un motivo molto semplice: ogni partita è una storia a sé. Ed è una storia a sé perché sono tanti i fattori che, in occasione di una gara, possono incidere sul gioco di una o di entrambe le squadre e quindi sul risultato finale: la stanchezza, la squalifica o l’infortunio di uno o più giocatori, le condizioni ambientali e/o quelle del campo, gli errori arbitrali e così via.
Pertanto, tornando all’esempio di prima, se quella volta l’Inter aveva surclassato la Juve, non era detto che poi, quando avrebbe affrontato il Milan, avrebbe automaticamente vinto: poteva accadere benissimo il contrario ed anche che, nel prossimo match con i bianconeri, sarebbero stati quest’ultimi ad ottenere i 3 punti, magari pure con una goleada.
Ora, questo discorso dev’essere fatto, secondo me, anche per gli esami universitari: non si può dire che Marco sia più intelligente di Luca soltanto perché il primo a Diritto Privato ha preso 30, mentre il secondo 18. E questo perché, anche in occasione di un esame universitario, tanti sono i fattori che possono incidere sulla prestazione dello studente e quindi sulla valutazione finale: la stanchezza (sempre lei), l’essere emotivi o meno, il periodo in cui si è preparato l’esame, il tempo che ci si è dedicato, l’essere capitato con un assistente piuttosto che con un altro, l’interesse o meno per la materia.
Pertanto, se Marco a Privato ha preso 30, complimenti vivissimi! Ciò non vuol dire però che lui sia, sol per questo, un prodigio e che Luca invece valga meno. E non vuol dire neanche che sicuramente Marco prenderà 30 anche a Penale, mentre Luca ancora 18: può capitare sia che accada il contrario, sia che Marco venga bocciato mentre Luca no; sia addirittura che vengano bocciati entrambi.
Insomma, la forza di una squadra rispetto ad un’altra e l’intelligenza di un ragazzo rispetto ad un altro non possono e non devono essere misurati attraverso i numeri: l’unica cosa che, secondo me, conta davvero e che esprime realmente il valore di un team o di uno studente è ciò che uno sa fare e sa. DENTRO E FUORI IL CAMPO DA CALCIO, DENTRO E FUORI L’UNIVERSITÀ!

STORIA DI UNA VITA DISTRUTTA
di Kateryna Semenchuk
Nonostante la guerra in Ucraina sia ancora in corso, il notiziario TSN di proprietà del canale 1+1, in collaborazione con la giornalista Natalia Yarmola, è riuscito a produrre un documentario intitolato “Vedere il fondo”.
Nel film viene raccontata la vicenda di uno dei più grandi disastri causati dall’uomo negli ultimi decenni – la distruzione della centrale idroelettrica di Nova Kachovka (Regione di Kherson) – che ha messo in pericolo la vita di milioni di ucraini e ha causato danni importanti all’ambiente; il tutto viene accompagnato da immagini esclusive del fondo del bacino idrico di Kachovka e racconti poco conosciuti della storia della centrale idroelettrica. Inoltre, sono presenti diverse interviste e tra queste un ruolo rilevante ha il racconto di Oleg Vashchenko, direttore della centrale idroelettrica che ormai non esiste più.
L’uomo è nato e vissuto a Nova Kachovka, una città situata nella regione di Kherson. Durante l’intervista Oleg si arrischia a raccontare la sua tragedia personale, iniziata molto prima del 6 giugno 2023 (giorno della distruzione della diga).
24 febbraio 2022
Nonostante i bombardamenti e l’avvicinamento delle truppe russe, Oleg era andato al lavoro. “Alle 10.40 erano già alla stazione. Una parte dei militari era entrata dentro e ci ha accerchiati… c’erano davvero tanti mezzi militari”, racconta il direttore. Lui, insieme a circa 200 impiegati, è stato preso come prigioniero e per ben 4 mesi ha vissuto e lavorato sotto l’occupazione del nemico. Per non cadere nel collaborazionismo, quando i russi hanno iniziato ad obbligarlo a registrare la centrale come russa, Oleg Vashchenko ha deciso di fare una mossa disperata: “Siamo riusciti a rubare i documenti costitutivi della centrale, portarli via e distruggerli, in modo che a loro non rimanesse nulla. Abbiamo fatto un po’ i partigiani…”, racconta. “Quando volevamo scappare, io e mia moglie abbiamo passato due settimane ad allenarci sui posti di blocco. Come? In modo da non essere uccisi. Ho visto coi miei occhi molte persone ammazzate. Quando arrivavi al posto di blocco dovevi alzare le mani in su in modo che gli occupanti potessero vederti, se no semplicemente ti sparavano addosso. Quando stavamo andando da Nova Kachovka ad Armjansk (Crimea) abbiamo passato 18 posti di blocco. Sono dovuto scappare tra il sabato e la domenica perché lunedì mattina mi avrebbero già cercato al lavoro. Dalla Crimea, attraverso Vladikavkaz (Russia), siamo andati in Georgia e da lì in Turchia e poi infine in Romania. In Georgia ci aveva raggiunti nostra figlia, la quale ci ha portati finalmente in salvo a casa sua in Romania”.
Cosa abbia provato Oleg in quelle circostanze, con militari in ogni dove, bombardamenti, ipercontrollo di ogni passo, persone viste morire per il semplice fatto di non aver eseguito gli ordini degli occupanti russi e molto altro, lo possiamo soltanto immaginare. L’intervista del direttore della centrale da parte della reporter è accompagnata da molte lacrime, perché la guerra non porta soltanto alla distruzione del territorio di una nazione, ma anche dei cuori delle persone che ci abitano.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL
di Nurgul Cokgezici
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014.
A Diyarbakır, città curda situata nel sudest della Turchia, è iniziato il processo di formazione della Convenzione di Istanbul, alla quale la stessa Turchia si è ritirata per decisione del presidente Erdogan. La denuncia di Nahide Opuz alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, vittima di violenze da parte del marito, non solo ha condannato per la prima volta la Turchia per violenze contro le donne, ma ha anche aperto la strada alla Convenzione di Istanbul.
Nahide, che viveva a Diyarbakır, si è presentata all’ufficio del pubblico ministero sette volte dopo il 1995 con la motivazione di essere stata vittima di violenze da parte del marito. L’ultimo degli attacchi è avvenuto nel 2002, nel corso del quale il marito di Nahide ha ucciso la suocera. Mentre il processo al marito arrestato continua, Nahide ha sporto denuncia contro la Turchia presso la CEDU perché non le è stata data una protezione, sebbene abbia esposto 36 volte denuncia contro il marito.
Nel caso di Diyarbakır, il marito è stato condannato a 25 anni e 10 mesi di reclusione il 26 marzo 2008; ma è stato rilasciato. Nel frattempo Nahide, che si era trasferita a Smirne, si era rivolta all’ufficio del pubblico ministero, dicendo che temeva di essere uccisa dal marito.
Gli avvocati di Nahide si sono rivolti anche alla CEDU, chiedendo tutela. Con la lettera del 16 maggio 2008, il segretariato ha trasmesso la richiesta al governo per il suo parere e ha invitato la CEDU a informare sulle misure che devono essere adottate dalle autorità. A quel punto, la CEDU ha avvertito l’ufficio del procuratore capo di Diyarbakır e ha chiesto l’adozione.
Nella decisione del 9 giugno 2009, la CEDU ha ritenuto che Nahide avesse ragione e ha condannato la Turchia. Questa decisione è stata registrata come la prima sentenza pronunciata alla Turchia dalla CEDU in merito alla violenza contro le donne. Nella decisione della CEDU, il Consiglio d’Europa ha affermato che gli Stati membri accettano tutti i tipi di violenza domestica come reati penali, i tribunali devono adottare misure precauzionali per proteggere le vittime, garantendo che il persecutore non si riavvicini alla stessa. Si raccomanda inoltre che le autorità di contrasto, le istituzioni sanitarie e dei servizi sociali creino un protocollo obbligatorio per quanto riguarda il loro comportamento in tali questioni.
Questa decisione ha ispirato la Convenzione di Istanbul, che dovrebbe proteggere tutte le donne vittime di violenza fisiche e psicologiche.

A PROPOSITO DI NOI…
di Alessandro Bocci
Nuove Cronache si presenta come un luogo aperto, uno spazio di dialogo costruttivo e propositivo, un laboratorio in cui le diverse storie umane rappresentano un’occasione di arricchimento reciproco.
Di orientamento popolare, riformista ed europeista, Nuove Cronache trova nella Costituzione il documento di riferimento ideale e promuove, anche ospitando sensibilità differenti, riflessioni e confronti su tematiche di ordine politico, economico e culturale che caratterizzano la società.
Collaborano a Nuove Cronache persone di diversa formazione, di differente età anagrafica e tanti sono gli argomenti sui quali ci confronteremo: inverno demografico, fenomeni migratori, cambiamenti climatici, disuguaglianze sociali, condizione della donna, problematiche scolastiche, globalizzazione economica, dimensione giovanile. E naturalmente ci occuperemo di Milano, una città splendida, con prospettive importanti e che merita di essere conosciuta ed apprezzata nella sua interezza.
Nel momento in cui esce il primo numero di questa rivista, una pace giusta e rispettosa dell’integrità territoriale dell’Ucraina appare ancora lontana a causa delle pretese imperialistiche degli aggressori russi e i terroristi di Hamas si sono resi responsabili di uno spaventoso pogrom all’interno dello stato di Israele. Un atto di violenza contro la popolazione ebraica alla quale Hamas nega le ragioni stesse dell’esistenza. Il sogno che aveva alimentato gli accordi di Camp David e di Oslo, due popoli due stati, appare del tutto tramontato. Israele ha il diritto di difendersi, ma ha il dovere di farlo nella coscienza della misura e del limite. Come la popolazione ebraica, anche quella palestinese è vittima del terrorismo islamico.
Anna Politkovskaja è stata uccisa dagli sgherri putiniani e Novaja Gazeta non esiste più. Riprendendo il motto di quel periodico fondato da Gorbaciov, nella palestra di Nuove Cronache useremo le stesse lettere per scrivere parole diverse.

CRONACA DI UN RIENTRO A CASA SOTTO I BOMBARDAMENTI
di Kateryna Semenchuk
24 febbraio 2022, mia mamma stava lavorando a Kiev in una panetteria sotto la metro’, il suo posto di lavoro dista 200 km da casa.
Era la fine del suo turno di lavoro e per questo era disinformata su cosa stesse accadendo nel mondo. Mentre in Italia tutti i telegiornali parlavano di questa possibile guerra, in Ucraina il popolo non era minimamente informato. Dopo numerosi tentativi di comunicare con mia mamma finalmente riesco a mettermi in contatto.
La nostra prima chiamata:
<< Mamma, ciao, tutto bene? Com’è la situazione lì? >>.
<< Amore, qui va tutto bene. Siamo tutti vivi. Da qualche parte si sente sparare… c’è molta agitazione >>.
<< Ho capito. L’importante è che state tutti bene>>.
25 febbraio 2022, la nostra seconda chiamata:
<< Ciao mamma, come stai? Com’è la situazione in città? >>.
<< Dove sono io si sentono gli spari e c’è l’allarme aereo. Non posso andare a casa, perché stanno bombardando Chernihiv e anche vicino a casa nostra la situazione è la stessa >>.
<< Non ho veramente idea di cosa succederà. Mi dispiace veramente molto e non so come fate a sopportare tutto questo >>.
<< È la guerra. Domani proverò a partire per casa >>.
26 febbraio 2022:
<< Pronto, mamma… >>.
<< Tesoro, ascolta, sto cercando di andare a casa. Sono qui alla fermata. Ci sentiamo dopo, ho anche il cellulare scarico >>. In quel momento non sapevo ancora che il “ci sentiamo dopo” sarebbe durato 3 giorni. Nessuna chiamata, nessun messaggio, soltanto un eterno silenzio. Ero riuscita ad avere qualche informazione da papà, ma ovviamente al telefono non si poteva dire più di tanto.
1 marzo 2022, finalmente mamma era arrivata a casa e ha raccontato quanto era accaduto:
<< Tesoro, sono a casa, va tutto bene >>.
<< Cos’è successo? >>.
<< A Kiev non circolavano mezzi pubblici, perché bisognava risparmiare il carburante per i mezzi militari e le ambulanze. Ho fatto chilometri e chilometri di strada a piedi, ma nell’ora del coprifuoco mi hanno fermata i militari ucraini e mi hanno portata in un rifugio militare segreto. Non sapevo dov’ero, non potevo chiamare nessuno. Mi hanno verificato i documenti, fatto l’interrogatorio e il giorno dopo lo stesso iter. Per fortuna mi hanno permesso di fare una chiamata e ho sentito papà e le bambine. Non potevo spiegargli cosa stava succedendo, ma ho soltanto avvisato che ero viva. Da lì mi hanno portata a Chernihiv dove ho trascorso un’altra notte. I russi hanno sparato tutta la notte, non puoi capire la paura. Alla mattina ho deciso di riprendere il mio viaggio e magari fare un autostop. Mi sono trovata davanti ad un vasto campo e ho iniziato a camminare. La gente mi urlava: “Signora, è pericoloso! Ci sono le mine. Ma dove va?”. A me, però, non importava. Volevo rivedere i miei figli e stare con loro. Per fortuna è andato tutto bene. Tua mamma ha attraversato un campo minato. Ti rendi conto? Dopo ho incontrato un signore che si è offerto di dare un passaggio a chi doveva andare nella direzione di casa nostra e mi ha accompagnata al paese; poi papà è venuto a prendermi e abbiamo ringraziato l’autista. Ora sono a casa, ma la rete telefonica non sempre funziona e sto utilizzando internet del cellulare, ma non so per quanto durerà. I russi stanno bloccando le reti di comunicazione nelle zone vicine alla frontiera e non so quando potremo risentirci >>.
Fortunatamente dopo quel giorno, nonostante i problemi di comunicazione, siamo riuscite quasi sempre a mandarci almeno un messaggio, come dire: “Ci sono ancora”.

L’UOMO CURIOSO È L’UOMO VINCENTE
di Barbara Ciccone
Dal quotidiano contatto con le nuove generazioni accade inevitabilmente di dover riconoscere momenti in cui le si avverte sottotono, per motivi diversi: stanchezza, ansia da prestazione, disinteresse per lo studio, vulnerabilità emotiva. Esperienze umane rispetto alle quali tutti rischiamo di imbatterci almeno qualche volta nella vita. Ma quando ad essere abbattuta è la curiosità, lasciandoci inchiodati in un silenzio assordante, il sospetto dello smarrimento prende forma, cristallizzando la realtà in maniera sempre più imponente e mortificante. Infatti, nel tentativo diretto di chiedere ai giovani quali sono le loro curiosità ci si rende conto della fatica che emerge nel dover dare una risposta concreta. A volte il tentativo di sforzarsi nel cercarla una risposta resta senza risultati. Indubbia la constatazione, confermata dagli stessi ragazzi, che nella maggior parte dei casi non ci si è soffermati mai sulla questione. Essere curiosi è ben altro che intromettersi in faccende altrui o assumere significati dettati da giudizi senza fondamento o ancor peggio da pregiudizi assurdi. Essere curiosi conforta l’intelletto rispetto alla desiderosa voglia di conoscere, sapere, apprendere, sperimentare, esplorare, uscire dai propri schemi per provare sensazioni che possano meglio orientare i propri scopi, agganciando anche il desiderio di interagire con se stessi, con gli altri, con il mondo. La curiosità crea interesse, allontanandoci dalla noia e dall’appiattimento e liberandoci dall’apnea culturale nella quale spesso ci si ritrova a dover fare i conti. Da ciò deriva quella connotazione positiva di grande interesse per gli studiosi e per la gente comune, che coinvolge la ragione, in termini di comportamento indirizzato alla ricerca del nuovo e del diverso, e l’emozione, come soddisfazione e appagamento che conduce ad uno stato di benessere psicofisico. Michel Foucault afferma che il curioso è colui che ha premura, che presta attenzione a ciò che esiste e quindi a ciò che è reale e a ciò che potrebbe esistere e quindi a ciò che è possibile, nel gioco filosofico di non immobilizzarsi davanti al reale per assimilare una conoscenza conveniente, ma assumere un atteggiamento che possa esercitare il nostro sguardo a guardare le cose diversamente e a condurci oltre la conoscenza di ciò che ci è familiare. Lasciamo quindi che la curiosità guidi la nostra motivazione verso nuove e diverse modalità di approccio alla realtà e ai contenuti in essa custoditi; nella diversità si fonda la nostra unicità che ci rende vincenti: l’uomo curioso è un uomo vincente, perché percorre sentieri che altri ancora non conoscono, fortificando esperienze inedite.

UN NUOVO CASO “MAHSA AMINI”
di Nurgul Cokgezici
Una ragazza curda iraniana sedicenne, Armita Garawand, è finita in coma dopo essere stata “aggredita” martedì scorso in una stazione della metropolitana di Teheran.
Secondo un’agenzia di stampa francese, le autorità hanno affermato che non vi è stato alcun conflitto tra la ragazza e le istituzioni ufficiali e che la ragazza “ha perso conoscenza” a causa del calo della pressione sanguigna.
Invece l’organizzazione Hengaw, che monitora i diritti dei curdi in Iran, ha dichiarato: “La sedicenne Armita Garawand è caduta in coma domenica a seguito di un violento attacco fisico da parte di agenti donne della polizia morale nella metropolitana di Teheran”.
Dove è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza che era senza velo.
L’organizzazione ha riferito che l’aggressione è avvenuta perché “secondo la polizia, Garawand non rispettava la regola del velo obbligatorio”. Ha sottolineato che la giovane è stata gravemente ferita e portata all’ospedale Fajr della capitale, dove è stata tenuta sotto sorveglianza di sicurezza e “nessuno, compresa la sua famiglia, ha potuto farle visita”.
Il quotidiano iraniano Sharq ha riferito che la sua giornalista Meryem Lutfi è stata arrestata lunedì mentre visitava l’ospedale Fajr per riferire su Garawand ed è stata successivamente rilasciata.
Garawand, che vive a Teheran, viene da Kermanshah, una città nell’ovest dell’Iran dove la maggioranza della popolazione è curda.
Questo caso ha ricordato Mahsa Amini che 16 settembre del 2022 dopo essere finita in coma per le torture subite dalla polizia morale per una ciocca fuori posto e venuta a mancare.
La morte di Mahsa Amini, a portato a delle manifestazioni in tutto il paese, si sono attivate le organizzazioni dei diritti umani, ed attivisti che accusarono la polizia morale per la morte di Mahsa Amini, mentre le autorità sostenevano che la sua morte fosse a causata dai problemi di salute preesistenti.
Dopo la morte di Mahsa Amini, sono iniziate le manifestazioni nella sua città natale di Sakkiz il 17 settembre 2022, che si sono diffuse in tutto il Paese e si sono trasformate in proteste antigovernative.
Negli eventi durati mesi successivi sono stati uccisi circa 500 manifestanti e più di un centinaio di agenti di polizia hanno perso la vita.
Migliaia di persone che hanno protestato contro la morte di Mahsa Amini e si sono opposte al codice di abbigliamento obbligatorio sono state detenute nel Paese.

IL MODELLO MILANO
di Francesco Maraia
Milano è da tempo conosciuta come la capitale finanziaria del nostro Paese, celebre per la sua influenza nella moda e per la vivace vita notturna, ma anche per la sua nebbia che avvolgeva la città. Eppure questa nebbia si è dissipata, proprio come alcuni pregiudizi contenuti nella mia valigia.
È bastato poco per svelare una Milano molto diversa da quella stereotipata. Inevitabilmente, ho riconosciuto i numerosi valori che sostengono la società milanese, trasformandola in una città europea, forse unica nel suo genere in Italia.
Uno dei valori più evidenti è l’Integrazione Culturale, basata sulla tolleranza delle diverse etnie e delle varie sfere sociali. Nel corso dei secoli, questa città ha assorbito influenze straniere, si è evoluta durante l’esodo dei migranti meridionali ed è giunta alla sua forma più pura nell’odierna società multietnica e multiculturale.
A Milano, l’integrazione culturale è una questione seria. La città non ha subito l’influenza delle politiche divisive o dell’odio, ma ha invece lavorato incessantemente per includere tutti, sfruttando al massimo le energie migliori sotto l’etica del lavoro. Qui, ogni individuo ha l’opportunità concreta di realizzare i propri sogni con impegno e tenacia. Non sorprende sentire storie di successo come quella di un imprenditore edile egiziano, una brillante start-up fondata da un nordafricano o un centro di orientamento per il lavoro creato da un filippino. È perfettamente normale che manager e amministratori delegati parlino con accenti campani, pugliesi o siciliani. Sono tutti qui per contribuire ad una società inclusiva che si basa sul merito. Questa inclusività si riflette nelle scuole del Nord Italia, sempre più multietniche e tolleranti, dove la diversità geografica e culturale è la norma e rappresenta il futuro della società italiana.
Negli anni, ho imparato a considerare Milano come un modello sociologico. La città è un esempio di integrazione culturale e di progresso che tutti dovremmo cercare di emulare. Una città che abbraccia la diversità, celebra il talento e il duro lavoro come chiave per il successo e la crescita di una società inclusiva. Questa è per me Milano, questo è il Modello Milano.
